1/ “Sulle spalle dei giganti” – Ottavo incontro. L’io spezzato e la domanda di assoluto: Luigi Pirandello, di Franco Nembrini 2/ “Sulle spalle dei giganti” – Nono incontro. La rivoluzione del ‘68: un appuntamento mancato? Pier Paolo Pasolini, di Franco Nembrini 3/ “Sulle spalle dei giganti” – Decimo incontro. Guareschi, Buzzati. Il passato è perduto per sempre?, di Franco Nembrini
- Tag usati: dino_buzzati, franco_nembrini, giovannino_guareschi, luigi_pirandello, pier_paolo_pasolini
- Segnala questo articolo:
1/ “Sulle spalle dei giganti” – Ottavo incontro. L’io spezzato e la domanda di assoluto: Luigi Pirandello, di Franco Nembrini
Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione dell’VIII incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 16 febbraio 2018 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura. Per altri testi e audio di Franco Nembrini, e in particolare per l’intero ciclo Sulle spalle dei giganti, clicca sul tag franco_nembrini.
Il Centro culturale Gli scritti (1/7/2018)

Franco: Buona sera a tutti. Le nostre serate diventano sempre più impegnative, spero siate pronti. Leggerò molto, e vi sono molto grato per questo perché mi costringete a prendere in mano testi che ho frequentato per tanti anni mentre insegnavo, ma era da tempo che non li toccavo più. Lo spirito, ha detto don Fabio, parla attraverso i grandi geni e i grandi profeti. La parola poeta è compresa nella parola profeta, vi ho fatto notare tante volte, e mi ha sempre stupito vedere che è proprio vero, lo Spirito Santo fa davvero quello che vuole.
Riparto dal punto esatto in cui ci siamo lasciati la volta scorsa: abbiamo visto nel Positivismo della seconda metà dell’800, nel tentativo del Verismo, di Verga in particolare, la pretesa moderna di conoscere la verità. Perché tutto il problema è questo: se si possa crescere nella certezza del senso buono delle cose. Cosa vuol dire maturare nella vita una certezza in ordine al bene, al destino nostro e di tutta l’umanità. Abbiamo visto la parabola della modernità arrivare fino a questo momento che ho descritto in modo un po’ rozzo, ma molto interessante: la pretesa dell’uomo moderno di poter conoscere la verità nella sua oggettività.
C’è un ultimo punto che la volta scorsa ho omesso, lo riprendo adesso: l’aspetto finale della parabola del Verismo, il suo fallimento. Nel senso che parte della critica ha fatto notare che l’ultima raccolta di novelle di Verga, che si chiama “Don Candeloro e C.i” è molto interessante perché è proprio una sconfessione di quella pretesa, tant’è che i protagonisti di quest’ultima raccolta sono una famiglia di teatranti che gira con il suo carrozzone a rappresentare delle storie, facendo teatro girovago. Questo è interessante perché stabilisce un nesso immediato con Pirandello. Il sugo già di questa raccolta di Verga è: la vita in fondo è una finzione, della realtà, della vita, della verità non possiamo conoscere nulla, siamo tutti in qualche modo maschere o burattini, questo è il cinismo con cui Verga conclude la sua riflessione. Siamo tutti maschere, è tutta una grottesca finzione la vita, una finzione che ci vede ultimamente schiavi, servi inconsapevoli del potere. E che profezia è anche questa se pensate al modo in cui gli strumenti del potere, oggi, sono in grado di entrare nelle coscienze! Oggi è veramente possibile una violenza non armata, ma mai così pervasiva della vita del singolo, di tutti.
Una grottesca finzione la vita, schiavi del potere, dove addirittura la religione svela tutta la sua falsità. La metà delle novelle di “Don Candeloro e C.i” racconta di figure di sacerdoti, più frequentemente di conventi di suore, dove è evidente che quella stessa dinamica che si vorrebbe vinta dalla religione è invece il carattere distintivo anche dei rapporti dentro una comunità monastica. Quindi, se non ve l’ho dimostrato abbastanza la volta scorsa, quell’aspetto di impossibilità del verismo, andatevi a leggere quest’ultima raccolta di novelle e vedrete.
Siamo ora nella prima metà del ‘900 con Pirandello. Questo tema della maschera, della finzione ricorre spessissimo, è proprio la parola chiave. Ma in una riflessione così acuta e così realista che fa venire veramente i brividi, perciò il pessimismo forse non è la caratteristica del nostro Leopardi, ma di tutto quello che è venuto dopo, lo dico sempre. Perché sfocia in una lucida descrizione della vita alla fine come follia, come pazzia, che in casa Pirandello è una presenza determinante.
La moglie impazzisce ed è ricoverata in un ospedale psichiatrico. Pirandello ha a che fare con la pazzia direttamente e tragicamente e diventa la cifra della sua riflessione. Per aiutarci in una produzione sterminata come la sua, evidentemente noi stasera possiamo prendere solo due o tre parole e provare a metterle a fuoco, portare a casa le due o tre parole che mi sembrano contenere e descrivere in qualche modo i passaggi fondamentali del suo percorso, della sua riflessione.
Si potrebbe, per fare le connessioni con quello che abbiamo detto negli incontri precedenti, rileggere velocemente “L’orgoglio punito” di Baudelaire, dove lui tratteggia la tragedia che verrà, descrivendo la parabola di un uomo che, illusosi di poter fare a meno di Dio, finisce senza volerlo all’inferno.
Ai tempi meravigliosi che la Teologia
fioriva con più linfa e con più energia,
si narra che un giorno uno fra i dottori più valenti –
dopo aver forzato tanti cuori indifferenti;
averli smossi nel fondo dei loro neri meandri,
dopo aver superato verso le glorie sante
strani sentieri da lui stesso ignorati,
dove solo i puri Spiriti erano forse passati
come chi sia salito troppo in alto, dal panico
afferrato gridò, in preda a un orgoglio satanico:
«Gesù, piccolo Gesù, t’ho spinto in alto davvero!
Ma se avessi voluto attaccarti nel punto più debole,
la tua vergogna sarebbe pari alla tua gloria
e non saresti più che un feto derisorio!
La presunzione moderna, appunto, ubriaca della sua stessa saggezza, ubriaca del suo potere, l’abbiamo descritto la volta scorsa, subisce la stessa tentazione che fu di Lucifero, che fu dei primi, sostituirsi a Dio. Ma questo è il risultato: “immediatamente se ne andò la sua ragione”.
Immediatamente se ne andò la sua ragione.
Un velo nero offuscò lo splendore di quel sole;
tutto il caos si rovesciò in quella intelligenza,
tempio vivo, ripieno d’ordine e d’opulenza,
la cui volta aveva visto brillare tanto sfarzo.
S’installarono in lui la notte ed il silenzio,
come in una cantina di cui s’è persa la chiave.
Da quel giorno fu simile alle bestie randagie,
e quando se ne andava senza nulla vedere,
nei campi, senza distinguere le estati dagl’inverni,
sporco, inutile e laido come cosa da buttar via,
dei fanciulli faceva il trastullo e l’allegria.
Questa profezia di Baudelaire che ho voluto mettere all’inizio di questo nostro percorso sulla modernità, sintetizza in qualche modo quel che Pirandello ci descriverà stasera. Se non c’è un punto di verità, “se Dio non esiste tutto è possibile” diceva Dostoevskji. Se non c’è una verità oggettiva fuori di me, cioè se Dio non esiste, vale tutto e il contrario di tutto. Non c’è più né bene né male, né sopra né sotto, né destra né sinistra, né menzogna né verità, non c’è più niente.
Allora per entrare proprio a gamba tesa nel modo in cui Pirandello ci getta in faccia questo dramma della Verità, di sapere semplicemente se le cose stanno insieme, se hanno un senso, vi leggo alcune tra le pagine che amo di più, in particolare l’inizio di un romanzo poco letto “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”.
Tenete presente che l’onomastica in Pirandello è sempre importantissima. “Serafino Gubbio” è il rovesciamento di San Francesco: “serafico in ardore” nella Divina Commedia, “Gubbio” è evidente. Che fa anche rima con “dubbio”. È proprio il rovesciamento di quella certezza che faceva dire a San Francesco, 800 anni prima, che tutto si lega, tutto ha senso, perfino il filo d’erba, perché tutto è uno nel cuore e nella sapienza di Dio. Bisogna dire prima una cosa, che si dimentica sempre quando si parla di San Francesco come l’antesignano del wwf, come il patrono dei movimenti ecologici, che per innamorarsi dell’erba, del sole e della luna, bisogna prima dire “Altissimo, onnipotente bon Signore, tue son le laude, et la gloria, et l’onore et honne benedictione”. Allora un filo d’erba è salvo, altrimenti non sta insieme niente.
Serafino Gubbio sta davanti alla realtà in quel modo che aveva detto Verga. Cosa fa di mestiere? L’operatore. Siamo negli anni della nascita del cinema e lui è quello che gira la manovella: il titolo originale dell’opera era “Si gira!”, pubblicato a puntate. Poi è diventato, quando è stato pubblicato in volume, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”. Sentite:
Studio la gente nelle sue più ordinarie occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa ch’io faccia: la certezza che capiscano ciò che fanno.
In prima, sì, mi sembra che molti l’abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, correndo di qua, di là, dietro alle loro faccende o ai loro capricci. Ma poi, se mi fermo a guardarli un po’ addentro negli occhi con questi miei occhi intenti e silenziosi, ecco che subito s’aombrano. Taluni anzi si smarriscono in una perplessità così inquieta, che se per poco io seguitassi a scrutarli, m’ingiurierebbero o m’aggredirebbero.
Perché questo sguardo è quello di chi, se non ha la verità, almeno la cerca. E quando ti guarda negli occhi uno che cerca la verità tu, se non cerchi la verità, sei a disagio, quello sguardo ti infastidisce. Quando si dice che un santo ti guarda negli occhi e ti costringe ad abbassare lo sguardo, perché non lo reggi, è perché la verità funziona così, la verità giudica. Se sei sotto lo sguardo della verità un po’ di movimento dentro ce l’hai. Quando la Girolama del Miguel Manara, che vi ho raccomandato tante volte di leggere, una ragazzina di sedici anni che dice al cavaliere che ne ha fatte di cotte e di crude “io non temo il vostro sguardo su di me” per tre volte, descrive questo.
No, via, tranquilli. Mi basta questo: sapere, signori, che non è chiaro né certo neanche a voi neppur quel poco che vi viene a mano a mano determinato dalle consuetissime condizioni in cui vivete.
Ci dice Pirandello: “tranquilli, lo so che siete anche voi nel casino come me” perché c’è un oltre in tutto. Montale avrebbe detto: “Tutte le cose portano scritto ‘più in là'”. Dante avrebbe detto più radicalmente: “Tutto è segno di qualcosa d’altro. “C’è un oltre in tutto”, dice Pirandello:
Voi non volete o non sapete vederlo. Ma appena appena quest’oltre baleni negli occhi d’un ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate.
Conosco anch’io il congegno esterno, vorrei dir meccanico della vita che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi, così e così; questo e quest’altro da fare; correre qua, con l’orologio alla mano, per essere in tempo là. – No, caro, grazie: non posso! – Ah sì, davvero? Beato te! Debbo scappare… – Alle undici, la colazione. – Il giornale, la borsa, l’ufficio, la scuola… – Bel tempo, peccato! Ma gli affari… – Chi passa? Ah, un carro funebre… Un saluto, di corsa, a chi se n’è andato. – La bottega, la fabbrica, il tribunale…
Nessuno ha tempo o modo d’arrestarsi un momento a considerare, se quel che vede fare agli altri, quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che sopra tutto gli convenga, ciò che gli possa dare quella certezza vera, nella quale solamente potrebbe trovar riposo. Il riposo che ci è dato dopo tanto fragore e tanta vertigine è gravato da tale stanchezza, intronato da tanto stordimento, che non ci è più possibile raccoglierci un minuto a pensare. Con una mano ci teniamo la testa, con l’altra facciamo un gesto da ubriachi.
– Svaghiamoci!
Sì. Più faticosi e complicati del lavoro troviamo gli svaghi che ci si offrono; sicché dal riposo non otteniamo altro che un accrescimento di stanchezza.
Guardo per via le donne, come vestono, come camminano, i cappelli che portano in capo; gli uomini, le arie che hanno o che si dànno, ne ascolto i discorsi, i propositi; e in certi momenti mi sembra così impossibile credere alla realtà di quanto vedo e sento, che non potendo d’altra parte credere che tutti facciano per ischerzo, mi domando se veramente tutto questo fragoroso e vertiginoso meccanismo della vita, che di giorno in giorno sempre più si còmplica e s’accèlera, non abbia ridotto l’umanità in tale stato di follia, che presto proromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere tutto. Sarebbe forse, in fin de’ conti, tanto di guadagnato. Non per altro, badiamo: per fare una volta tanto punto e daccapo.
Quest’espressione vi prego di segnarla perché mi sembra una delle due o tre parole che in Pirandello sono decisive. Perché il problema che abbiamo nella vita è che c’è una scontentezza rispetto alla vita stessa che sembra crescere con il tempo e con gli anni. E così un vecchietto che, senza dirlo al bar, di notte va a bussare alla porta di Gesù a chiedergli: “si potrebbe fare punto e a capo? Si potrebbe ricominciare? Si può rinascere di nuovo?”. Alla risposta di Gesù “Sì” rimane un po’ tramortito e incredulo chiede: “Ma posso forse rientrare nel ventre di mia madre?” e Gesù gli dice: “No, ma quello che è impossibile agli uomini è possibile allo Spirito”.
Tutto il tema di Pirandello secondo me è questo: “Si può rinascere di nuovo? Si può provare a ricominciare?” Poi leggeremo qualche riga del grandissimo romanzo che è “Il fu Mattia Pascal” che è il racconto, con un’invenzione artistica geniale, di un uomo che ha la possibilità di ricominciare daccapo. Dopo ve lo racconto in breve.
Qua da noi non siamo ancora arrivati ad assistere allo spettacolo, che dicono frequente in America, di uomini che a mezzo d’una qualche faccenda, fra il tumulto della vita, traboccano giù, fulminati. Ma forse, Dio ajutando, ci arriveremo presto. So che tante cose si preparano. Ah, si lavora! E io – modestamente – sono uno degli impiegati a questi lavori per lo svago.
In questo senso vi dicevo che questi, che sono stati accusati dal progressismo positivista di essere degli sfigati, dei malati, dei disadattati, sono invece i primi grandi profeti che sulla modernità hanno detto il vero. Per esempio sul fatto di identificare il progresso scientifico, tecnologico, con il progresso tout-court dell’uomo è assurdo. Chi l’ha detto che scoprire l’energia nucleare, che è evidentemente un progresso, abbia voluto dire un progresso dell’umanità in quanto tale? Andate a chiederlo a Nagasaki. Si capisce? Ma agli inizi del ‘900 riuscire a dire così non era scontato.
L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di esse.
Viva la Macchina che meccanizza la vita!
Vi resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare.
Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?
È per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni. […]
Non dico di no: l’apparenza è lieve e vivace. Si va, si vola. E il vento della corsa dà un’ansia vigile ilare acuta, e si porta via tutti i pensieri. Avanti! Avanti perché non s’abbia tempo né modo d’avvertire il peso della tristezza, l’avvilimento della vergogna, che restano dentro, in fondo. Fuori, è un balenìo continuo, uno sbarbàglio incessante: tutto guizza e scompare.
Che cos’è? Niente, è passato! Era forse una cosa triste; ma niente, ora è passata.
C’è una molestia, però, che non passa. La sentite? Un calabrone che ronza sempre, cupo, fosco, brusco, sotto sotto, sempre. Che è? Il ronzìo dei pali telegrafici? lo striscìo continuo della carrùcola lungo il filo dei tram elettrici? il fremito incalzante di tante macchine, vicine, lontane? quello del motore dell’automobile? quello dell’apparecchio cinematografico?
Il bàttito del cuore non s’avverte, non s’avverte il pulsar delle arterie. Guaj, se s’avvertisse! Ma questo ronzìo, questo ticchettìo perpetuo, sì, e dice che non è naturale tutta questa furia turbinosa, tutto questo guizzare e scomparire d’immagini; ma che c’è sotto un meccanismo, il quale pare lo insegua, stridendo precipitosamente.
Si spezzerà?
Ah, non bisogna fissarci l’udito. Darebbe una smania di punto in punto crescente, un’esasperazione a lungo insopportabile; farebbe impazzire.
Ascoltare il nostro cuore ci farebbe impazzire, dice lui. Se non esiste Dio è così, si può solo far di tutto per dimenticare di averne bisogno.
In nulla, più in nulla, in mezzo a questo tramenìo vertiginoso, che investe e travolge, bisognerebbe fissarsi. Cogliere, attimo per attimo, questo rapido passaggio d’aspetti e di casi, e via, fino al punto che il ronzìo per ciascuno di noi non cesserà.
Poi, nel dialogo con un amico, è messa a tema proprio la questione delle cose. Le cose esistono davvero o esistono solo perché ce le abbiamo in testa noi? E se esistono le conosciamo davvero? Sono letture pericolose, io a 17 anni ci sono impazzito su queste pagine e se a 17 anni prendi sul serio “Uno, nessuno, centomila” di Pirandello ti butti sotto un treno. Bisogna avere una certa delicatezza. Però tra noi che sappiamo che la risposta c’è, si può dire! Non si possono dire cose così sconsideratamente a chi questa debolezza la vive. Ai giovani di oggi la dici, ma spiegandogli che è tutto così vero che va letto, ma che c’è una speranza, se no è meglio non leggerle queste cose.
Scusa, e come so io del monte, dell’albero, del mare? Il monte è monte, perché io dico: Quello è un monte. Il che significa: io sono il monte. Che siamo noi? Siamo quello di cui a volta a volta ci accorgiamo. Io sono il monte, io l’albero, io il mare. Io sono anche la stella, che ignora se stessa!
Restai sbalordito. Ma per poco. Ho anch’io – inestirpabilmente radicata nel più profondo del mio essere – la stessa malattia dell’amico mio.
La quale, a mio credere, dimostra nel modo più chiaro, che tutto quello che avviene, forse avviene perché la terra non è fatta tanto per gli uomini, quanto per le bestie.
Segue questa breve paginetta, che ricorda tante delle nostre più belle opere di letteratura - finiscono tutte così! Com’è bello studiare queste cose per poter tornare sempre sulla tua vita e sul senso che le dai. Gira e rigira, a profondità diverse, da punti di vista diversi, in contesti diversi, la grande letteratura ha a tema il tuo cuore, sempre.
Allora uno quando sente dire che quello è un monte perché io lo chiamo monte, pensa subito all’inizio, al nominalismo, al dubbio che, nato in una corrente filosofica nel Medioevo, pone il dubbio che noi non possiamo conoscere davvero le cose. Andate a rivedervi la spiegazione che diedi l’anno scorso del “Nome della Rosa” di Umberto Eco, che ne costituisce la versione più moderna e intelligente.
Il nominalismo dice che in realtà noi non possiamo conoscere né noi stessi né gli altri né Dio. O meglio, siccome Dio non esiste, è un puro nome, in realtà di tutto sappiamo solo il nome. Continua Pirandello:
Perché le bestie hanno in sé da natura solo quel tanto che loro basta ed è necessario per vivere nelle condizioni, a cui furono, ciascuna secondo la propria specie, ordinate; laddove gli uomini hanno in sé un superfluo…
Altra parola importantissima in Pirandello. Per “superfluo” intende quell'”oltre” misterioso che caratterizza appunto la vita dell’uomo rispetto a quella degli animali. Termine che vorrebbe essere negativo ma che noi sentiamo religioso. Il superfluo è quel che non serve alla vita materiale, ma che serve all’uomo per vivere. Dico sempre che mio padre non sapeva l’inglese, l’informatica, la chimica e la matematica, ma viveva bene, perché sapeva del bene e del male, del dolore e della gioia, della vita e della morte. Sono queste le cose senza le quali non si può vivere. Lui qui chiama superfluo questa tensione alla verità, al bene e alla bellezza che gli animali non hanno.
…un superfluo, che di continuo inutilmente li tormenta, non facendoli mai paghi di nessuna condizione e sempre lasciandoli incerti del loro destino. Superfluo inesplicabile, chi per darsi uno sfogo crea nella natura un mondo fittizio, che ha senso e valore soltanto per essi, ma di cui pur essi medesimi non sanno e non possono mai contentarsi, cosicché senza posa smaniosamente lo mutano e rimutano…
La parola “posa”, a me che un po’ ho il gusto della parola, non può che ricordarmi “girando senza posa per tornar sempre la donde son mosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so”, il “Canto Notturno” di Leopardi.
… mutano e rimutano, come quello che, essendo da loro stessi costruito per il bisogno di spiegare e sfogare un’attività di cui non si vede né il fine né la ragione, accresce e còmplica sempre più il loro tormento, allontanandoli da quelle semplici condizioni poste da natura alla vita su la terra, alle quali soltanto i bruti sanno restar fedeli e obbedienti.
Siamo di fronte veramente a due mondi. Oggi il cristiano deve scegliere non tra i riti, andare o non andare in chiesa, ma come usare la testa. Sono due mondi. Uno che dice: “fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza”, “è la cosa più grande che avete, avventuratevi fiduciosi verso la verità perché c’è. E anche conoscere tutto il male e la debolezza di cui siete fatti è il primo passo verso una verità sicura e certa”. Così che anche l’Inferno può chiudersi con la parola “stelle”. C’è un modo invece diverso, pieno di desiderio grande e magnanimo, per esempio in Leopardi. Il quale quando dice “guarda le bestie, certo, a volte mi viene da dire che sono beate per non avere questo tormento addosso!”.
O greggia mia che posi, oh te beata,
Che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
Quasi libera vai;
Ch’ogni stento, ogni danno,
Ogni estremo timor subito scordi;
Ma più perché giammai tedio non provi.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
E un fastidio m’ingombra
La mente, ed uno spron quasi mi punge
Sì che, sedendo, più che mai son lunge
Da trovar pace o loco.
“Provo anche io a fare la bestia, ma non c’è verso!” Quel desiderio ineffabile di grandezza mi tormenta e non mi lascia mai ed è proprio la cifra che mi distingue dalle bestie. Prosegue Pirandello:
Sono anch’io convinto ch’egli valga molto più d’un bruto, ma non per queste ragioni. Che giova all’uomo non contentarsi di ripeter sempre le stesse operazioni? Già, quelle che sono fondamentali e indispensabili alla vita, deve pur compierle e ripeterle anch’egli quotidianamente, come i bruti, se non vuol morire. Tutte le altre, mutate e rimutate di continuo smaniosamente, è assai difficile non gli si scoprano, presto o tardi, illusioni o vanità…
Leopardi resta sulla soglia di quella grande domanda di cosa sarà questa cosa che gli fa intuire un infinito per cui è fatto, per cui non riuscirebbe ad accontentarsi anche se possedesse il mondo intero, evangelicamente parlando. Pensate anche solo al “Pensiero LXVIII” dove il desiderio può essere riempito solo dall’infinito e dall’eterno.
Pirandello invece, insieme alla modernità, fa un passo in più. Non riescono a stare di fronte a questa esigenza e semplicemente a riconoscerla come una grandezza, la grandezza dell’uomo. Finiscono la parabola, la chiudono dicendo che allora è tutta una presa in giro. Ci attaccano la risposta che l’uomo può dare quando, eliminato Dio, gli resta in mano l’esigenza del bene che non è però più reperibile, non è più possibile.
…il bruto non ha in sé alcun superfluo. L’uomo che l’ha, appunto perché l’ha, si pone il tormento di certi problemi, destinati su la terra a rimanere insolubili.
Ma chi te l’ha detto? Perché devi chiudere? Leopardi fu più onesto. Diceva Kafka: “Non credo che la salvezza verrà ma voglio esserne degno in ogni momento”. Questa è anche la grandezza di Leopardi.
Ed ecco in che consiste la sua superiorità! Forse quel tormento è segno e prova (speriamo, non anche caparra!) di un’altra vita oltre la terrena; ma, stando così le cose su la terra, mi par proprio d’aver ragione quando dico ch’essa è fatta più pe’ bruti che per gli uomini.
Non vorrei esser frainteso. Intendo dire, che su la terra l’uomo è destinato a star male, perché ha in sé più di quanto basta per starci bene, cioè in pace e pago. E che sia veramente un di più, per la terra, questo che l’uomo ha in sé (e per cui è uomo e non bruto), lo dimostra il fatto, ch’esso – questo di più – non riesce a quietarsi mai in nulla, né di nulla ad appagarsi quaggiù, tanto che cerca e chiede altrove, oltre la vita terrena, il perché e il compenso del suo tormento.
Ma lo dice non come attesa di una possibile verità, ma come rifugio fantastico di un uomo che quella verità sa che non c’è, è tutto diverso.
L’altra opera decisiva, per quel che conosco io, è “Il fu Mattia Pascal”, di cui vi leggo qualche pezzo. Per la ragione che ho detto prima. Questo romanzo è il disperato tentativo, e la descrizione comunque meravigliosa, di uno che dice che la vita fa schifo e che ha il sogno di rifare tutto. Il sogno che abbiamo tutti peraltro, perché tutti in qualche modo accusiamo le circostanze di esserci contro. E perciò se capita il dolore, se c’è da far fatica, se sperimentiamo il limite o la debolezza, ci sembra un’obiezione a Dio, quando invece è esattamente il contrario. Perché l’esperienza della debolezza, la tristezza e la fatica, il dolore e perfino la morte non sono altro che il modo con cui Dio ci chiama a sé. Non c’è circostanza che non sia fattore della tua vocazione. E pensare che cambiare le circostanze faciliti la vita è un’ingenuità terribile. L’ho sempre detto ai ragazzi, che essendo in qualche modo in un’età in cui certe decisioni potrebbero cambiare le circostanze, aspettano solo di andar via di casa. Devono decidere dove andare a lavorare, dove vivere, che donna sposare, dove far famiglia. Hanno l’illusione effettivamente di poter determinare loro stessi circostanze più favorevoli alla vita. Non sanno cosa li aspetta. E allora devi dirgli: “Guarda che se non ami questa circostanza in cui sei, tu la noia mortale che ti affligge, te la porterai dietro in tutte le circostanze. Non è che perché vai in India a fare arti marziali liberandoti di tutte le circostanze, buttando a mare tutto pensando di rifarti una vita hai risolto il problema”. È il “surfismo della vita”, come mi piace chiamarlo, come Ulisse, che fa il surfista della vita. Dante invece prende il punto dove si trova e scende. Va nel profondo di quel che gli è dato da vivere. Per questo Ulisse fallisce. Arrivano allo stesso punto ma Ulisse affonda e Dante invece ce la fa. Perché uno sta nel punto della circostanza in cui Dio l’ha messo e lì cerca l’eterno, l’altro pensa che la circostanza sia sbagliata, gli sia contro, e va a cercare quella giusta.
E allora ai ragazzi bisogna dire: “Guarda che se non ami questa circostanza che Dio ti ha dato non amerai mai niente, perché dopo sei mesi che hai sposato la tua donna ti verrà il dubbio che sia quella giusta, e ti verrà l’illusione che cambiarla e cambiarne tante possa risolvere il problema dell’amore vero.”
Tutto il romanzo “Il fu Mattia Pascal” è costruito su questa idea. Pensate che trovata, per chi non sa la trama faccio una breve sintesi. C’è un uomo che proprio non ne può più, è ucciso dalla noia. Fa il bibliotecario in un posto impossibile dove non gli interessa leggere nemmeno un libro. Un mestiere inutile, fermo, polveroso, immobile. Mi ricorda la frase che mi disse quella volta un ragazzo in Ucraina: “Va tutto bene. La tragedia è che non succede niente”. Perché è di questo che l’uomo ha bisogno per vivere: una novità. Che la vita rinasca sempre.
Insomma, questo signore fa una vita d’inferno, ha una moglie insopportabile, da cui gli nascono due bambine che descrive in modo terrificante, come due gattini che si graffiano e si ammazzano continuamente. Una vita dove davvero le circostanze sono odiabili. Gli succede che durante un viaggio ad un certo punto va a giocare al Casinò, vince un sacco di soldi e vuol tornare a casa per vendicarsi delle circostanze. Ma sul treno, apre il giornale, e legge che è morto. Per un equivoco hanno trovato in un canale un cadavere in avanzato stato di decomposizione e hanno pensato che fosse lui. Quindi viene dichiarato morto, sepolto secondo tutte le regole. E di colpo capisce che ha la possibilità di rinascere: una nuova identità, una nuova vita, la moglie lo pensa morto. Inizia a ricostruirsi una vita, assumendo il nome di Adriano, cioè si ricomincia con la A. E incontra addirittura, quando arriva a Roma, quella che sembra essere l’anima gemella, tale Adriana appunto, l’altra metà di cui sempre ha avuto bisogno per essere felice.
“Mattia ritorna al lavoro in biblioteca, in una oppressione intollerabile, una immobilità e perciò rabbia e schifo di vivere”. Questa noia gli ritorna continuamente, per vincerla fa un viaggio a Nizza, ma legge della possibilità di vincere alla roulette e vince effettivamente una somma enorme. E sul treno, come vi dicevo legge la notizia della sua morte.
Ero solo ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente d’ogni legame e d’ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato, e con l’avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio.
Ah, un pajo d’ali! Come mi sentivo leggero!
Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal.
Stava a me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo destino…
Lo sentite? Nuovo, qualcosa di nuovo, finalmente si può ricominciare! Si può fare punto e a capo. E cosa fa prima di tutto? Va dal barbiere e si cambia i connotati. Perché uno quando rifiuta le circostanze in realtà rifiuta se stesso e quel mascheramento continuo che è il tatuaggio per esempio, per il quale tutti mi rimproverano di non capire che è un nuovo linguaggio, che esprime un’identità, è falso. Tant’è vero che, dice il testo “era già brutto prima, uscì dal negozio che era un mostro”.
Ci sono pagine di riflessione su questa questione della sua immagine. Si guarda intorno, osserva il mondo, con l’aria comunque di esserne ormai padrone, e la domanda però che gli viene, a proposito appunto del progresso, è: “Perché tutto questo stordimento di macchine? Che farà l’uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il cosiddetto progresso non ha niente a che fare con la felicità?” E come è vero! Come è vero oggi, pensando che sono cose dette 120 anni fa. Perché, da un certo punto di vista, il progresso che vedevano loro un pochino con la felicità ci aveva a che fare, perché se invece che vivere con le candele potevi con un bottone fare arrivare la luce era uno star bene davvero. E se c’era da mangiare per tutti invece che fare la fame, era meglio.
Questi poeti hanno intravisto profeticamente quella tristezza infinita del progresso di oggi. Ma quel che vedevano giustificava invece l’idea che il progresso tecnologico rendesse un po’ più felici gli uomini. Potevano aver vissuto questa illusione, come hanno fatto a vedere che non era vero? Vedevano la medicina curare malattie che una volta erano pestilenziali, e si viveva meglio. Loro vedevano un progresso che davvero avvicinava un po’ l’uomo alla felicità, ma i profeti sono andati più in là e hanno visto che invece non era così, che la fonte vera della felicità è un’altra. Ha un’altra sorgente la felicità degli uomini.
Il nostro Mattia arriva addirittura in Piazza san Pietro, decide di andare a vivere a Roma e fa impressione perché c’è una pagina dove lui, di fronte alla maestosità della Basilica è come se si avvicinasse un pochino all’idea giusta, che forse c’è qualcosa che ci abbraccia davvero.
Ricordo, una notte, in piazza San Pietro, l’impressione di sogno, d’un sogno quasi lontano, ch’io m’ebbi da quel mondo secolare, racchiuso lì, tra le braccia del portico maestoso, nel silenzio che pareva accresciuto dal continuo fragore delle due fontane. M’accostai a una d’esse, e allora quell’acqua soltanto mi sembrò viva, lì, e tutto il resto quasi spettrale e profondamente malinconico nella silenziosa, immota solennità.
Quante volte andiamo in chiesa per abitudine o registrando il fascino di una solennità che ormai è solo formale. C’è, ed è un’adesione anche affettivamente significativa: ma a che cosa? Alla solennità di un passato, che perciò genera malinconia, e perciò tristezza, non la grandezza di una presenza viva. La Chiesa ridotta, nostalgicamente, a ciò che di grande fu, a ciò che di grande rappresentò. Per cui si va a San Pietro, si fanno gli anni santi, i pellegrinaggi, ma come per sostenere una nostalgia che è debole, perché poggia sul passato e ha bisogno di rinverdirlo costantemente. Quant’è diverso invece accostarsi alla Chiesa come luogo di una presenza viva e vera.
Mattia incontra questa Adriana, A.A. l’altra metà, che è una ragazza religiosissima invece, che di nascosto gli riempie l’acquasantiera sul comodino che lui prende per un posacenere e ci spegne i mozziconi.
Mi voleva dunque santo quella minuscola mammina, se al fonte di San Rocco aveva attinto l’acqua benedetta anche per la mia acquasantiera?
Non sarà un caso, vero? Vi ricorda qualcosa San Rocco? La chiesa dove si è convertito Manzoni il quale racconta della propria conversione quando, probabilmente, colpito da un attacco di agorafobia, si rifugia nella chiesa di San Rocco per respirare.
La ragazza, Adriana, cerca di convertirlo andando ad attingere alla chiesa di San Rocco, quindi l’autore crea un parallelo con una possibile conversione, che però non avverrà. E non avverrà perché se Dio non c’è, l’amore è impossibile. Quel che fu possibile per quel matrimonio, che era partito male - “questo matrimonio non s’ha da fare, né oggi né mai” -, ma che si conclude bene perché c’è di mezzo una Beatrice, una Lucia, non lo è qui. Non può finire bene, perché è negata la condizione previa del cristianesimo. È tutto falso, e quindi la prima cosa che si rivela falsa è l’amore tra l’uomo e la donna. Non fosse altro perché lui deve andare con dei documenti, lui documenti non ne ha, la finzione viene a galla, e il sogno di fare punto e a capo muore in una parabola terribile che finisce con “Il fu Mattia Pascal”. Anche il nome, l’avrete capito, Pascal è il nome del grande filosofo cristiano che aveva scommesso sull’esistenza di Dio, Mattia che richiama le parole “matto” e “pazzia”: come a dire che scommettere su Dio è un fallimento, conduce solo alla follia, Dio non esiste.
“Il fu Mattia Pascal”: non sono più neanche presente a me stesso. Resta di me soltanto la forma che fu, la sostanza è persa. Era persa prima, è persa oggi, sarà persa domani. Non esiste possibilità di dare sostanza all’essere, alla propria persona. E mi viene in mente: se il problema della vita è una novità, è che rinasca, cosa vuol dire essere cristiani e prendere sul serio la frase “ecco, io faccio nuove tutte le cose”? Pensate cosa vuol dire un poema come la Divina Commedia in cui il Purgatorio, che in qualche modo è la vita su questa terra, perché è un cammino vero, dove c’è il giorno e la notte, la montagna, non si è nella fissità dell’Inferno o del Paradiso, di cui gli ultimi quattro versi sono “io ritornai dalla santissima onda / rifatto sì come piante novelle / rinnovellate da novella fronda”. In tre versi la parola “nuovo”, “puro e disposto a salire alle stelle”. Capite che è veramente cambiato il mondo? E se una risposta la modernità, così tragicamente e lucidamente consapevole del dramma che vive, se una risposta la avrà, sarà solo da cristiani che la intercettano. Ma la intercettano perché la vivono, non è veramente più tempo di arroccarsi in difesa della Chiesa, dei nostri valori, delle nostre cose. Quel mondo lì non c’è più. Adesso c’è il cuore dell’uomo ferito che sanguina nelle sue punte più acute, più profetiche, anche lontanissime dalla Chiesa, nemiche della Chiesa. Cosa c’entra? Anche Gesù non aveva mica tanti amici. Ci vogliono cristiani che sentano quel grido. Ma lo sentono se lo vivono. O cominciamo noi ad essere come Dante, a sentire nostro questo cammino, o non ce la faremo.
Grazie, alla prossima.
2/ “Sulle spalle dei giganti” – Nono incontro. La rivoluzione del ‘68: un appuntamento mancato? Pier Paolo Pasolini, di Franco Nembrini
Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione del IX incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 2 marzo 2018 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura. Per altri testi e audio di Franco Nembrini, e in particolare per l’intero ciclo Sulle spalle dei giganti, clicca sul tag franco_nembrini.
Il Centro culturale Gli scritti (1/7/2018)

Franco: Stasera è una serata particolarmente difficile. Lo erano anche le altre, ma questa è stata davvero difficile da preparare perché parlare di Pasolini, del ’68, è parlare di un periodo in cui io c’ero, e molti tra voi c’erano e quindi probabilmente tutte le cose che dirò stasera, più delle altre volte, sono opinabili, discutibili perché ognuno avrà il proprio vissuto e una propria storia. Io mi avventuro in una specie di racconto di quegli anni che ritrovi in Pasolini una sintesi della cultura di quegli anni per cercare di capire cosa è accaduto. Dall’altra parte vorrei riprendere la traccia da cui siamo partiti l’anno scorso, seguendo la chiave di lettura de “La coscienza religiosa dell’uomo moderno”. Cioè un tentativo di don Giussani di leggere e di capire la storia spirituale dell’Europa a partire dal Medioevo.
Nel riferire questo percorso userò dei testi di Pasolini raccontando anche quel che ho visto io. Ci sono degli episodi di quegli anni che hanno determinato molto di me e del sentimento che poi ho maturato nel tempo rispetto alla politica, rispetto alla società.
Far questo lavoro è difficilissimo, sintetizzare un momento come quello è davvero un’impresa.
Cercando di essere ordinato riparto da dove siamo partiti quest’anno. Non so chi c’era di voi quando ho presentato Leopardi. Ripartiamo da lì perché quel che ho tentato di dire di Leopardi mi sembra che sia la cifra di tutto quello che diremo stasera e che ci aiuta a mettere a fuoco l’idea fondamentale di stasera senza poi perderci in tanti spunti che dovrò comunque cercare di dare. Dico questo partendo dalla poesia di Leopardi “Alla sua donna” che ha sempre colpito me - aiutato a capirla da don Giussani - perché rappresenta il vertice del sentimento profondo della vita che Leopardi ha e della domanda più radicale che tutta la sua vita e tutta la sua opera propongono alla sua epoca e alla nostra e a me sembra veramente un’ipotesi, una chiave di lettura interessantissima.
Questa poesia dice che l’uomo è fatto per una cosa grande, di un desiderio nel cuore dell’uomo che in questa poesia arriva perfino ad essere definito come contenuto in termini assolutamente chiari. “Bisognerebbe che ci fosse il cristianesimo” dice Leopardi. “Sarebbe veramente bello e forse sarebbe il termine vero della felicità che l’uomo cerca se Dio, invece che starsene sulla luna o da qualche altra parte, inconosciuto e inconoscibile, sarebbe veramente bello che Dio accettasse di sporcarsi le mani con la nostra vita, accettasse di farsi carne insieme a noi per esserci davvero compagno. Ma questo non è possibile”.
Impressionante perché 1800 anni dopo l’avventura di Cristo su questa terra un uomo geniale esprime il desiderio che ciò che è già accaduto avvenga, e lo ritiene impossibile. In fondo tutta la modernità e i grandi della modernità, benché poi esteriormente nemici della Chiesa, come fu Leopardi del resto, dal punto di vista del pensiero e della filosofia, in realtà esprimono tutti questo dramma che fa soffrire, leggendo certe pagine, perché ci si chiede: “Come fa? Perché un italiano, in una società e in una terra imbevuta di cristianesimo invoca Cristo venturo e non lo riconosce presente, presente nella storia che ci ha portato fin qui?”
“Quale terribile dimenticanza, quale terribile negazione, cosa è accaduto?” era la domanda da cui siamo partiti l’anno scorso. Cosa è accaduto perché l’uomo vivo, che sente drammaticamente la vita, in Italia, dove anche i sassi parlano di Cristo, cosa è accaduto perché gli uomini più grandi hanno sentito questa nostalgia di Cristo senza riconoscerlo presente? Cosa è stata per loro la Chiesa? Cosa siamo oggi di fronte al grido dell’uomo noi cristiani? Questo è il tema di stasera e a me, cristiano, leva la pelle. Mi fa star male perché è il grido di Pasolini come è il grido, settant’anni dopo del Peppino della lettera che vi lessi.
XVIII – ALLA SUA DONNA
Cara beltà che amore
Lunge m’inspiri o nascondendo il viso,
Fuor se nel sonno il core
Ombra diva mi scuoti,
O ne’ campi ove splenda
Più vago il giorno e di natura il riso;
Forse tu l’innocente
Secol beasti che dall’oro ha nome,
Or leve intra la gente
Anima voli? o te la sorte avara
Ch’a noi t’asconde, agli avvenir prepara?
Bellezza infinita che mi scuoti nel sonno, che mi sorprendo a desiderare con tutto me stesso, dove sei? Forse sei stata nel passato, forse sei presente ma non ti vediamo, o forse devi ancora venire. Dove sei?
Viva mirarti omai
Nulla speme m’avanza;
S’allor non fosse, allor che ignudo e solo
Per novo calle a peregrina stanza
Verrà lo spirto mio. Già sul novello
Aprir di mia giornata incerta e bruna,
Te viatrice in questo arido suolo
Io mi pensai.
Da bambino, da ragazzo ho davvero sperato che tu mi fossi compagna, bellezza finita, cioè Dio.
“Viatrice” è compagna di strada, ma che a me ha sempre fatto venire la pelle d’oca per la sua assonanza con la Beatrice invocata ma non più presente.
Ma non è cosa in terra
Che ti somigli; e s’anco pari alcuna
Ti fosse al volto, agli atti, alla favella,
Saria, così conforme, assai men bella.
Fra cotanto dolore
Quanto all’umana età propose il fato,
Se vera e quale il mio pensier ti pinge,
Alcun t’amasse in terra, a lui pur fora
Questo viver beato:
Ecco, la felicità sarebbe questo: che sulla terra - chissene frega del Paradiso! - qui su questa terra, giorno per giorno nella fatica della giornata ti potessi amare, abbracciare, sentire compagna.
E ben chiaro vegg’io siccome ancora
Seguir loda e virtù qual ne’ prim’anni
L’amor tuo mi farebbe.
E se tu fossi qui, per il tuo amore io ritroverei l’entusiasmo e le passioni della giovinezza.
Or non aggiunse
Il ciel nullo conforto ai nostri affanni;
“Ma non è vero, non ci sei, non è accaduto”. Però di nuovo ripete:
E teco la mortal vita saria
Simile a quella che nel cielo india.
Eppure la vita con te sarebbe uguale a quella che nel cielo vivono i beati. Simile a quella che nel cielo rende simili a Dio: “india”.
Per le valli, ove suona
Del faticoso agricoltore il canto,
Ed io seggo e mi lagno
Del giovanile error che m’abbandona;
E per li poggi, ov’io rimembro e piagno
I perduti desiri, e la perduta
Speme de’ giorni miei; di te pensando,
A palpitar mi sveglio. E potess’io,
Nel secol tetro e in questo aer nefando,
L’alta specie serbar; che dell’imago,
Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago.
Se dell’eterne idee
L’una sei tu, cui di sensibil forma
Sdegni l’eterno senno esser vestita,
E fra caduche spoglie
Provar gli affanni di funerea vita;
Se tu sei Dio ma te ne stai per conto tuo, non ti va di servire questa carne e provare il dolore della vita come lo proviamo noi, oppure:
O s’altra terra ne’ superni giri
Fra’ mondi innumerabili t’accoglie,
E più vaga del Sol prossima stella
T’irraggia, e più benigno etere spiri;
Di qua dove son gli anni infausti e brevi,
Questo d’ignoto amante inno ricevi.
“Io l’unica cosa che posso fare, da uomo, leale con me stesso e leale con la condizione che vivo è, Dio sconosciuto, adorarti, mettermi in ginocchio davanti a questa grandezza che vedo ma che non accetta di farsi compagna della vita”. Quando don Giussani commenta questa poesia e chiude il libro “Cara beltà” di commento a Leopardi, si fa questa domanda: “Come ha potuto arrivare fin qui, chiedere l’incarnazione, invocare l’incarnazione e non riconoscerla? Per brutta che fosse la Chiesa e brutto che fosse il popolo cristiano erano ben duemila anni di questo annuncio che lo ha raggiunto”. E tira questa conclusione che mi ha sempre colpito molto, perché io avrei detto: “Con una madre come quella di Leopardi, che viveva il cristianesimo a quel modo (Ritratto di una madre), non poteva essere cristiano. O con il padre tradizionalista legato al potere della Chiesa, proprio non poteva”. Giussani dice invece semplicemente: “Gli mancò amicizia sufficiente”. Quel che serve è avere amicizia sufficiente perché questa domanda possa essere dialogata con degli amici, sentita fattore comune della propria umanità e perciò, con degli amici, avventurarsi alla ricerca, almeno alla ricerca leale, sincera, piena di ammirazione e di meraviglia, di dove questo Dio che dicono si sia fatto carne, si sia cacciato. Andarlo a stanare per le strade del mondo, in quel che accade, in quel che succede. Nella presunzione che la Chiesa ha di se stessa, conciata com’è, ma che continua a dire “Io sono il corpo di Cristo, quello che cerchi è qui”. Quel che le nostre comunità e le nostre parrocchie dovrebbero fare è questo: generare amicizia sufficiente per andare a vedere insieme dove Cristo abita e dove ci viene incontro e ci chiama.
Bene, quel che vorrei provare a dire stasera, leggendo alcune cose, è provare a mettere a tema la domanda iniziale: cos’è accaduto ad alcuni grandi, e prendo Pasolini come punto chiaro di questa terribile contraddizione che è la stessa di Leopardi, che invocavano Cristo presente e sentivano uno struggente amore per il popolo? Perché io solo tre persone ho sentito al mondo parlare del popolo così: don Giussani, il prete più anti-borghese, anti-clericale che io abbia mai visto che aveva un amore vero alla gente, al popolo. Mi raccontava che da bambino si commuoveva sentendo gli operai o i contadini che tornavano dalla terra, nelle sue zone, Desio, la Brianza campagnola, lo riscuotevano dal sonno sentendo gli uomini al sabato sera tornare a casa ubriachi fradici cantando canzonacce con il fiasco del vino in mano. Lui si commuoveva perché quello era il popolo cristiano. Questo stesso sentimento l’ho ritrovato nelle pagine di Pasolini che leggeremo adesso. E forse la stessa cosa la notai quando conobbi Aldo Brandirali, di Servire il Popolo, una delle fazioni para militari vicini alle Brigate Rosse negli anni di piombo che aveva chiamato il suo movimento “servire il popolo” per uno struggente amore al popolo. Poi si è convertito incontrando don Giussani e siamo diventati amici, l’ho conosciuto bene e aveva veramente quella sensibilità, quell’amore per il popolo, per la gente gente. Poche volte, al di là di tanti manifesti, ho sentito parlare del popolo con un amore così, oltre che nel Vangelo, naturalmente.
Quel sogno di Leopardi di avere Dio come compagno della vita è in fondo il sogno anche di Pasolini. Nasce nel 1922 e muore nel 1975, viene trovato ammazzato come sapete, alla periferia di Roma, frequentava omosessuali, quindi era lo scandalo vivente di tutto ciò che la Chiesa aborriva. Era della stessa classe di don Giussani, e non si sono incontrati per un pelo: quando è stato ammazzato avevano già fissato un incontro, come racconta Savorana nella biografia di don Giussani. Chissà cosa sarebbe stato quell’incontro.
Pasolini scrive un racconto “Il sogno di una cosa” il cui inizio è tratto dal Capitale di Carlo Marx, che aveva visto da poco. Ora non ricordo esattamente dove sta la citazione, ma dice che stava per emergere il sogno di una grande cosa che l’umanità ha sempre avuto e finalmente comincia a prendere corpo, si comincia a vedere. Il sogno di una verità, di una bellezza della vita che poi evidentemente ha preso una strada che è esattamente il contrario per le ragioni che abbiamo visto in tutte queste serate e che ridirò stasera. Il sogno di una vita vera, questa nostalgia, che io chiamo così esplicitando il sugo della storia, la nostalgia di Cristo, la nostalgia del fatto che Cristo ci possa essere compagno che è stata rigettata dalla modernità in nome di un razionalismo che abbiamo visto però fallire. Ha generato una sorta di ubriacatura, di ottimismo sulla possibilità che l’uomo si sostituisse a Dio ritenuto inutile se non dannoso, se non nemico. Ma questo ottimismo è stato pesantemente frustrato da un secolo che fra due guerre mondiali e tutto quel che è successo ha mostrato la corda. L’ottimismo moderno ha mostrato la corda. Alcuni se n’erano accorti, abbiamo visto nel Verismo e in Pirandello e han detto “non funzionerà mai, o comunque c’è qualcosa in questa nostra presunzione che non funziona”. Allora io riprendo in momento il testo di don Giussani e leggo i quattro branetti che ho scelto su Pasolini e man mano li leggo vi dico un po’ la mia.
Giussani a un certo punto dice che lo smarrimento culturale dell’uomo moderno, cioè l’esito di questo percorso, di questa presunzione poi frustrata dalla storia, dai fatti, è uno smarrimento culturale. L’uomo moderno sembra essere caratterizzato da alcune ferite, da alcune cicatrici che lui definisce così: “una angoscia di fronte all’assenza, alla enigmaticità dell’essere, della vita, delle cose, la realtà che pure c’è sembra non avere alcun significato. O questo significato, se c’è, sembra irreperibile. Perché le cose, perché la vita, perché il dolore, le grandi domande dell’uomo di fronte alla realtà sembrano non trovare più una risposta”. Cita, bellissimo, il romanzo “Barabba” premio Nobel per la letteratura, la storia dell’uomo che ha avuto la vita salva perché Cristo ha perso la vita al suo posto, ma di Cristo non sa nulla. Barabba non si converte ma il premio Nobel, nella motivazione del premio Nobel a questo romanzo è scritto così: “È considerato emblema dell’uomo europeo, il quale riconosce il cristianesimo come fonte dei valori che hanno imposto al mondo la sua cultura, ma in Cristo non riesce più a credere”. La presunzione di realizzare un cristianesimo senza Cristo. L’abbiamo detto tante volte: liberté, egalité, fraternité, ma non più fondata sul Padre Nostro, ma sulla ragione, sulla natura dell’uomo.
“Uno sconosciuto è mio amico” sempre una poesia di Lagerkvist:
Uno sconosciuto è mio amico,
uno che io non conosco,
uno sconosciuto lontano lontano.
Per lui il mio cuore è pieno di nostalgia.
Perché Egli non è presso di me.
Perché Egli forse non esiste affatto?
Chi sei tu che colmi il mio cuore della tua assenza?
Che colmi tutta la terra della tua assenza?
Chi sei tu? Sento che ci devi essere ma non riesco più a riconoscerti.
La seconda conseguenza di cui parla Giussani, le cito soltanto, poi andrete voi a riprenderle sul libretto. La cosa più interessante è stata per me andare a rileggere la lettera di Beppino o tirare fuori le lettere di tanti alunni in questi anni e sentire che ragazzi di 14 o 15 anni dicono la stessa cosa quasi con le parole dei poeti e degli scrittori, dei geni. È impressionante. “L’uomo non può a lungo, dice Giussani, resistere in questa situazione enigmatica perché ‘Tutta la legge dell’umana esistenza sta in questo: che l’uomo possa inchinarsi all’infinitamente grande’” usando le parole di Dostoevskji. Per questo vi ho citato Leopardi, per questo lo fisso come discrimine della storia occidentale e europea perché è stato l’ultimo con questo grido: “sarebbe bello che Dio ci fosse compagno nella vita” ma allo stesso tempo grida “peccato che non è vero”. E qui comincia a introdursi la domanda vera su ciascuno di noi, su che tipo di fede viviamo. Che fede viviamo se gli uomini del nostro tempo gridano una nostalgia per Cristo e devono dire, di fronte al cristianesimo “Peccato che non è vero”. È una responsabilità enorme che abbiamo.
Una disperazione etica è la seconda conseguenza denunciata da Giussani, cioè non c’è legge, non ci sono più il bene e il male, non si sa più nulla del bene e del male. Kafka diceva: “Anch’io come chiunque altro ho in me fino alla nascita un centro di gravità che neanche la più pazza educazione è riuscita a spostare”. Questa è una citazione che amo tantissimo e che rincuora i genitori e gli insegnanti che possono stare tranquilli che nemmeno la peggiore educazione può togliere il grido con cui Dio ha fatto l’uomo. Il bisogno di felicità con cui Dio ci ha messo al mondo, quello non lo ammazza un insegnante, un genitore, pur mettendocela tutta. È il grillo parlante apparentemente ammazzato nel primo capitolo da Pinocchio che torna continuamente. Quello non lo puoi ammazzare. E continua: “Ma in me questo centro di gravità è come una palla di piombo che appesantisce anziché aiutare a vivere. Un’angoscia esistenziale”. Dopodiché le conseguenze di questa angoscia esistenziale che chiama “disperazione etica” sono molte e lui ne fa un elenco terrificante che leggerete voi.
Io queste cose cerco di rintracciarle nel testo di Pasolini: la perdita del gusto di vivere, sfiducia in sé, nella consistenza della persona, distruzione dell’utilità del tempo, una terribile solitudine, un’inconsistenza della realtà che non ha più una sua ragion d’essere e perciò il rifugiarsi in un impegno volontaristico “Ci metto almeno la mia buona volontà”, che non serve assolutamente a niente.
Pasolini è la quintessenza di tutto l’odio per la Chiesa, anche se in realtà poi non è così vero e lo vedremo in uno dei quattro brani che leggeremo, un discorso che ha fatto a Brescia nel dicembre 1964, stesso anno dell’uscita del film “Il Vangelo secondo Matteo”. Lui dice certe cose in sintonia totale con quel che stavo dicendo adesso. Vorrei far notare questo suo essere profeta in che senso? Scartata l’ipotesi che la Chiesa sia una cosa interessante per la vita degli uomini d’oggi, guarda il suo tempo e capisce che la cosiddetta rivoluzione, il cosiddetto mondo nuovo per cui un’intera generazione si sta battendo - questo fu il ’68 almeno nelle sue manifestazioni ufficiali - ha dentro un marcio che lui sente d’istinto e lo denuncia con un coraggio che gli costò molto.
Forse uno dei brani più famosi in questo senso è quello che scrisse subito dopo i famosi “scontri di Valle Giulia” qui a Roma. I primi scontri violentissimi, il 16 giugno del ’68 tra polizia e manifestanti. Stava per crollare la diga e lui scrive questa cosa incredibile. Chi ha più o meno la mia età si ricorderà che cos’erano più o meno quegli anni, come temperie culturale, come clima che c’era. Se andavi contro erano legnate, erano botte. Veniva esercitato un ostracismo e con l’etichetta “fascista” venivi fatto fuori dal lavoro, dalle fabbriche, dalle amicizie. E lui invece con un coraggio da leoni scrive:
Mi dispiace. La polemica contro
il Pci andava fatta nella prima metà
del decennio passato. Siete in ritardo, cari.
Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati:
peggio per voi.
Adesso i giornalisti di tutto il mondo (compresi
quelli delle televisioni)
vi leccano (come ancora si dice nel linguaggio
goliardico) il culo. Io no, cari.
Avete facce di figli di papà.
Vi odio come odio i vostri papà.
Buona razza non mente.
Avete lo stesso occhio cattivo.
Siete pavidi, incerti, disperati
(benissimo!) ma sapete anche come essere
prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati:
prerogative piccolo-borghesi, cari.
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte
coi poliziotti,
io simpatizzavo coi poliziotti.
Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da subtopie, contadine o urbane che siano.
Quanto a me, conosco assai bene
il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo anche lui,
a causa della miseria, che non dà autorità.
La madre incallita come un facchino, o tenera
per qualche malattia, come un uccellino;
Questo è il popolo. Perché io ho patito tutto l’errore di quegli anni, io l’ho sentito come un nemico mortale Pasolini, ma se l’avessi incontrato credo che in qualcosa ci saremmo capiti perché io questa cosa ce l’avevo. Non so come dirlo, ma la madre incallita come un facchino che muore di fatica a 60 anni ce l’avevo davvero. Continua parlando dei poliziotti.
E poi, guardateli come li vestono: come pagliacci,
con quella stoffa ruvida, che puzza di rancio
furerie e popolo. Peggio di tutto, naturalmente,
è lo stato psicologico cui sono ridotti
(per una quarantina di mille lire al mese):
senza più sorriso,
senza più amicizia col mondo,
separati,
esclusi (in un tipo d’esclusione che non ha uguali);
umiliati dalla perdita della qualità di uomini
per quella di poliziotti (l’essere odiati fa odiare).
Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care.
Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione della polizia.
Ma prendetevela contro la Magistratura, e vedrete!
[…]
una sola cosa gli studenti realmente conoscono:
il moralismo del padre magistrato o professionista,
il teppismo conformista del fratello maggiore
(naturalmente avviato per la strada del padre),
l’odio per la cultura che ha la loro madre, di origini
contadine anche se già lontane.
Questo, cari figli, sapete.
E lo applicate attraverso due inderogabili sentimenti:
la coscienza dei vostri diritti (si sa, la democrazia
prende in considerazione solo voi) e l’aspirazione
al potere.
Sì, i vostri orribili slogan vertono sempre
sulla presa di potere.
Leggo nelle vostre barbe ambizioni impotenti,
nei vostri pallori snobismi disperati,
nei vostri occhi sfuggenti dissociazioni sessuali,
nella troppa salute prepotenza, nella poca salute disprezzo
(solo per quei pochi di voi che vengono dalla borghesia
infima, o da qualche famiglia operaia
questi difetti hanno qualche nobiltà:
conosci te stesso e la scuola di Barbiana!)
[…]
Sarà che gli operai non parlano né il francese né l’inglese,
e solo qualcuno, poveretto, la sera, in cellula,
si è dato da fare per imparare un po’ di russo.
Smettetela di pensare ai vostri diritti,
smettetela di chiedere il potere.
Un borghese redento deve rinunciare a tutti i suoi diritti,
a bandire dalla sua anima, una volta per sempre,
l’idea del potere.
Quanto di più evangelico si possa immaginare. Poi è una poesia molto più lunga, che ha dentro una cosa che per il tempo era assolutamente rivoluzionaria. Quella che sta accadendo non è la rivoluzione della gente nel senso profondo del termine, non è del popolo, non aiuterà a camminare verso la felicità. È solo un cambio di guardia. Un potere si sostituisce a un vecchio potere. Le categorie sono quelle del marxismo di allora: le lotte di classe, che oggi fanno un po’ sorridere ma alle quali della gente ha sacrificato la vita, quindi tanto di cappello. Perché il PCI fu una Chiesa a tutti gli effetti, con i suoi dogmi, le sue obbedienze, il suo papa. Alcuni avevano un grande amore proprio per il popolo. Negli anni quanti colleghi ho incontrato a scuola e quanta fatica si è fatta a volte a lavorare insieme tra cattolici, veramente una fatica grande perché il privilegio era sempre alla forma, ai modi, ai comportamenti, ai cosiddetti valori. Ma un amore vero a quei ragazzi così come sono l’ho trovato tante volte proprio in colleghi comunisti, che venivano dall’altra chiesa. Perché anche per loro fu una fede nel popolo quella che vivevano e la missione che vivevano come insegnanti. Poi dentro un guscio ideologico terrificante, culturalmente e politicamente ma per me l’incontro con alcuni di loro è stato l’incontro con quel sentimento del popolo, del bisogno della gente.
E Pasolini cosa individua invece nel ’68? La rivoluzione di un nuovo potere più devastante di tutti i poteri precedenti.
È stata la propaganda televisiva del nuovo tipo di vita “edonistico” che ha determinato il trionfo del «no» al referendum. [1974, dopo il referendum sul divorzio] Non c’è niente infatti di meno idealistico e religioso del mondo televisivo. È vero che in tutti quegli anni la censura televisiva è stata una censura vaticana. Solo per che il Vaticano non ha capito che cosa doveva e che cosa non doveva censurare. Doveva censurare per esempio «Carosello»,
Voi vi ricordate cos’era il Carosello? Non c’era un tempo la pubblicità in mezzo ai film! Mi ricordo che quando mio fratello mi disse “sapete che in America interrompono un film per far vedere la pubblicità?” nessuno ci credeva! La pubblicità era Carosello, cinque pubblicità che erano dei veri e propri piccoli filmati e dopo a nanna, il demonio arrivava dopo Carosello, c’era la tv dei ragazzi, poi qualcosa in una zona grigia tra il vietato e il lecito, ma Carosello certamente sanciva l’orario e i programmi solo per adulti. E lui dice:
Perché è in «Carosello», onnipotente, che esplode in tutto il suo nitore, la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di vita che gli italiani «devono» vivere. E non mi si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa. D’altra parte le trasmissioni di carattere specificamente religioso della Televisione sono di un tale tedio, di un tale spirito di repressività, che il Vaticano avrebbe fatto bene a censurarle tutte. Il bombardamento ideologico televisivo non è esplicito: esso è tutto nelle cose, tutto indiretto. Ma mai un «modello di vita» ha potuto essere propagandato con tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo e di donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da realizzare, non è descritto o decantato: è rappresentato! Il linguaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento. Che viene dunque mimato di sana pianta, senza mediazioni nel linguaggio fisico-mimico e nel linguaggio del comportamento nella realtà. Gli eroi della propaganda televisiva - giovani su motociclette, ragazze accanto a dentifrici - proliferano in milioni di eroi analoghi nella realtà.
Certo che qui ogni cosa sarebbe da discutere: ci sono delle ragioni storiche, venivamo dalla guerra e da uno stato di povertà e, con passione, una generazione di genitori ha detto: “Quello che ho passato io, mio figlio no!” E quindi lavorare 40 ore al giorno per garantire quel livello di vita materiale. Sentita come progresso, come passo in avanti, per cui stiamo parlando di cose che hanno mille sfaccettature. Io quel che voglio individuare è che cosa è il cristianesimo in un mondo così. Dopo del resto si può discutere.
Appunto perché perfettamente pragmatica, la propaganda televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova ideologia edonistica del consumo: e quindi è enormemente efficace.
Se al livello della volontà e della consapevolezza la televisione in tutti questi anni è stata al servizio della democrazia cristiana e del Vaticano, al livello involontario e inconsapevole essa è stata invece al servizio di un nuovo potere che non coincide più ideologicamente con la democrazia cristiana e non sa più che farsene del Vaticano.
Quel nuovo potere è quanto di più anticristiano ci sia. Fa un paragone poi tra le città dell’Unione Sovietica e le città occidentali e dice che in Unione Sovietica si vede da come la gente è vestita e va in giro, che ha raggiunto l’uguaglianza. E a me viene la domanda: Ma come ha fatto un genio così a non accorgersi della stupidaggine che sta dicendo? Come hanno fatto a credere a quell’uguaglianza lì ritenendola più vera perché esito di una conquista sociale, di una lotta di classe, di una rivoluzione che certo ha visto degli eroi, a Stalingrado, ma come fai a non vedere la verità paragonando l’uguaglianza raggiunta in Unione Sovietica come un’uguaglianza vera perché guadagnata col sangue e quella invece occidentale non vera perché concessa dal nuovo potere economico? Si capisce? C’è una svista clamorosa che ci fa chiedere a dove e cosa stava guardando! Pasolini scrive “L’uguaglianza infatti non è stata conquistata, ma è una ‘falsa’ uguaglianza ricevuta in regalo”.
Questo esempio poi forse è sintesi di tutto Pasolini:
Una delle caratteristiche principali di questa uguaglianza dell’esprimersi vivendo, oltre alla fossilizzazione del linguaggio verbale, è la tristezza: l’allegria è sempre esagerata, ostentata, aggressiva, offensiva. La tristezza fisica di cui parlo e profondamente nevrotica. Essa dipende da una frustrazione sociale. Ora che il modello sociale da realizzare non è più quello della propria classe, ma imposto dal potere, molti non sono appunto in grado di realizzarlo. E ciò li umilia orrendamente. Faccio un esempio, molto umile. Una volta il fornarino, o cascherino – come lo chiamano qui a Roma – era sempre, eternamente allegro: un’allegria vera, che gli sprizzava dagli occhi. Se ne andava in giro per le strade fischiettando e lanciando motti. La sua vitalità era irresistibile. Era vestito molto più poveramente di adesso: i calzoni erano rattoppati, addirittura spesse volte la camicetta uno straccio. Però tutto ciò faceva parte di un modello che nella sua borgata aveva un valore, un senso. Ed egli ne era fiero. Al mondo della ricchezza egli aveva da opporre un proprio mondo altrettanto valido. Giungeva nella casa del ricco con un riso naturaliter anarchico, che screditava tutto: benché egli fosse magari rispettoso. Ma era appunto il rispetto di una persona profondamente estranea. E insomma, ciò che conta, questa persona, questo ragazzo era allegro.
Non è la felicità che conta? Non è per la felicità che si fa la rivoluzione? La condizione contadina o sottoproletaria sapeva esprimere, nelle persone che la vivevano, una certa felicità «reale». Oggi, questa felicità con lo Sviluppo è andata perduta. Ciò significa che lo Sviluppo non è in nessun modo rivoluzionario, neanche quando è riformista. Esso non dà che angoscia. Ora ci sono degli adulti della mia età così aberranti da pensare che sia meglio la serietà (quasi tragica) con cui oggi il cascherino porta il suo pacco avvolto nella plastica, con lunghi capelli e baffetti, piuttosto che l’allegria «sciocca» di una volta. Credono che preferire la serietà al riso sia un modo virile di affrontare la vita. In realtà sono dei vampiri felici di vedere divenuti vampiri anche le loro vittime innocenti. La serietà, la dignità sono orrendi doveri che si impone la piccola borghesia; e i piccoli borghesi sono dunque felici di vedere anche i ragazzi del popolo «seri e dignitosi». Non gli passa neanche per la testa il pensiero che questa è la vera degradazione: che i ragazzi del popolo sono tristi perché hanno preso coscienza della propria inferiorità sociale, visto che i loro valori e i loro modelli culturali sono stati distrutti.
[11 luglio 1974, P.P.P., “Ampliamento del bozzetto sulla rivoluzione antropologica in Italia” in Scritti Corsari]
Cioè che cosa sta dicendo? Non fa il passo, non ci arriva a dire le cose per come sono, ma arriva sull’orlo, come Leopardi. Cosa sta dicendo Pasolini? Sta dicendo che è stata distrutta la tradizione, che è stata distrutta quella ragione profonda che faceva lieto mio padre nella sua povertà e nella sua apparente inferiorità sociale. Quella letizia che ha vissuto un intero popolo piena di drammi, di fatica, di dolore, ma permessa da una profonda a volte non detta o indicibile letizia che era data dal “tutto è bene, Cristo è risorto, la vita ha un senso. La pena e il dolore hanno un significato, nulla è perduto”. Questo era il sentimento, il giudizio della fede che ha fatto vivere un popolo per 1800 anni. Lui però la butta lì in chiave sociale, economica, classista. La sente questa cosa, la dice, ma non ne sa individuare il motivo vero. La butta in politica anche lui, proprio perché è di quegli anni. Ma che meraviglia sentirgli descrivere il fornarino contento e sentire la tragedia di una tristezza invece imperante e che diventa l’angoscia caratteristica di una generazione.
Quelli sono gli anni del Concilio, gli anni di rinnovamento che la Chiesa vive, negli anni in cui l’Europa bruciava non per una guerra vera e propria, ma per l’incendio di navi alle spalle, ponti, incendiando la tradizione. Il dibattito conciliare è stato come soffiare sul fuoco, in senso anche positivo. Il sentimento di una rivoluzione ha accompagnato anche la Chiesa. Che qualcosa bisognasse cambiare era chiaro a tutti, il problema è che questa ideologizzazione che nel ’68 è avvenuta, per via di quel razionalismo di cui abbiamo parlato già, che diventa in questi anni coscienza popolare, che invade le case, le famiglie attraversa, si sposa con il dibattito interno alla Chiesa sulla propria funzione e la propria natura. Un’attesa grande riforma della vita della Chiesa.
Vi racconto come l’ho vissuta io. A Calcinate, dove ho aperto nell’82 una scuola cattolica, stavamo cercando uno stabile per quella che nelle nostre intenzioni doveva essere una scuola media. Troviamo questo stabile enorme, dei padri passionisti che, per farla breve, ci hanno accolto e hanno permesso l’avvio della scuola “La Traccia”. Era l’82, in questo luogo deserto, c’erano allora 17 ragazzini in seminario perché era il seminario minore delle medie nazionale dei padri passionisti. Era stato inaugurato nel ’62, vent’anni prima, con 350 posti letto che non bastavano, ora erano 17 ragazzini e qualche anziano padre. I seminari in quegli anni si sono letteralmente svuotati e siccome erano pieni dei migliori tra i nostri ragazzi, dal punto di vista almeno della formazione intellettuale e culturale, il travaso di queste intelligenze, di anime nobili in cerca di ideali grandi, il travaso dalla Chiesa ai movimenti di formazione marxista è stato quasi automatico. La bontà dell’ideale perseguito dentro il seminario nella vocazione, sentito ad un certo punto quell’ideale cristiano come inadeguato, non storicamente fondato e sentita molto più adeguata il nuovo verbo marxista proprio come parola e annuncio di una salvezza per i poveri, per gli indigenti, per le classi sociali perseguitate dal capitale, nel giro di pochissimi anni un’intera generazione fece armi e bagagli e passò dall’altra parte.
Ma non la sentì come un passaggio dall’altra parte. Nessuno allora avvertì che quella parte sarebbe stata una parte così violentemente nemica del cristianesimo, della tradizione e della Chiesa. È successo poco dopo, ma in quegli anni fu sentita come la traduzione vera della propria passione evangelica per i poveri e per gli oppressi. I gruppi parrocchiali, che subirono anche nel lessico - si potrebbe fare la storia di questo paese con la storia lessicale di certi fenomeni sociale -, i gruppi di base, che cominciarono a chiamarsi così in opposizione all’autoritarismo dei vertici, in quattro e quattr’otto diventarono i gruppi di “marxismo e cristianesimo”.
La Bibbia era il libro di Girardi “Marxismo e cristianesimo”. Poi a dar man forte arrivò il Catechismo olandese, poi un certo modo di sentire nella Chiesa certe figure che, in opposizione al cosiddetto autoritarismo della gerarchia, dogmatismo dei contenuti, formalismo dei riti, avviò quel casino che conosciamo. Noi abbiamo assistito a cose che raccontate oggi fanno ridere ma io ho assistito a messe dei preti operai! Io ero il rappresentate di CL al convegno “Evangelizzazione e promozione umana” della Diocesi di Bergamo e mi sorbii una giornata intera di persone, anche di una certa età, che urlavano: “Buttiamo giù le chiese per fare le case per i poveri perché questo è il vero vangelo, i comizi saranno le nostre prediche, i cortei le nuove processione etc…” Ma davanti al Vescovo al convegno diocesano! Arrivarono poi i preti guerriglieri osannati che dicono messa con la cartuccera a tracolla e la maschera in volto mentre dicono messa in mezzo alla giungla coi poveri dell’Amazzonia. Insomma, è montato tutto un equivoco che inizialmente non fu un equivoco, era una passione vera rispetto alla quale la Chiesa si è trovata totalmente impotente, non preparata. Arroccata a difesa di alcune forme che parevano difendere la fede stessa, e le forme invece non la difendono mai. E nello stesso tempo saliva un’esigenza di cambiamento perché questa contraddizione era ormai una ferita aperta. Perciò il Concilio diventò un dibattito da bar: invece che di calcio, si parlava del Concilio. Da questo punto di vista la nostra è stata una generazione meravigliosa, era normale a 17 anni fare discussioni fino alle 3 di notte sul Concilio, sulla Chiesa, sui poveri, per che cosa si dava la vita. In questo fummo una bella generazione, poi vi dico cosa ne pensava Pasolini e cambiate idea.
Pasolini, in una presentazione del suo “Il Vangelo secondo Matteo” parla del papa Giovanni XXIII, il papa buono, al quale evidentemente io sono particolarmente debitore essendo il papa santo bergamasco. Io ricordo che quando è morto, nel 1963, la mia mamma, poveri come eravamo, comprò il giradischi per poter sentire la canzone del papa buono anche in casa. L’altro ricordo che ho è di quando è morto. Alle tre di notte bussano alla porta violentemente, era un amico di mio padre che disse: “È morto il papa, si va a Roma. Appuntamento con le bici, in piazza, alle 5”. Alle cinque del mattino gli uomini di mezzo paese, in bicicletta, partivano per i funerali di papa Giovanni, per venire a Roma. Queste sono cose che dicono tutto di una storia, di un paese, di una cultura.
Quando io leggo queste cose, Pasolini aveva questo sentimento che io vi sto comunicando adesso, perché sentire alle tre buttar giù la porta e vedere uomini d’acciaio che uscivano dalla guerra, in lacrime che si chiamavano l’un l’altro per la morte del papa era una cosa incredibile. Ma vi rendete conto? Quella civiltà è stata spazzata via nel giro di dieci anni. E i padri non sono più riusciti a parlare con i figli, tantomeno con le figlie. Un disastro. Quella cultura del nostro disegnino che sale sempre di più, sempre più nemica della Chiesa, in questi anni, e questa è la tesi che vede sposato il pensiero di Pasolini e quello di don Giussani, attraverso in particolare la televisione e la scuola di stato, quella cultura entra nella vita della gente, creando questo casino, questo disastro. Separa, distrugge, anche nell’immaginario, duemila anni di civiltà cristiana, distruggendone i principi fondamentali: l’autorità, la religiosità, e la caratteristica fondamentale, quella di Leopardi, una dipendenza dal mistero. L’uomo umilmente adoratore di una grandezza che non dipende da lui, che viene prima di lui, questa è l’operazione che è stata perpetrata in quegli anni da gente in massima parte inconsapevole di quello che stava accadendo, gente brava, che voleva aiutare. Gente che magari è partita per il terzo mondo, con i gruppi del Mato Grosso, la Gioventù risveglio, il Gen Rosso, movimenti anche internazionali che questo afflato di verità e di solidarietà con i poveri l’hanno vissuto pagandone il prezzo con la vita!
Questo, che era vero, che fu una passione vera, in un baleno, buttata in politica è diventata un’ideologia terrificante. Pasolini l’aveva già visto. Il profeta è quello che vede da pochissimi indizi presenti il futuro, queste sono queste pagine.
In un certo senso Giovanni XXIII compiva l’atto profondamente altamente democratico di sorridere di se stesso.
Cosa volete immaginare di più rivoluzionario nella Chiesa, nella Chiesa che si è sempre posta come autoritaria, come paternalistica, come dogmatica, antiliberale e antidemocratica nel fondo? Papa Giovanni ha compiuto nel proprio ciclo, nel breve ciclo del suo papato, una profonda rivoluzione nella Chiesa, ed è questa profonda rivoluzione che è un fatto secondo me definitivo e importante. Non è il fatto che egli fosse un buon Papa e simpatico a tutti noi, a tutti i livelli. Non è questo l’importante. È che per la prima volta Papa Giovanni XXIII ha vissuto all’interno della Chiesa, nel profondo del suo spirito cristiano la grande esperienza laica e democratica della borghesia. Ha vissuto cioè la reale realtà del suo tempo, e nella reale realtà del suo tempo, oltre a questa esperienza, fondamentale, laica e democratica della borghesia, ci sono delle nuove realtà, c’è la realtà del socialismo.
Voi sapete che il socialismo è nato con il Vangelo in mano. Alla fine dell’Ottocento i primi Socialisti hanno cominciato a predicare il loro socialismo tenendo in mano il Vangelo, riferendosi al Vangelo.
De Lubac, grande teologo, ha scritto che la tragedia dell’umanità è stato il mancato incontro tra socialismo e cristianesimo, e qui lo si vede.
E ci sono anche comunisti in questa nuova realtà. Ebbene tutti voi avete visto come Papa Giovanni non riuscisse, – proprio non riuscisse psicologicamente a fare delle discriminazioni – non perché lo facesse per volontà o per intenzione o per diplomazia; assolutamente no. (Il compromesso richiesto dalla diplomazia è un fatto profondamente anticristiano e anti-evangelico. Quando mai Cristo ha predicato e ha detto: «siate diplomatici», oppure «venite a compromessi?» È proprio il contrario di quello che ha predicato Cristo.) Quindi Giovanni XXIII, che era profondamente cristiano, non veniva a compromessi. C’era molta bonomia e molta dolcezza in lui, e quindi perdonava qui e là, ogni volta che poteva; ma non ha mai ceduto ad un momento di compromesso. Era autentico il moto democratico di avvicinamento a tutti quelli che sono i classici nemici della Chiesa.
Questa è la cosa che ferisce e che colpisce: lui chiama democrazia quello che è cristianesimo.
Voi avrete dunque osservato come Papa Giovanni XXIII era incapace psicologicamente di fare delle discriminazioni. Questo perché in lui si erano profondamente fusi e incrociati lo spirito cristiano con lo spirito della democrazia. Uno che sia veramente cristiano e sia veramente democratico non è capace di fare delle discriminazioni. Quindi, quando si rivolgeva a dei comunisti si rivolgeva veramente a delle persone come lui; non riusciva a concepirli manicheisticamente come degli esseri diversi con cui non fosse possibile avere dei rapporti.
[P.P.P. “Saggi sulla politica e sulla società”, Meridiani Mondadori]
Perché questo brano per me è importantissimo? Perché quello che Pasolini dice senza capirlo, senza riuscire a tratteggiarlo nella sua fisionomia vera è che cosa ha caratterizzato Papa Giovanni o comunque un certo spirito conciliare di allora? La grande scoperta che il problema del cristianesimo non era più delle forme cristiane da difendere ma era il problema del cristianesimo vissuto e capace di interpellare il cuore dell’altro. Per lontano che sia ideologicamente, l’altro ha il tuo stesso cuore, l’ha fatto Dio, ti è fratello. E per questa fratellanza vera che Cristo ha portato sulla terra tu dai la vita per l’altro. Comunista, fascista, nero, bianco, rosso non è più un problema di schieramenti, non è più un problema di orti da difendere, non è più un problema di castelli assaliti dal nemico a cui fare la guerra. Oggi è tempo di una Chiesa, come dice il papa, incidentata piuttosto che chiusa in se stessa. Una Chiesa che va fuori perché ha tanto da dare a quelli che ci sono fuori, che magari le vogliono male, non importa: era così all’inizio, è stato così per Gesù.
Ecco, quel che mi pare di poter dire in conclusione è questo, che Pasolini, se lo assumiamo come sintesi di questo desiderio dell’uomo gridato a mo’ della poesia di Leopardi, se osserviamo la storia del ’68 da questo punto di vista, come non rintracciare questo grido, questo bisogno di Cristo? Non più riconoscibile per mille ragioni. Quando penso a Oriana Fallaci che, mentre con rabbia attacca l’ISIS, l’integralismo musulmano perché distrugge la bellezza che caratterizza il nostro paese, come fa a non vedere che quella bellezza è il cristianesimo? Perché contemporaneamente parla malissimo della storia della Chiesa, ma da ignorante proprio! Eppure riesce a scrivere un libro che osanna la grandezza dell’Italia, della sua tradizione ma nel contempo ne mina le fondamenta, minando proprio e accusando di delitti mai commessi proprio la vita della Chiesa, esattamente come tanti altri nel mondo dell’arte, della canzone, del cinema, nemici della Chiesa per ragioni ideologiche e per convenienza politica.
Poi quel movimento che ha scassato la società europea e la Chiesa nei termini che ho detto, che ha visto in quei vent’anni svuotarsi i seminari, dà vita a episodi per cui a casa mia fu fondato il Partito Democratico di Unità proletaria da sette baldi giovani, tutti e sette ex seminaristi. A casa mia dove aveva sede anche la nascente comunità di CL e dove venivano preti e frati in grande abbondanza. Fatto sta che una sera ci siamo trovati con tre cene contemporaneamente. Mio padre fece cinquanta trote al forno e ricordo bene che io pranzavo in cucina insieme al rettore del seminario dove c’era l’altro mio fratello con preti di una certa levatura, in sala pranzava il raduno dei responsabili di CL di Bergamo e in fondo il direttivo di Unità Proletaria e mi ricordo che mia mamma tira fuori la prima infornata di trote al forno e parte con il vassoio dicendo, di fronte alla mia richiesta di servire prima il rettore: “Prima quelli là, che ne hanno più bisogno”. E noi abbiamo aspettato il nostro turno, perché è questo il cristianesimo che ho imparato io dai miei. Non gli faceva la guerra, li sentiva lontani e bisognosi di Cristo, perché nella sincerità con cui avevano vissuto il loro ingresso in seminario era la stessa sincerità con cui ne erano usciti. Un certo potere li ha traditi e massacrati, e ha buttato tutto in politica, facendo di don Lorenzo Milani e dell’Isolotto e di quel che di meglio anche esprimeva la Chiesa, ne hanno fatto un’arma politica contro la Chiesa. Ma è anche una responsabilità della Chiesa stessa non essere stata presente all’appuntamento con questo grido di verità che ci veniva dai geni, dai profeti, dai grandi santi presenti sempre, e la Chiesa non ha capito, ha mancato all’appuntamento. Detta così capisco che è grossa ma è stata un’incomprensione vera. E cos’è successo? Che quelli lì che potevano essere i grandi alleati contro il nuovo potere del consumismo, del materialismo selvaggio che ha distrutto tutto, li abbiamo lasciati in pasto alla politica che ne ha fatto l’arma contro la Chiesa! E così io li ho odiati per scoprire adesso che erano grandi cuori, grandi menti, tradite da una incapacità della Chiesa di riconoscere questo grido perché troppo presa a difendere le forme e presi poi dal Nemico con la N maiuscola e usati proprio loro che gridavano il bisogno di verità, li ha usati il nemico e ne ha fatti un’arma contro la Chiesa.
È terribile ma la storia di tanti di questa generazione è stata proprio questa. Non dico l’abusato esempio di Renato Curcio capo delle Brigate Rosse presidente dell’Azione Cattolica del Veneto, ma è stato veramente così. La Chiesa ha generato dal suo interno i suoi peggiori nemici per questa parabola terribile che ha vissuto. A noi tocca metter rimedio a questo, a noi tocca il coraggio di smetterla di dividere il mondo in due, quelli pro e quelli contro, quelli dentro e quelli fuori. Ma cosa ne sappiamo ormai di chi è dentro e di chi è fuori? Quel mondo lì non c’è più. Quel che dice Papa Francesco, bisogna andar fuori da qui forti di un’amicizia che ci ha fatto vedere Cristo e incontrare gli uomini così come sono: marxisti, atei, comunisti, neri, gialli. Portare Cristo a un uomo devastato, a una generazione di giovani che vive tutti questi mali che Giussani elenca e tutti quelli della lettera della volta scorsa.
Ultima poesia, forse la più bella con cui chiudiamo. Si chiama “La poesia della Tradizione”.
Oh generazione sfortunata!
Cosa succederà domani, se tale classe dirigente –
quando furono alle prime armi
non conobbero la poesia della tradizione
ne fecero un’esperienza infelice perché senza
sorriso realistico gli fu inaccessibile
e anche per quel poco che la conobbero,
dovevano dimostrare
di voler conoscerla sì ma con distacco, fuori dal gioco.
Oh generazione sfortunata!
che nell’inverno del ’70 usasti cappotti e scialli fantasiosi
e fosti viziata
chi ti insegnò a non sentirti inferiore –
rimuovesti le tue incertezze divinamente infantili –
chi non è aggressivo è nemico del popolo! Ah!
I libri, i vecchi libri passarono sotto i tuoi occhi
come oggetti di un vecchio nemico
sentisti l’obbligo di non cedere
davanti alla bellezza nata da ingiustizie dimenticate
fosti in fondo votata ai buoni sentimenti
da cui ti difendevi come dalla bellezza
con l’odio razziale contro la passione;
venisti al mondo, che è grande eppure così semplice,
e vi trovasti chi rideva della tradizione,
e tu prendesti alla lettera tale ironia fintamente ribalda,
erigendo barriere giovanili contro la classe dominante del passato
la gioventù passa presto; oh generazione sfortunata,
arriverai alla mezza età e poi alla vecchiaia
senza aver goduto ciò che avevi diritto di godere
e che non si gode senza ansia e umiltà
e così capirai di aver servito il mondo
contro cui con zelo «portasti avanti la lotta»:
era esso che voleva gettar discredito sopra la storia – la sua;
era esso che voleva far piazza pulita del passato – il suo;
oh generazione sfortunata, e tu obbedisti disobbedendo!
Era quel mondo a chiedere ai suoi nuovi figli di aiutarlo
a contraddirsi, per continuare;
vi troverete vecchi senza l’amore per i libri e la vita:
perfetti abitanti di quel mondo rinnovato
attraverso le sue reazioni e repressioni, sì, sì, è vero,
ma soprattutto attraverso voi, che vi siete ribellati
proprio come esso voleva, Automa in quanto Tutto;
non vi si riempirono gli occhi di lacrime
contro un Battistero con caporioni e garzoni
intenti di stagione in stagione
né lacrime aveste per un’ottava del Cinquecento,
né lacrime (intellettuali, dovute alla pura ragione)
non conosceste o non riconosceste i tabernacoli degli antenati
né le sedi dei padri padroni, dipinte da
- e tutte le altre sublimi cose
non vi farà trasalire (con quelle lacrime brucianti)
il verso di un anonimo poeta simbolista morto nel
la lotta di classe vi cullò e vi impedì di piangere:
irrigiditi contro tutto ciò che non sapesse di buoni sentimenti
e di aggressività disperata
passaste una giovinezza
e, se eravate intellettuali,
non voleste dunque esserlo fino in fondo,
mentre questo era poi fra i tanti il vostro dovere,
e perché compiste questo tradimento?
per amore dell’operaio: ma nessuno chiede a un operaio
di non essere operaio fino in fondo
gli operai non piansero davanti ai capolavori
ma non perpetrarono tradimenti che portano al ricatto
e quindi all’infelicità
oh sfortunata generazione
piangerai, ma di lacrime senza vita
perché forse non saprai neanche riandare
a ciò che non avendo avuto non hai neanche perduto:
povera generazione calvinista come alle origini della borghesia
fanciullescamente pragmatica, puerilmente attiva
tu hai cercato salvezza nell’organizzazione
(che non può altro produrre che altra organizzazione)
e hai passato i giorni della gioventù
parlando il linguaggio della democrazia burocratica
non uscendo mai della ripetizione delle formule,
ché organizzar significar per verba non si poria,
ma per formule sì,
ti troverai a usare l’autorità paterna in balia del potere
imparlabile che ti ha voluta contro il potere,
generazione sfortunata!
Io invecchiando vidi le vostre teste piene di dolore
dove vorticava un’idea confusa, un’assoluta certezza,
una presunzione di eroi destinati a non morire –
oh ragazzi sfortunati, che avete visto a portata di mano
una meravigliosa vittoria che non esisteva!
Questa poesia è la poesia della mia generazione, siamo descritti totalmente. Quel potere lì, quel nuovo potere che ha usato il ’68 per riciclarsi, è quel potere ideologico, terribile, che ha conquistato in quegli anni tutto. Per cui la cosa di cui dobbiamo renderci conto è che patiamo una censura culturale per tutto ciò che è vero umanamente e cristianamente significativo, terrificante, prima di tutto a scuola. E qui si aprirebbe tutto il discorso, perché la rivoluzione fu fatta conquistando magistratura, scuola, università e giornali. Il potere di comunicazione, il potere di trasmissione alle nuove generazioni e il potere di giudicare il bene e il male. Le conseguenze le abbiamo viste. Io la prossima volta proverò, concludendo in positivo, a vedere alcuni autori dove invece, pur dentro questo casino terrificante, la certezza cristiana e quell’amore vero al popolo e quel bisogno vero di Cristo si documenta anche nella letteratura, che appunto è stata censurata ma c’è.
Ci leggeremo qualcosa per poter dire che sì, in modo carsico magari, ma quel cristianesimo c’è ancora, lo andiamo a ripigliare rendendoci consapevoli e coscienti.
Alla prossima.
3/ “Sulle spalle dei giganti” – Decimo incontro. Guareschi, Buzzati. Il passato è perduto per sempre?, di Franco Nembrini
Riprendiamo sul nostro sito la trascrizione del X incontro tenuto da Franco Nembrini per il ciclo Sulle spalle dei giganti il 16 marzo 2018 a Roma. I neretti sono nostri ed hanno l’unico fine di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Letteratura. Per altri testi e audio di Franco Nembrini, e in particolare per l’intero ciclo Sulle spalle dei giganti, clicca sul tag franco_nembrini.
Il Centro culturale Gli scritti (1/7/2018)
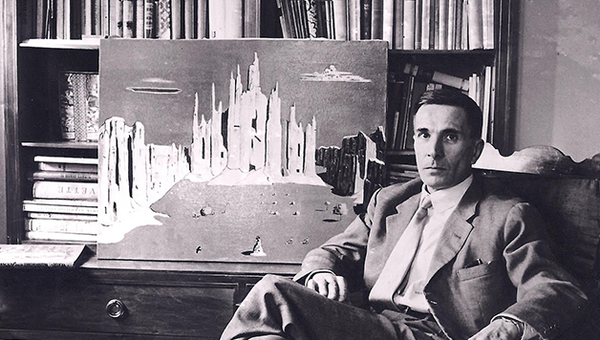
Siamo alla conclusione del nostro percorso di questi due anni. È stata difficilissima la scelta dei testi, come sempre. Ho dovuto fare subito una scelta radicale perché mi sono reso conto che per cercare di chiudere questo percorso e tentare di rispondere alle domande che ci siamo fatti durante la strada, non si potevano leggere tanti testi a spizzichi e bocconi. Quindi ho ridotto a due gli autori che citerò stasera: Buzzati e Guareschi. Ho lasciato perdere Corti, la cui lettura suggerisco comunque a tutti. Per me “Il cavallo rosso” insieme a “I più non ritornano” sono due testi assolutamente fondamentali. Il primo in particolare è un affresco storico di una grandezza, di un respiro, di una acutezza notevoli. Sono un migliaio di pagine ma vale veramente la pena leggerlo.
Perché Guareschi e Buzzati tra i mille che si potevano scegliere? Uno legge e racconta quel che sa e che lo ha colpito. Questi due autori mi sono carissimi, credo che li conosciate tutti almeno a grandi linee e li ho scelti perché mi pare che con due sensibilità diverse e con una scrittura però che li accomuna, sia nello stile molto semplice e popolare e sia nel genere della novella e del racconto breve, da due punti di vista diversi, uno decisamente cattolico tanto da fare del vero protagonista dei sui racconti il crocifisso, l’altro il grande cantore della vita come mistero anche se non espressamente cattolico, entrambi rimettono l’uomo di fronte alla realtà come mistero, cioè lo riposizionano secondo quella verità autentica, senza quella ideologizzazione del mistero di cui abbiamo così bisogno.
Si potrebbe dire così: abbiamo fatto un certo percorso che non sto a ripetere, seguendo grossomodo il percorso suggerito da Giussani ne “La coscienza religiosa nell’uomo moderno”, e siamo arrivati all’ultimo incontro, dopo Verga e Pirandello, a riconoscere che questa modernità mostra ormai la corda. A questo punto io volevo che il discorso nostro si chiudesse con un accenno di speranza. Dopo nove serate dove abbiamo percorso la storia spirituale dell’occidente accorgendoci, guardando e vedendo anche il miserando fallimento di una modernità che orgogliosamente ha preteso di costituirsi prima senza Dio e poi contro Dio, che si fa? A che responsabilità siamo chiamati? O, se preferite, da dove ricominciare?
Ecco, io volevo tentare di chiudere il percorso rispondendo a questa domanda che credo sia l’urgenza con cui tutti siamo qui. Da dove ricominciare? Cosa si deve fare quando ci si accorge o si prende atto di un momento della civiltà, della storia, particolarmente difficile e faticoso da un certo punto di vista un momento dove il male e la menzogna sembrano dominare, sembra vincere?
Allora, come prima cosa vi leggo, anche se lo conoscerete tutti, il brano noto come “Bisogna salvare il seme” di Guareschi.
Don Camillo spalancò le braccia [rivolto al crocifisso]: “Signore, cos’è questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione?”.
“Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli uomini sarebbe dunque fallita perché la malvagità degli uomini è più forte della bontà di Dio?”.
“No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano: amore, bontà, pietà, onestà, pudore, speranza. E fede. Cose senza le quali non si può vivere. Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si troverà come il bruto delle caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo sarà quello del bruto delle caverne […] Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi?”.
Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi possiede ancora la fede e mantenerla intatta. Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più, ogni giorno nuove anime inaridiscono perché abbandonate dalla fede. Ogni giorno di più uomini di molte parole e di nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la fede degli altri. Uomini di ogni razza, di ogni estrazione, d’ogni cultura”.
Bisogna salvare il seme. Credo che in tanta nostra letteratura, in tanti nostri grandi, Guareschi per primo, ci sia questa dedizione al bene, all’umanità. Ho accennato la volta scorsa quando abbiamo chiuso che certamente abbiamo patito, forse adesso un po’ di meno, una grave e pesantissima censura culturale per cui del bene se n’è parlato poco, di certi autori pochissimo. Alcuni sono stati censurati in modo clamoroso e credo il tempo, che è galantuomo, ne mostrerà invece il valore.
Per documentare questa grandezza di alcuni, di Guareschi ovviamente, almeno di don Camillo e Peppone qualcosa conosciamo, non sto a riprendere episodi, figure e immagini bellissime. Vi sottolineo solo una cosa che riprendo alla fine: in fondo il modo con cui Guareschi tratta i suoi personaggi è come se Peppone e don Camillo difendessero allo stesso modo il popolo. Stasera il tema vorrei che fosse “il popolo”, “la gente”. Vi ricordate la volta scorsa? Abbiamo proprio parlato di un sentimento della fede che il popolo in qualche modo ha incarnato fino a qualche tempo fa. Mi colpiva anche solo considerare che Guareschi nasce nel 1908 e muore nel ’68, la data che sembrerebbe anche l’anno della scomparsa del mondo che lui ha raccontato. Invece grazie a Dio quel mondo sopravvive in chi lo vive, sopravvive in chi, e in questo senso è modernissimo, ha deciso di salvare il seme. Cioè di restituire a sé e agli altri, per come si può, ciò che la nostra tradizione ci ha consegnato.
E di Guareschi vorrei soffermarmi sull’introduzione che lui fa al suo primo grande libro “Mondo piccolo”, il primo della lunghissima serie. Non so se lo ricordate, ma c’è una lunga introduzione che Guareschi fa, dove racconta tre storielle. Lui cerca di spiegare che sentimento potessero avere quei grandi, cattolici o non cattolici che di quel popolo hanno amato l’espressione, la carnalità, i canti e il vino e la famiglia, il lavoro, la terra, insomma quel sentimento della vita che un popolo ha incarnato fino a settant’anni fa, popolo che è stato guardato e riconosciuto nel suo valore da alcuni e distrutto da altri. Guareschi per dare l’idea di quel popolo fa una lunga premessa ai suoi racconti dove racconta tre storie, che sono un capolavoro.
La prima storia riguarda suo padre. Nella sua famiglia erano undici o dodici, e vivevano al Boscaccio.
Io abitavo al Boscaccio, nella Bassa, con mio padre, mia madre e i miei undici fratelli: io, che ero il più vecchio, toccavo appena i dodici anni e Chico che era il più giovane toccava appena i due. Mia madre mi consegnava ogni mattina una cesta di pane, un sacchetto di mele o di castagne dolci, mio padre ci metteva in riga nell’aia e ci faceva dire ad alta voce il Pater Noster: poi andavamo con Dio e tornavamo al tramonto. I nostri campi non finivano mai e avremmo potuto correre anche una giornata intera senza sconfinare. Mio padre non avrebbe avuto neppure mezza parola anche se noi gli avessimo calpestato tre intere biolche di frumento in germoglio o se gli avessimo divelto un filare di viti. Eppure noi sconfinavamo sempre e ci davamo parecchio da fare. Anche Chico, che aveva due anni appena e aveva la bocca piccolina e rossa e gli occhi grandi con lunghe ciglia e ricciolini sulla fronte come un angioletto, non si faceva certamente scappare un papero quando gli arrivava a tiro. Poi, ogni mattina, appena partiti noi, venivano alla fattoria delle vecchie con sporte piene di paperi, di gallinelle, di pulcini assassinati, e mia madre, per ogni capo morto, dava un capo vivo. Noi avevamo mille galline che razzolavano per i nostri campi, ma quando si doveva mettere qualche pollo a bollire nella pentola, bisognava comprarlo. Mia madre scuoteva il capo e continuava a cambiare paperi vivi con paperi morti. Mio padre faceva la faccia scura, si arricciava i lunghi baffi e interrogava brusco le donnette per sapere se si ricordavano chi dei dodici. era stato a fare il colpo. Quando qualcuna gli diceva che era stato Chico, il più piccolino, mio padre si faceva raccontare per tre o quattro volte la storia, e come aveva fatto a lanciare il sasso, e se era un sasso grosso, e se aveva colpito il papero al primo colpo. Queste cose le ho sapute tanto tempo dopo: allora non ci si pensava. Ricordo che una volta mentre io, lanciato Chico contro un papero che passeggiava come uno stupido in mezzo a un praticello spelacchiato, stavo con gli altri dieci appostato dietro un cespuglione, vidi mio padre a venti passi di distanza che fumava la pipa all’ombra di una grossa quercia. Quando Chico ebbe spacciato il papero, mio padre se ne andò tranquillamente con le mani in tasca e io e i miei fratelli ringraziammo il buon Dio.
«Non si è accorto di niente» dissi io sottovoce ai ragazzi. Ma allora io non potevo capire che mio padre ci aveva pedinati per tutta la mattinata, nascondendosi come un ladro, pur di riuscire a vedere come Chico ammazzava i paperi. Ma io sto uscendo dal seminato: questo è il difetto di chi ha troppi ricordi. Io devo dirvi che il Boscaccio era un paese dove non moriva mai nessuno, per via di quell’aria straordinaria che vi si respirava. Al Boscaccio sembrava quindi impossibile che un bambino di due anni potesse ammalarsi. Invece Chico si ammalò sul serio. Una sera, mentre stavamo per tornare a casa, Chico si sdraiò improvvisamente per terra e cominciò a piangere. Poi smise di piangere e si addormentò. Non si volle svegliare e io lo presi in braccio. Chico scottava, sembrava pieno di fuoco: allora noi tutti provammo una paura terribile. Il sole tramontava e il cielo era nero e rosso, le ombre lunghe. Abbandonammo Chico in mezzo all’erba e fuggimmo urlando e piangendo come se qualcosa di terribile e di misterioso ci inseguisse. «Chico dorme e scotta!… Chico ha il fuoco dentro la testa!» singhiozzai io appena mi trovai davanti a mio padre. Mio padre, lo ricordo bene, staccò la doppietta dalla parete, la caricò, se la mise sottobraccio, e ci seguì senza dir nulla, e noi camminammo stretti attorno a lui e non avevamo più paura perché nostro padre era capace di fulminare un leprotto a ottanta metri di distanza. Chico era abbandonato in mezzo all’erba scura, e con la sua lunga veste chiara e i suoi ricciolini sulla fronte sembrava un angelo del buon Dio cui si fosse guastata un’aluzza e che fosse caduto nel trifoglio. Al Boscaccio non moriva mai nessuno, e quando la gente seppe che Chico stava male, tutti provarono un enorme sgomento. Anche nelle case si parlava sottovoce. Per il paese bazzicava un forestiero pericoloso e nessuno di notte si azzardava ad aprire una finestra per paura di vedere, nell’aia imbiancata dalla luna, aggirarsi la vecchia vestita di nero e con la falce in mano. Mio padre mandò a prendere col calessino tre o quattro dottori famosi. E tutti toccarono Chico e gli appoggiarono l’orecchio alla schiena, poi guardarono mio padre senza dir niente. Chico continuava a dormire e a scottare, e il suo viso era diventato più bianco del lenzuolo. Mia madre piangeva in mezzo a noi e non voleva più mangiare; mio padre non si sedeva mai e continuava ad arricciarsi i baffi, senza parlare. Il quarto giorno i tre ultimi dottori, che erano arrivati insieme, allargarono le braccia e dissero a mio padre: «Non c’è che il buon Dio che possa salvare il vostro bambino». Ricordo che era mattina: mio padre fece un cenno con la testa e noi lo seguimmo nell’aia. Poi con un fischio chiamò i famigli: erano cinquanta fra uomini, donne e bambini. Mio padre era alto, magro e potente, con lunghi baffi, un grande cappello, la giacca attillata e corta, i calzoni stretti alla coscia e gli stivali alti. (Da giovane mio padre era stato in America, e vestiva all’americana.) Faceva paura quando si piantava a gambe larghe davanti a qualcuno. Mio padre si piantò a gambe larghe davanti ai famigli e disse: «Soltanto il buon Dio può salvare Chico. In ginocchio: bisogna pregare il buon Dio di salvare Chico».
Tutti ci inginocchiammo e cominciammo a pregare ad alta voce il buon Dio. Le donne dicevano a turno delle cose e noi e gli uomini rispondevamo: «Amen». Mio padre rimase a braccia conserte, fermo come una statua davanti a noi fino alle sette di sera, e tutti pregavano perché avevano paura di mio padre e perché volevano bene a Chico. Alle sette di sera, mentre il sole cominciava a tramontare, venne una donna a chiamare mio padre. Lo seguii. I tre dottori erano seduti pallidi attorno al letto di Chico: «Peggiora» disse il più anziano. «Non arriverà a domattina.» Mio padre non disse nulla, ma sentii che la sua mano stringeva forte la mia. Uscimmo: mio padre prese la doppietta, la caricò a palla, se la mise a tracolla, prese un grosso pacco, me lo consegnò. «Andiamo» disse. Camminammo attraverso i campi: il sole si era nascosto dietro l’ultima boscaglia. Scavalcammo il muretto di un giardino e bussammo a una porta. Il prete era solo in casa e stava mangiando al lume della lucerna. Mio padre entrò senza levarsi il cappello. «Reverendo» disse mio padre «Chico sta male e soltanto il buon Dio può salvarlo. Oggi, per dodici ore, sessanta persone hanno pregato il buon Dio, ma Chico peggiora e non arriverà a domattina.» Il prete guardava mio padre con gli occhi sbarrati. «Reverendo» continuò mio padre «tu soltanto puoi parlare al buon Dio e fargli capire come stanno le cose. Fagli capire che se Chico non guarisce io gli butto all’aria tutto. In quel pacco ci sono cinque chili di dinamite da mina. Non resterà più in piedi un mattone di tutta la chiesa. Andiamo!» Il prete non disse parola: si avviò seguito da mio padre, entrò in chiesa, si inginocchiò davanti all’altare, giunse le mani. Mio padre stava in mezzo alla chiesa, col fucile sottobraccio, a gambe larghe, piantato come un macigno. Sull’altare ardeva una sola candela e tutto il resto era buio. Verso mezzanotte mio padre mi chiamò: «Va’ a vedere come sta Chico e torna subito». Volai fra i campi, arrivai a casa col cuore in gola. Poi ritornai e correvo ancora più forte. Mio padre era ancora lì, fermo, a gambe larghe, col fucile sottobraccio e il prete pregava bocconi sui gradini dell’altare. «Papà» gridai col mio ultimo fiato. «Chico è migliorato! Il dottore ha detto che è fuori pericolo! Il miracolo! Tutti ridono e sono contenti!» Il prete si alzò: sudava e il suo viso era disfatto. «Va bene» disse bruscamente mio padre.
Poi, mentre il prete guardava a bocca aperta, si tolse dal taschino un biglietto da mille e l’infilò nella cassetta delle elemosine. «Io i piaceri li pago» disse mio padre. «Buona sera.» Mio padre non si vantò mai di questa faccenda, ma al Boscaccio c’è ancora oggi qualche scomunicato il quale dice che, quella volta, Dio ebbe paura.
Stupendo! Meraviglioso perché io non so se in queste serate insieme vi ho letto il branetto degli Atti degli Apostoli che racconta di Eutico, quello che è caduto dal terzo piano. Un brano che ho scoperto qualche mese fa e che mi ha colpito tantissimo. Sull’educazione, che dice così:
Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli, e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove eravamo riuniti, c’erano molte lampade; un giovane di nome Eutico, che stava seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo, poiché Paolo tirava in lungo il suo dire; egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Ma Paolo scese, si gettò su di lui e, abbracciatolo, disse: «Non vi turbate, perché la sua anima è in lui». Poi risalì, spezzò il pane e prese cibo; e dopo aver ragionato lungamente sino all’alba, partì. Il giovane fu ricondotto vivo, ed essi ne furono oltremodo consolati.
Io sono rimasto impressionatissimo, e quante volte in questi mesi l’ho citato a preti e suore, perché pensate che lì c’era San Paolo, il migliore! E, posso immaginare che se erano i primi cristiani che si riunivano ad ascoltare San Paolo magari quelli sono stati mangiati dai leoni la settimana dopo, magari hanno dato davvero la vita per Cristo! Non degli adulti sfigati, sbagliati, proprio cristiani tosti della prima ora. E immagino avranno parlato di cose bellissime, ma non hanno intercettato l’interesse di quel ragazzino che c’era lì.
Me lo figuro, come mi capita tante volte andando in giro a parlare, che inizialmente si siede davanti per fare l’adulto. Poi però si stufa dopo tre minuti e si sposta, poi si mette in fondo alla sala e poi per respirare un attimo si siede sul davanzale e intanto io continuo a parlare, parlare ma a quello non gliele frega niente, si addormenta, cade e muore. È la fotografia di tanta Chiesa dove tanti adulti sinceramente di fede, parlano di cose santissime tra loro, fanno delle cose bellissime tra loro, ma non parlano più a nessuno. E i ragazzi in particolare si addormentano e cadono morti.
Poi però dice che Paolo, accortosi dell’accaduto, interrompe quello che sta facendo e scende giù. Lo abbraccia e dice: “Vi sembra morto, ma c’è qualcosa in lui che vive. Dobbiamo scommettere su qualcosa che in lui vive”. E a me questo sembra il principio educativo più bello che abbia mai sentito. Perché anche quando i nostri ragazzi sembrano morti, l’educatore è quello che scommette sul loro cuore, che vive perché gliel’ha dato Dio. E allora risale, riprende la messa, parla fino all’alba e nel frattempo il ragazzo era tornato in vita. Impressionante, ma ci vuole un adulto che facendo quel che fa è chiamato ad intercettare il desiderio di una gioventù alla quale il linguaggio che usiamo, i riti che proponiamo, non bastano più, bisogna fare altro. Tutto quello che abbiamo detto fin qui della modernità, della chiesa in uscita e del coraggio di ripartire dall’io, mi sembra fotografato in quel brano che fa il paio con questo di Guareschi.
Perché Chico che muore sono i nostri figli, i nostri giovani. Bisogna prendere il fucile, andare in Chiesa, prendere un prete e farlo pregare. Io sono un po’ guerrafondaio e un po’ mi è rimasta l’idea che il cristianesimo sia una cosa virile, per uomini e donne veri. L’immagine della suora che all’asilo ci spiegava che la cresima ci fa “soldati di Cristo” mi gasava in un modo! Mi sembrava molto più interessante la cresima della comunione, nella mia fantasia. La fede non come una cosa per pappe molli, e l’ha detto anche Gesù: “il regno di Dio è dei violenti”. In questo senso bisogna forzare la mano a Dio qualche volta, spingere il proprio bisogno, il proprio grido fino a questa immagine. Insieme a quella di un popolo intero che per un pomeriggio ha pregato, nelle case, il padre che chiama a raccolta la sua gente per pregare! Ma non basta, bisogna che ci sia la Chiesa, bisogna che sia la Chiesa inevitabile luogo della Sua presenza, che ci aiuta a parlare con Dio, che fa accadere il miracolo. Queste due immagini mi hanno sempre entusiasmato. Il popolo non è a caso, è guidato, dentro al quale Dio a qualcuno ha chiesto di rappresentarli tutti, di offrire il sacrificio per il popolo, di parlare a Dio a nome del popolo, dei suoi bisogni, delle sue sofferenze. Questa è la messa per noi.
La seconda storia che non leggo invece riguarda il rapporto con la terra, meravigliosa e violentissima anche questa. E la terza è lui che dice che quando va all’osteria si va a bere e a dire quattro stupidate ma quanto a donne…
Ragazze? No, niente ragazze. Se si tratta di fare un po’ di baracca all’osteria, una cantata, sempre pronto. Niente altro, però: io ho già la mia ragazza che mi aspetta tutte le sere vicino al terzo palo del telegrafo lungo la strada del Fabbricone. Io avevo quattordici anni e tornavo a casa in bicicletta per la strada del Fabbricone. Un albero di prugne lasciava uscire un ramo da un muretto e, una volta, mi fermai. Una ragazza uscì dai campi con un cesto in mano e io la chiamai. Doveva avere un diciannove anni perché era molto più alta di me e ben formata. «Tu fammi la scaletta» le dissi. La ragazza depose il cesto ed io mi issai sulle sue spalle. Il ramo era stracarico e io mi riempii la camicia di prugne gialle.
«Allarga il grembiule che facciamo a mezzo» dissi alla ragazza. La ragazza rispose che non occorreva.
«Non ti piacciono le prugne?» domandai.
«Sì, ma io le posso staccare quando voglio» spiegò.
«La pianta è mia: io abito lì». Io allora avevo quattordici anni e portavo í calzoni a mezza gamba: ma facevo il manovale di muratore e non avevo paura di nessuno. Lei era molto più alta di me e formata come una donna.
«Tu prendi in giro la gente» esclamai guardandola male «ma io sono anche capace di romperti la faccia, brutta spilungona.» Non fiatò neanche.
La incontrai due sere dopo, sempre sulla stradetta.
«Ciao, spilungona!» le gridai. Poi le feci un versaccio con la bocca. Adesso non sarei più capace, ma allora li facevo meglio del capomastro, che aveva imparato a Napoli. La incontrai delle altre volte, ma non le dissi più niente, una sera finalmente perdetti la pazienza, saltai giù dalla bicicletta e le sbarrai il passo.
«Si potrebbe sapere che cos’hai da guardarmi così?» le domandai buttandomi la visiera del berretto tutta da una parte. La ragazza spalancò due occhi chiari come l’acqua, due occhi come non ne avevo visti mai.
«Io non ti guardo» rispose timidamente;
Rimontai sulla bicicletta.
«Sta’ in gamba, spilungona!» le gridai.
«Io non scherzo.»
Una settimana dopo la vidi di lontano che stava camminando davanti a me a fianco di un giovanotto e mi venne una gran rabbia. Mi alzai in piedi sui pedali e cominciai a spingere come un dannato: a due metri dal giovanotto sterzai, e nel passargli vicino gli diedi una spallata che lo appiccicò lungo disteso per terra come una buccia di fico. Sentii che mi gridava dietro del figlio di donnaccia, e io allora smontai e appoggiai la bicicletta a un palo telegrafico, vicino a un mucchio di ghiaia. Lo vidi che mi correva incontro come un maledetto: era un giovanotto di vent’anni e con un pugno mi avrebbe spaccato. Ma io faceva il manovale di muratore e non avevo paura di nessuno. Quando fu ora gli sparai una sassata che lo prese dritto in faccia. Mio padre era un meccanico straordinario e quando aveva una chiave inglese in mano faceva scappare un paese intero: però anche mio padre, se vedeva che io riuscivo a raccattare un sasso, faceva dietro front e per picchiarmi aspettava che io dormissi. Ed era mio padre! Figurati quel baggiano là! Gli riempii la faccia di sangue, poi quando ne ebbi voglia saltai sulla bicicletta e filai via.
Per un paio di sere girai alla larga, poi, alla terza, ritornai per la strada del Fabbricone, e appena vidi la ragazza la raggiunsi e smontai all’americana, saltando giù dal sellino per di dietro. I ragazzi del giorno d’oggi fanno ridere quando vanno in bicicletta: parafanghi, campanelli, freni, fanali elettrici, cambi di velocità e poi? Io avevo una Frera con sopra le croste di ruggine, ma per scendere i sedici gradini della piazza mica smontavo: pigliavo il manubrio alla Gerbi e volavo giù come un fulmine. Smontai e mi trovai davanti alla ragazza: avevo la sporta attaccata al manubrio e cavai fuori una martellina.
«Se ti trovo ancora con un altro, ti spacco la testa a te e a lui» dissi. La ragazza mi guardò con quei suoi maledetti occhi chiari come l’acqua.
«Perché dici così?» mi domandò sottovoce.
Non lo sapevo, ma cosa importa?
«Perché sì» risposi. «Tu devi andare a spasso da sola o se no con me.»
«Io ho diciannove anni e tu quattordici al massimo» disse la ragazza. «Se tu ne avessi almeno diciotto sarebbe un’altra cosa. Adesso io sono una donna e tu sei un ragazzo.»
«E tu aspetta fino a quando avrò diciotto anni» gridai.
«E bada a non farti vedere con qualcuno o sei fritta.»
Allora io facevo il manovale di muratore e non avevo paura di niente: quando sentivo parlare di donne, pigliavo su e andavo via. Non me ne importava un fico secco delle donne: però quella là non doveva far la stupida con gli altri. Rividi la ragazza per quasi quattro anni, tutte le sere meno la domenica. Era sempre là, appoggiata al terzo palo del telegrafo, sulla strada del Fabbrícone. Se pioveva aveva il suo bravo ombrello aperto.
Non mi fermai neanche una volta.
«Ciao» le dicevo passando.
«Ciao» mi rispondeva. Il giorno in cui compii diciotto anni smontai dalla bicicletta.
«Io ho diciotto anni» le dissi. «Adesso puoi venire a spasso con me. Se fai la stupida ti spacco la testa.»
Lei aveva adesso ventitré anni e s’era fatta una donna completa: però aveva sempre gli stessi occhi chiari come l’acqua e parlava sempre a voce bassa, come prima.
«Tu hai diciotto anni» mi rispose «ma io ne ho ventitré. I ragazzi mi prenderebbero a sassate se mi vedessero insieme con uno così giovane.»
Lasciai andare la bicicletta per terra, rimediai un sasso piatto e le dissi: «Lo vedi quell’isolatore là, il primo sul terzo palo?». Fece cenno di sì con la testa. Lo centrai netto e rimase soltanto il gancio di ferro, nudo come un verme.
«I ragazzi» esclamai «prima di prenderci a sassate dovranno saper lavorare così.»
«Facevo per dire» spiegò la ragazza.
«Non sta bene che una donna vada in giro con un minorenne. Se tu avessi almeno fatto il soldato!…»
Mi girai la visiera del berretto tutta a sinistra: «Ragazza mia, per caso mi avresti preso per un torototella? Quando avrò fatto il soldato, io avrò ventun anni e tu ne avrai ventisei: e allora ricomincerai la storia».
«No» rispose la ragazza «fra diciotto e ventitré è una cosa, e fra ventuno e ventisei è un’altra. Più si va avanti e meno gli anni di differenza contano. Un uomo che abbia ventun anni o che ne abbia ventisei è la stessa cosa.»
Mi pareva un ragionamento giusto: però io non ero il tipo che si lasciasse menare per il naso.
«Allora ne riparleremo quando avrò fatto il soldato» dissi saltando in sella. «Però bada che se quando ritorno non ti trovo, vengo a spaccarti la testa anche sotto il letto di tuo padre.»
Tutte le sere la vedevo ferma al terzo palo della luce e io non scesi mai. Le dicevo buona sera e lei mi rispondeva buona sera.
Quando mi chiamarono io le gridai. «Domani parto per il militare».
«Arrivederci» rispose la ragazza. Adesso non è il caso di ricordare tutta la mia vita militare: macinai diciotto mesi di naia e al reggimento ero lo stesso di quando stavo a casa. Avrò fatto tre mesi di riga: si può dire che tutte le sere o ero consegnato o ero dentro. Appena passati i diciotto mesi mi mandarono a casa. Arrivai nel pomeriggio tardi e, senza neanche mettermi in borghese, saltai sulla bicicletta e andai verso la strada del Fabbricone. Se quella trovava ancora delle storie, la facevo fuori a biciclettate nella schiena. Cominciava a farsi scuro lentamente e io andavo come un fulmine pensando dove diavolo sarei andato a stanarla fuori.
Ma non dovetti cercare un bel niente, invece: la ragazza era là che mi aspettava puntualmente sotto il terzo palo del telegrafo. Era precisa come l’avevo lasciata, e gli occhi erano gli stessi, identici. Smontai davanti a lei.
«Ho finito» le dissi mostrandole il foglio di congedo. «C’è l’Italia seduta e vuol dire congedo illimitato. Dove c’è invece l’Italia in piedi significa congedo provvisorio.»
«È una bella cosa» rispose la ragazza.
Avevo corso come un Dio-ti-fulmini e avevo la gola secca. «Si potrebbe avere un paio di quelle prugne gialle di quella volta?» domandai.
La ragazza sospirò: «Mi dispiace tanto, ma la pianta è bruciata».
«Bruciata?» mi meravigliai.
«Da quando in qua le piante di prugne bruciano?»
«È stato sei mesi fa» rispose la ragazza. «Una notte prese fuoco il pagliaio e bruciò la casa e tutte le piante dell’orto, come zolfanelli. Tutto è bruciato: dopo due ore c’erano soltanto i muri. Li vedi?»
Guardai là in fondo e vidi un pezzo di muro nero con una finestra che si apriva sul cielo rosso.
«E tu?» domandai. «Anch’io» rispose con un sospiro «anch’io come tutto il resto. Un mucchietto di cenere e buona notte al secchio.»
Io guardai la ragazza che stava appoggiata contro il palo del telegrafo: la guardai fisso e, attraverso la sua faccia e il suo corpo, vidi la venatura del legno del palo e l’erba del fosso. Le misi un dito sulla fronte e toccai il palo del telegrafo. «Ti ho fatto male?» domandai.
«Niente male.»
Rimanemmo un po’ in silenzio mentre il cielo diventava di un rosso sempre più cupo.
«E allora?» dissi alla fine.
«Ti ho aspettato» sospirò la ragazza «per farti vedere che la colpa non è mia. Adesso, posso andare?»
Io allora avevo ventun anni e facevo il presentat’armi con un pezzo da settantacinque. Le ragazze quando mi vedevano passare, buttavano in fuori il petto come se si trovassero alla rivista del generale, e mi guardavano fin che avevano una fessura d’occhio.
«Allora?» ripeté la ragazza con voce bassa. «Debbo andare?»
«No» le risposi io. «Tu devi aspettarmi fin che ho finito quest’altro servizio. In giro non mi prendi, bella mia.»
«Va bene» disse la ragazza. E mi parve che sorridesse.
Ma a me queste stupidaggini non vanno tanto e rimontai subito in bicicletta.
Adesso sono ormai dodici anni che tutte le sere ci vediamo. Io passo e neanche smonto dalla bicicletta «Ciao».
«Ciao.»
Capite? Se si tratta di fare una cantata all’osteria, un po’ di baracca, sempre pronto. Niente altro, però: io ho già la mia ragazza che mi aspetta tutte le sere vicino al terzo palo del telegrafo sulla strada del Fabbricone.
Capirete che per un dantista come me una ragazza i cui occhi sono pezzi di cielo “lucevan gli occhi suoi più che la stella”, una ragazza che muore mentre ti aspetta e una ragazza a cui chiedi di aspettarti proprio perché è morta perché la vuoi rivedere, è quanto di più dantesco io possa riuscire a immaginare. In questo terzo racconto un amore e una fede incrollabili nella vita, una tradizione che passa attraverso la terra, che è fatta di amore alla propria terra e un amore che è per l’eternità, tenuto d’occhio per tutta la vita e che è l’unico vero grande amore a cui terrà fede per sempre è esattamente quello che in Dante è cantato, qui raccontato con la saggezza e la sapienza di un figlio di contadini. Ma è la stessa cosa. Quella fede che abbiamo ricevuto è fatta di queste cose: di un amore vero per la donna tanto che ti cambia la vita, tanto che è una fedeltà che dura dopo la morte, che dura per sempre. Che diventa un compito rispetto alla terra, rispetto ai giovani, al futuro e ai propri figli.
Sembrano tre storielle ma sono la grande premessa per capire tutto il mondo di Guareschi e tutta la nostra tradizione.
Seconda questione: se si tratta di salvare questo seme, in tempi difficili e terribili, salvare l’unica cosa che conta, chi lo può salvare? Lui dice che bisogna fare come il contadino che salva il seme e aspetta il momento buono.
In Buzzati c’è una percezione così acuta che il seme da salvare sia il cuore che Dio ci dà, il desiderio. O almeno io lo leggo così, poi ognuno avrà la sua idea. È il desiderio, questa nostalgia con cui l’uomo viene al mondo di una cosa grande per cui si sente fatto e per cui l’unico compito che abbiamo, se si tratta di salvare il seme si tratta di questo: salvare la natura dell’uomo che è tensione all’infinito, all’essere. Abbiamo detto con altri poeti e con altre parole: tensione alla felicità, al bene, a qualcosa di grande.
Allora leggere Buzzati è come guardare la vita nei suoi particolari anche più infimi, fino allo scarafaggio, guardare la vita, la giornata e le cose della vita sempre con dentro questo amore per la verità. Cioè non poterne della menzogna, non poter mentire né a sé stessi né agli altri, dire la verità, dar la vita per la verità è l’unico compito che abbiamo. Questo salva il seme perché la verità è che il nostro cuore è fatto per Dio, per un’amicizia grande, per il bene, per la bellezza. E allora se abbiamo un compito ed è quello di salvare il seme, bisogna cercare di vivere prima di tutto noi all’altezza del desiderio.
Le novelle di Buzzati, sia quelle terribili, come quella dei topi che se la leggo troppo non mi fa dormire la notte. È la storia di una famiglia presso cui il protagonista va in vacanza una settimana all’anno. Di anno in anno si accorge di una cosa che gli dà un po’ fastidio, a volte chiede, a volte non osa… Insomma, c’è un topolino il primo anno, l’anno dopo di più, quello dopo ancora sente dei rumori in soffitta… Questo problema aumenta sempre e lui cerca di parlare con i padroni di casa ma questi quasi si risentono di essere richiamati sulla presenza di questi topi che invece che combatterli in qualche modo li si tiene buoni. Tant’è che il figlio maggiore, Giorgio, un giorno confessa: “Sai il papà dev’essere un po’ fuori di testa. L’ho scoperto a volte buttare una salsiccia nella botola che va in cantina quasi per tenersi buoni questi topastri che girano per la casa”.
Il racconto finisce con lui che va per l’ultima volta in vacanza non trovando più né lui né lei ma solo il figlio maggiore che in qualche modo gli ha sempre detto la verità e gli chiede: “Ma dove sono il papà e la mamma? Si sentono rumori sinistri…” Il figlio gli chiede di seguirlo, solleva la botola, butta uno zolfanello acceso perché per un attimo si veda la scena. La scena è questa:
Tacque. E attraverso il pavimento giunse un suono difficilmente descrivibile. Un brusìo, un cupo fremito, un rombo sordo come di materia inquieta e viva che fermenti. E frammezzo pure delle voci, piccole grida acute, fischi, sussurri. “Ma quanti sono?” chiesi con un brivido.
“Chissà, milioni forse. Adesso guarda ma fa’ presto”.
Accese un fiammifero e sollevato il coperchio della botola lo lasciò cadere giù nel buco.
Per un attimo io vidi. In una specie di caverna un frenetico brulichio di forme nere accavallantesi in smaniosi vortici. E c’era in quel laido tumulto una potenza, una vitalità infernale che nessuno avrebbe mai più fermato. I topi.
Vidi anche un luccicare di pupille, migliaia e migliaia rivolte in su che mi fissavano cattive. Ma Giorgio chiuse il coperchio con un tonfo.
E adesso? Perché Giovanni ha scritto di non potere più invitarmi? Cosa è successo? Avrei la tentazione di fargli una visita, pochi minuti basterebbero tanto per sapere, ma non ne ho il coraggio.
Da varie fonti mi sono giunte strane voci, talmente strane che la gente le ripete come favole e ne ride. Ma io non rido.
Dicono per esempio che i due vecchi genitori siano morti, dicono che nessuno esca più dalla villa e che i viveri glieli porti un uomo del paese lasciando il pacco al limite del bosco.
Dicono che nella villa nessuno possa entrare, che enormi topi l’abbiano occupata e che i Corio ne siano schiavi.
Un contadino che si è avvicinato, ma non molto eh, dice di aver intravisto la signora Corio, la moglie del mio amico, quella dolce e amabile creatura, in cucina, accanto al fuoco vestita come una pezzente e rimestava in un immenso calderone mentre intorno grappoli fetidi di topi la incitavano avidi di cibo. Sembrava stanchissima e afflitta. Come scorse l’uomo che guardava, gli fece con le mani un gesto sconsolato quasi volesse dire “non datevi pensiero, è troppo tardi. Per noi non ci sono più speranze”.
La lotta con il male è una lotta quotidiana. Questo racconto mi impressiona perché parte da un topino piccolo piccolo che passava, che gli faceva perfino tenerezza anni prima. E invece il male, il topolino, si moltiplica e cominci ad averne paura e poi non lo domini più. È una lotta, una vera lotta quotidiana.
Questo è uno dei più terribili dei suoi racconti perché pone il problema del male.
Vi leggo un altro dei più famosi “Il disco si posò”, ma leggeteveli tutti, sono bellissimi.
Era sera e la campagna già mezza addormentata, dalle vallette levandosi lanugini di nebbia e il richiamo della rana solitaria che però subito taceva (l’ora che sconfigge anche i cuori di ghiaccio, col cielo limpido, l’inspiegabile serenità del mondo, l’odor di fumo, i pipistrelli e nelle antiche case i passi felpati degli spiriti), quand’ecco il disco volante si posò sul tetto della chiesa parrocchiale, la quale sorge al sommo del paese.
All’insaputa degli uomini che erano già rientrati nelle case, l’ordigno si calò verticalmente giù dagli spazi, esitò qualche istante, mandando una specie di ronzio, poi toccò il tetto senza strepito, come colomba. Era grande, lucido, compatto, simile a una lenticchia mastodontica; e da certi sfiatatoi continuò a uscire zufolando un soffio. Poi tacque e restò fermo, come morto.
Lassù nella sua camera che dà sul tetto della chiesa, il parroco, don Pietro, stava leggendo, col suo toscano in bocca. All’udire l’insolito ronzio, si alzò dalla poltrona e andò ad affacciarsi al davanzale. Vide allora quel coso straordinario, colore azzurro chiaro, diametro circa dieci metri.
Non gli venne paura, né gridò, neppure rimase sbalordito. Si è mai meravigliato di qualcosa il fragoroso e imperterrito don Pietro? Rimase là, col toscano, ad osservare. E quando vide aprirsi uno sportello, gli bastò allungare un braccio: là al muro c’era appesa la doppietta.
Ora sui connotati dei due strani esseri che uscirono dal disco non si ha nessun affidamento. È un tale confusionario, don Pietro. Nei successivi suoi racconti ha continuato a contraddirsi. Di sicuro si sa solo questo: ch’erano smilzi e di statura piccola, un metro un metro e dieci. Però lui dice anche che si allungavano e si accorciavano come fossero di elastico. Circa la forma, non si è capito molto: «Sembravano due zampilli di fontana, più grossi in cima e stretti in basso» così don Pietro «sembravano due spiritelli, sembravano due insetti, sembravano scopette, sembravano due grandi fiammiferi.» «E avevano due occhi come noi?» «Certo, uno per parte, però piccoli.» E la bocca? e le braccia? e le gambe? Don Pietro non sapeva decidersi: «In certi momenti vedevo due gambette e un secondo dopo non le vedevo più… Insomma, che ne so io? Lasciatemi una buona volta in pace!».
Zitto, il prete li lasciò armeggiare col disco. Parlottavano tra loro a bassa voce, un dialogo che assomigliava a un cigolio. Poi si arrampicarono sul tetto, che ha una moderatissima pendenza, e raggiunsero la croce, quella che è in cima alla facciata. Ci girarono intorno, la toccarono, sembrava prendessero misure. Per un pezzo don Pietro lasciò fare, sempre imbracciando la doppietta. Ma all’improvviso cambiò idea.
«Ehi!» gridò con la sua voce rimbombante. «Giù di là, giovanotti. Chi siete?»
I due si voltarono a guardarlo e sembravano poco emozionati. Però scesero subito, avvicinandosi alla finestra del prevosto. Poi il più alto cominciò a parlare.
Don Pietro – ce lo ha lui stesso confessato – rimase male: il marziano (perché fin dal primo istante, chissà perché, il prete si era convinto che il disco venisse da Marte; né pensò di chiedere conferma), il marziano parlava una lingua sconosciuta. Ma era poi una vera lingua? Dei suoni, erano, per la verità non sgradevoli, tutti attaccati senza mai una pausa. Eppure il parroco capì subito tutto, come se fosse stato il suo dialetto. Trasmissione del pensiero? Oppure una specie di lingua universale automaticamente comprensibile?
«Calmo, calmo» lo straniero disse «tra poco ce n’andiamo. Sai? Da molto tempo noi vi giriamo intorno, e vi osserviamo, ascoltiamo le vostre radio, abbiamo imparato quasi tutto. Tu parli, per esempio, e io capisco. Solo una cosa non abbiamo decifrato. E proprio per questo siamo scesi. Che cosa sono queste antenne? (e faceva segno alla croce). Ne avete dappertutto, in cima alle torri e ai campanili, in vetta alle montagne, e poi ne tenete degli eserciti qua e là, chiusi da muri, come se fossero vivai. Puoi dirmi, uomo, a cosa servono?»
«Ma sono croci!» fece don Pietro. E allora si accorse che quei due portavano sulla testa un ciuffo, come una tenue spazzola, alta una ventina di centimetri. No, non erano capelli, piuttosto assomigliavano a sottili steli vegetali, tremuli, estremamente vivi, che continuavano a vibrare. O invece erano dei piccoli raggi, o una corona di emanazioni elettriche?
«Croci» ripeté, compitando il forestiero. «E a che cosa servono?»
Don Pietro posò il calcio della doppietta a terra, che gli restasse però sempre a portata di mano. Si drizzò quindi in tutta la statura, cercò di essere solenne:
«Servono alle nostre anime» rispose. «Sono il simbolo di Nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, che per noi è morto in croce.»
Sul capo dei marziani all’improvviso gli evanescenti ciuffi vibrarono. Era un segno di interesse o di emozione? O era quello il loro modo di ridere?
«E dove, dove questo sarebbe successo?» chiese sempre il più grandetto, con quel suo squittio che ricordava le trasmissioni Morse; e c’era dentro un vago accento di ironia.
«Dio, vuoi dire, sarebbe venuto qui, tra voi?»
«Qui, sulla Terra, in Palestina.»
Il tono incredulo irritò don Pietro.
«Sarebbe una storia lunga» disse «una storia forse troppo lunga per dei sapienti come voi.»
In capo allo straniero la leggiadra indefinibile corona oscillò due tre volte. Pareva che la muovesse il vento.
«Oh, dev’essere una storia magnifica» fece con condiscendenza. «Uomo, vorrei proprio sentirla.»
Balenò nel cuore di don Pietro la speranza di convertire l’abitatore di un altro pianeta? Sarebbe stato un fatto storico, lui ne avrebbe avuto gloria eterna.
«Se non vuoi altro» disse, rude. «Ma fatevi vicini, venite pure qui nella mia stanza.»
Fu certo una scena straordinaria, nella camera del parroco, lui seduto allo scrittoio alla luce di una vecchia lampada, con la Bibbia tra le mani, e i due marziani in piedi sul letto perché don Pietro li aveva invitati ad accomodarsi, che si sedessero sul materasso, e insisteva, ma quelli a sedere non riuscivano, si vede che non ne erano capaci e tanto per non dir di no alla fine vi erano saliti, standovi ritti, il ciuffo più che mai irto e ondeggiante.
«Ascoltate, spazzolini!» disse il prete, brusco, aprendo il libro, e lesse: “…l’Eterno Iddio prese dunque l’uomo e lo pose nel giardino d’Eden… e diede questo comandamento: Mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare: perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo sarà la tua morte. Poi l’Eterno Iddio…”
Levò gli sguardi dalla pagina e vide che i due ciuffi erano in estrema agitazione. «C’è qualcosa che non va?».
Chiese il marziano: «E, dimmi, l’avete mangiato, invece? Non avete saputo resistere? È andata così, vero?».
«Già. Ne mangiarono» ammise il prete, e la voce gli si riempì di collera. «Avrei voluto veder voi! È forse cresciuto in casa vostra l’albero del bene e del male?»
«Certo. È cresciuto anche da noi. Milioni e milioni di anni fa. Adesso è ancora verde…»
«E voi?… I frutti, dico, non li avete mai assaggiati?».
«Mai» disse lo straniero. «La legge lo proibisce.»
Don Pietro ansimò, umiliato. Allora quei due erano puri, simili agli angeli del cielo, non conoscevano peccato, non sapevano che cosa fosse cattiveria, odio, menzogna? Si guardò intorno come cercando aiuto, finché scorse nella penombra, sopra il letto, il crocefisso nero.
Si rianimò: «Sì, per quel frutto ci siamo rovinati… Ma il figlio di Dio» tuonò, e sentiva un groppo in gola «il figlio di Dio si è fatto uomo. Ed è sceso qui tra noi!»
L’altro stava impassibile. Solo il suo ciuffo dondolava da una parte e dall’altra, simile a una beffarda fiamma.
«È venuto qui in Terra, dici? E voi, che ne avete fatto? Lo avete proclamato vostro re?… Se non sbaglio, tu dicevi ch’era morto in croce… Lo avete ucciso, dunque?»
Don Pietro lottava fieramente: «Da allora sono passati quasi duemila anni! Purtroppo per noi è morto, per la nostra vita eterna!».
Tacque, non sapeva più che dire. E nell’angolo scuro le misteriose capigliature dei due ardevano, veramente ardevano di una straordinaria luce. Ci fu silenzio e allora di fuori si udì il canto dei grilli.
«E tutto questo» domandò allora il marziano con la pazienza di un maestro «tutto questo è poi servito?»
Don Pietro non parlò. Si limitò a fare un gesto con la destra, sconsolato, come per dire: che vuoi? siamo fatti così, peccatori siamo, poveri vermi peccatori che hanno bisogno della pietà di Dio. E qui cadde in ginocchio, coprendosi la faccia con le mani.
Quanto tempo passò? Ore, minuti? Don Pietro fu riscosso dalla voce degli ospiti. Alzò gli occhi e li scorse già sul davanzale, in procinto, si sarebbe detto, di partire. Contro il cielo della notte i due ciuffi tremolavano con affascinante grazia.
«Uomo» domandò il solito dei due. «Che stai facendo?»
«Che sto facendo? Prego!… Voi no? Voi non pregate?»
«Pregare, noi? E perché pregare?»
«Neanche Dio non lo pregate mai?»
«Ma no!» disse la strana creatura e, chissà come, la sua corona vivida cessò all’improvviso di tremare, facendosi floscia e scolorita.
«Oh, poveretti» mormorò don Pietro, ma in maniera che i due non lo udissero come si fa con i malati gravi. Si levò in piedi, il sangue riprese a correre con forza su e giù per le sue vene. Si era sentito un bruco, poco fa. E adesso era felice. “Eh, eh” ridacchiava dentro di sé “voi non avete il peccato originale con tutte le sue complicazioni. Galantuomini, sapienti, incensurati. Il demonio non lo avete mai incontrato. Quando però scende la sera, vorrei sapere come vi sentite! Maledettamente soli, presumo, morti di inutilità e di tedio.” (I due intanto si erano già infilati dentro allo sportello, lo avevano chiuso, e il motore già girava con un sordo e armoniosissimo ronzio. Piano piano, quasi per miracolo, il disco si staccò dal tetto, alzandosi come fosse un palloncino: poi prese a girare su se stesso, partì a velocità incredibile, su, su in direzione dei Gemelli.) «Oh» continuava a brontolare il prete «Dio preferisce noi di certo! Meglio dei porci come noi, dopo tutto, avidi, turpi, mentitori, piuttosto che quei primi della classe che mai gli rivolgon la parola. Che soddisfazione può avere Dio da gente simile? E che significa la vita se non c’è il male, e il rimorso, e il pianto?»
Per la gioia, imbracciò lo schioppo, mirò al disco volante che era ormai un puntolino pallido in mezzo al firmamento, lasciò partire un colpo. E dai remoti colli rispose l’ululio dei cani.
Che cos’è la vita se non c’è il dolore, il bisogno, il male e perciò il bene e il perdono? E perciò il desiderio?
Tutta l’opera di Buzzati mi sembra che ruoti attorno a questo grido, che non so definire se non ricordando il grido nella Chiesa la notte di Pasqua: “Felice colpa che ci ha meritato un così grande redentore!” Cioè a dire: senza nessuno scandalo è l’idea di fede e di Chiesa su cui ci ha rilanciato così frequentemente papa Francesco. La Chiesa incidentata, sporca piuttosto che la Chiesa dei sapientoni che non ha più bisogno né di perdono né di altro.
La novella “Nuovi strani amici” è, da questo punto di vista, quella di Buzzati che amo di più. Ve la rammento soltanto. È la più bella perché parla di questo Stefano Martella che muore. Morendo dice: “Va beh, tutto sommato non ho fatto proprio asinate grosse: ho lavorato tutta la vita, ho lasciato un po’ di soldi ai figli, qualche scappatella ma niente di che… dovrei finire in paradiso…” Infatti muore e si trova in Paradiso. Si trova in un paradiso dove tutto è perfetto, tutto è proprio come avrebbe desiderato: la casa è quella che ha sempre sognato, il clima intorno bellissimo dappertutto servitori che appena avvertono un po’ di sete sono pronti a servigli un calice di quello che avrebbe voluto bere. Tutto perfetto!
Solo che mentre si muove e una guida gli si accosta per spiegargli che quella è la sua casa, ecc…a lui vengono delle domande e si informa su come funziona questo paradiso.
– E Dio? – domandò il Martella (in cuor suo non gliene importava un bel niente, ma gli sembrava doveroso, se non altro per cortesia, informarsi circa il padrone di casa, il signore di quel regno). – E Dio? Mi ricordo che al catechismo, da piccolo, mi dicevano che in paradiso si gode la vista di Dio. Da quassù non si vede? – Francesco rise, in tono un po’ beffardo a dire il vero: – Eh, caro Martella, scusi se glielo dico, ma adesso forse pretende un po’ troppo mi sembra -. (Ma perché rideva in quel modo antipatico?) – Ciascuno ha il suo giusto paradiso, naturalmente, conforme alla sua natura. Che cosa le può interessare Dio, se non ci ha mai creduto? – Al che l’altro non insistette; dopo tutto, che gliene importava? Visitarono, non tutta la casa, che sarebbe stato troppo lungo, ma le cose principali; l’insieme prometteva una esistenza beata. Poi Francesco propose di andare al circolo: il Martella vi avrebbe trovato un gruppo di cari amici.
Continuano un po’ la visita e il Martella continua a chiedere:
– E donnette? ce ne sono di graziose donnette? -. (non che per la via non ne avesse vedute; una più bella dell’altra, anzi; ma voleva proprio sapere se lui, alla sua età, senza rimetterci in prestigio, avrebbe potuto eccetera eccetera.) – Che domande – fece l’altro, divertito, ma sempre con quel fondo beffardo. – Vuole chi manchino proprio qui in paradiso? Al circolo, una residenza di monarchi, sette otto signori di cospicua levatura sociale furono intorno al Martella, con la cordialità di vecchi amici. Lui ebbe l’impressione di averne conosciuti già due; gli venne anzi il vago sospetto che fossero stati due colleghi, chissà, suoi rivali, a cui forse aveva giocato qualche brutto tiro; ma di preciso non riusciva a ricordare. Nessuno dei due del resto diede segno di riconoscerlo.
– Eccoti qui dunque anche tu! – disse il più vecchio di quei signori, bianco di capelli, dignitosissimo, che lo contemplava avidamente. – Contento? contento?
– Eh, per forza contento – rispose il Martella centellinando un aperitivo che gli era stato subito offerto.
– Perché dici per forza? – intervenne un altro, magro, sulla trentina, con una faccia un po’ sul tipo di Voltaire, una piega delle labbra alquanto ironica ed amara. – Credi che sia obbligatorio essere contenti?
Insomma tutto il dialogo si gioca su una strana dinamica per cui tutto è perfetto, tutto è bello, tutto è esattamente e più di quel che aveva sognato ma… nelle risposte che raccoglie c’è una sfumatura che lo inquieta, c’è qualcosa di strano.
Arriva un altro che pure si associa al primo a far da guida che dice cose un po’ diverse.
Tutto quello che ci faceva penare laggiù – e fece con la destra un piccolo gesto bizzarro, che il Martella non aveva mai visto, evidentemente un gesto convenzionale e assai comune nell’aldilà per indicare la primiera esistenza – tutto quello che ci faceva penare laggiù adesso è scomparso.
– Tutto, proprio tutto? Anche gli scocciatori? – fece il Martella per mostrarsi di spirito.
– Spero bene – disse il vecchio signore.
– E malattie? Neanche un raffreddore?
– Malattie? Allora perché si sarebbe in paradiso? – e accentuò l’ultima parola, chissà perché, quasi la disprezzasse.
– Tranquillizzati – confermò il magro fissando bene negli occhi il nuovo compagno, – inutile aspettarsi malattie, non verranno.
– E che cosa ti fa pensare che io ne aspetti? Ne ho avuto abbastanza, direi – disse il Martella e si compiacque che gli fosse venuta fuori così, spontaneamente, una facezia.
– Non si sa mai, non si sa mai – insisteva l’altro, né si capiva se scherzasse o no. – Non sperare di potertene stare qualche giorno in letto con la febbre… o di avere un bel mal di denti… Neppure una storta, neanche una volgarissima storta ci è concessa!
– Ma perché gli parli così? Non sono mica disgrazie! – esclamò il vecchio; quindi, rivolto all’ospite: – Non badarci, sai, lui si diverte a scherzare.
– Eh, ho ben capito – disse il Martella con stentata disinvoltura, perché invece si sentiva in imbarazzo. – Qui insomma il dolore non esiste.
– Non c’è dolore, caro mio – ribadiva il signore canuto – e quindi non ospedali, non manicomi, non colonie sanatoriali.
– Giusto! – approvò il magro. – Su, spiegagli bene tutto!
– Ecco – continuò il vecchio signore – noi non abbiamo dolori. E poi qui nessuno ha paura. Di che cosa dovrebbe aver paura? Vedrai, non ti capiterà più di sentire il cuore che batte.
– Neanche quando si fanno dei brutti sogni, degli incubi?
– E perché vuoi avere degli incubi? Non credo neppure si sogni, da noi. Che io mi ricordi, da quando sono qui non ho mai sognato una volta.
– Ma desideri, desideri ne avrete, dico.
– Desideri di che? Se abbiamo tutto. Che cosa resta da desiderare? Che cosa ci manca?
– E le cosiddette… le cosiddette pene d’amore?
– Neanche queste, naturalmente. Né desideri, né amore, né rimpianti, né odi, né guerre, ti dico: tutto assolutamente tranquillo.
Ma a questo punto il giovane magro si alzò, da seduto che era, in piedi; una espressione dura sul volto. – Non pensarci nemmeno – disse al Martella con impeto. – Càvatelo dalla mente. Qui, siamo tutti felici, intesi? Niente ti costerà fatica, non sarai mai stanco, non avrai sete, mai ti farà male il cuore alla vista di una donna, mai dovrai aspettare la luce dell’alba, rivoltandoti sul letto, come una liberazione. Non abbiamo nostalgie, né rimorsi, niente ci fa più paura, non c’è più neanche la paura dell’inferno! Siamo felici, te ne vuoi persuadere? – Qui si fermò un attimo, quasi colto da pensiero sgradito. – E poi…, e poi specialmente una cosa: sulle prime non ci si pensa, eppure è tutta qui la questione: da noi non esiste la morte, capisci? Non abbiamo più la facoltà di morire; che bellezza vero? Ne siamo de-fi-ni-ti-va-men-te – e sillabava la parola – definitivamente esonerati… Ha un bel passare il tempo, oggi è uguale a ieri, domani uguale a oggi, niente di male ci potrà mai succedere. – La voce qui si fece lenta e grave. – La morte! Ti ricordi quanto la odiavamo? Come ci amareggiava la vita! E i cimiteri, te li ricordi? E i cipressi, e i lumini nella notte e i fantasmi, i fantasmi con le catene che uscivano dalle tombe?… E il pensiero dell’aldilà, le discussioni che si facevano, quel mistero, ti ricordi? Oh, ma chi ci pensa oramai… Qui tutto è diverso, qui siamo liberi finalmente, non c’è nessuno che ci stia ad aspettare alla porta. Che soddisfazione, vero? Che bellissima festa!
Il vecchio signore aveva ascoltato lo sfogo con crescente apprensione. Ora intervenne duramente: – Smettila, ti dico, smettila. È mai possibile perdere così il controllo?
La discussione prosegue finché arrivano quattro guardiani che prendono il giovane e lo portano via mentre sta urlando:
– Guardali, i bei palazzi, i giardini, i gioielli. Divèrtiti, se sei capace. Ma non capisci che abbiamo perso tutto? Ma non hai ancora capito che…- Qui le parole furono soffocate come gli avessero imposto un bavaglio.
La frase terminò in un borbottio informe che il Martella non poté decifrare. Non importava, oramai. Una voce sottile, estremamente precisa, gli diceva ciò che l’altro non era riuscito. – Ma non hai ancora capito – diceva questa voce – che noi siamo all’inferno?
Non è il Paradiso, è l’Inferno. Un posto dove non c’è da amare, da desiderare, dove non c’è il bisogno dell’altro è l’inferno. Perché il Paradiso sarà esattamente il contrario. Non che ci siano le pene, non che ci sia il dolore, ma ci sarà la verità dell’essere e la verità dell’essere è il bisogno dell’altro. Io sono il rapporto con te, io senza di te non esisto. Questo dice questa novella incredibile, la più grande storia che io ricordi che dica con chiarezza cos’è l’inferno e cos’è il Paradiso.
E come mai Gesù sia venuto e perché sia venuto per chi ha il coraggio di dire “Signore io ho bisogno”. I malati, i poveri, gli oppressi, le beatitudini insomma. E dice in qualche modo la natura di Dio. Perché Dio è amore cioè sono in tre ma uno non esiste senza gli altri due. L’uno è bisogno dell’altro e perciò è Dio. Perché è questo bisogno perennemente realizzato vissuto come piena comunione.
Ultimissima domanda: se il problema allora è conservare la nostra natura come desiderio, chi ce la fa? Chi di noi vive ogni giorno all’altezza del suo desiderio, della sua natura? Così come Dio l’ha fatta? Uno stupore e una meraviglia davanti alla realtà e perciò una dipendenza vissuta da chi l’ha fatta e la voglia, il desiderio che questa che è la verità sia detta, che non si viva nella menzogna. Ma come si fa a vivere così?
L’ultima parola che voglio dirvi è la parola “popolo”. C’è un posto che Dio si è inventato che non è il posto dove si fa i bravi o dove si diventa più bravi, la domanda del marziano se siamo riusciti a cambiare qualcosa, non è il posto dove si diventa più bravi, è il posto dove si custodisce la verità.
La Chiesa è quella porzione dell’umanità che essendo la Sua presenza, coincidendo con la Sua presenza è il posto dove la verità viene detta, come si è e come si può senza scandali.
Come ha detto il don Pietro ai marziani: “Dio non può che preferire noi così porci, così peccatori, così traditori ma ci deve preferire perché noi quando prendiamo coscienza di essere così abbiamo bisogno di lui e lui ci vuole bene quando noi gli diciamo che abbiamo bisogno di lui, ed è quello che lo fa felice! Voi come fate piuttosto a sopportare questa apparente perfezione per cui non avreste bisogno di Dio, non avete bisogno di essere salvati?” Ci vuole un popolo, ci vuole la Chiesa che ci aiuti a custodire questo desiderio che Dio ci ha dato e che è l’unica ragione per cui siamo al mondo. “Conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell’altra” è la definizione del Paradiso che mi ha insegnato la mia suora al catechismo.
Io mi ero segnato una serie di cose da citarvi semplicemente e con cui vi chiederei di lasciarci e tornare a casa pensosi rispetto a questa possibilità a cui siamo chiamati.
Vi ricordate che quando ho letto Leopardi dicevo che don Giussani si chiedeva perché un genio così che voleva il cristianesimo, voleva l’incarnazione non l’ha riconosciuta presente? La risposta che lui dà è: “non ebbe amicizia sufficiente”. Non visse la Chiesa.
Ecco, credo che quello che noi dobbiamo vivere, sostenuti ed aiutati anche da questi testi meravigliosi, è fare la Chiesa, cioè vivere tra noi amicizia sufficiente a sostenere il desiderio grande che abbiamo. Senza avere la presunzione di essere migliori degli altri, o più bravi. La Chiesa è fatta di peccatori e va bene così.
Leggete la novella di Boccaccio, la seconda novella del Primo giorno del Decamerone, è bellissima.
C’è uno che vuole convertire il suo amico ebreo e gli spiega perché il cristianesimo è giusto e la sua religione sbagliata. Insiste, insiste e allora un giorno l’amico ebreo dice: “Senti, facciamo così. Se sei così convinto vado a Roma, vedo come sono i tuoi capi, e se vedo che sono meglio dei miei mi faccio cristiano!”. L’altro si mette le mani nei capelli, spaventato. Invece l’ebreo va a Roma, torna e dopo qualche giorno l’amico cristiano osa chiedergli come sia andata. La risposta dell’ebreo è stupenda. Dice:
Parmene male, che Iddio dea a quanti sono; e di coti così che, se io ben seppi considerare, quivi niuna santità, niuna divozione, niuna buona opera o essemplo di vita o d’altro in alcuno che cherico fosse veder mi parve; ma lussuria, avarizia e gulosità, fraude, invidia e superbia e simili cose e piggiori (se piggiori essere possono in alcuno) mi vi parve in tanta grazia di tutti vedere, che io ho più tosto quella per una fucina di diaboliche operazioni che di divine. E per quello che io estimi, con ogni sollecitudine e con ogni ingegno e con ogni arte mi pare che il vostro pastore, e per consequente tutti gli altri, si procaccino di riducere a nulla e di cacciare del mondo la cristiana religione, là dove essi fondamento e sostegno esser dovrebber di quella.
E per ciò che io veggio non quello avvenire che essi procacciano, ma continuamente la vostra religione aumentarsi e più lucida e più chiara divenire, meritamente mi par di scerner io Spirito Santo esser d’essa, sì come di vera e di santa più che alcun’altra, fondamento e sostegno. Per la qual cosa, dove io rigido e duro stava a’ tuoi conforti e non mi volea far cristiano, ora tutto aperto ti dico che io per niuna cosa lascerei di cristian farmi. Andiamo adunque alla chiesa: e quivi, secondo il debito costume della vostra santa fede, mi fa battezzare.
Certo è un paradosso ma bellissimo! “Fa così schifo la Chiesa”, lui dice, “che per durare nel tempo, resistere e convincere altri deve essere per forza guidata dallo Spirito Santo e quindi mi converto e voglio il battesimo della Chiesa Cattolica!” E si dice alla fine che muore in odore di santità. Conclusione altrettanto bella perché non è che con questa scusa si possono fare tutti i peccati che volete, dice: “E a Nostra Dama di Parigi con lui insieme andatosene, richiese i cherici di là entro che ad Abraam dovessero dare il battesimo. Li quali, udendo che esso l’addomandava, prestamente il fecero: e Giannotto il levò del sacro fonte e nominollo Giovanni; e appresso a gran valenti uomini il fece compiutamente ammaestrare nella nostra fede la quale egli prestamente apprese, e fu, poi buono e valente uomo e di santa vita“.
Cioè, non è che ha detto che siccome i peccati dimostrano l’esistenza dello Spirito Santo allora ci diamo dentro. Si è tenuti a fare una santa vita, ma non scandalizza la povertà della Chiesa, anzi, paradossalmente, ne documenta la santità.
E, per chiudere, vi leggo due righe di Ratzinger che pronunciò in un discorso alla radio nel 1969.
Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi.
Dagli inizi vuol dire da te che dentro il mondo e la vita rintracci Cristo e quando lo vedi lo racconti, fine. Viviamo in tempi apostolici.
Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali… Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla fine.
Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica.
Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. Essa farà questo con fatica. Il processo infatti della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso… Ma dopo la prova di queste divisioni uscirà da una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza.
Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto… A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena incominciata. Si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la Chiesa del culto politico… ma la Chiesa della fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte.
Mi sembra che sia il nostro compito, il contenuto della nostra preghiera.
Grazie.



