Why Beauty Matters/Perché la bellezza ha importanza, di Roger Scruton
- Tag usati: arte_fede, bellezza, roger_scruton, why_beauty_matters
- Segnala questo articolo:
Riprendiamo dal sito Alleanza cattolica la trascrizione delle parole di un documentario di Roger Scruton per la BBC con l’introduzione che accompagnava la trascrizione sul sito stesso. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. la sezione Arte e fede.
Il Centro culturale Gli scritti (26/1/2020)
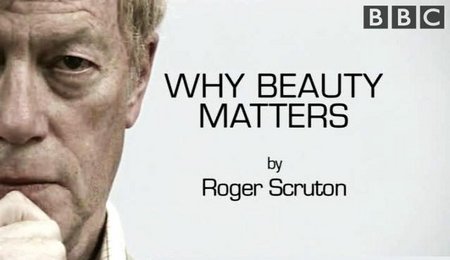
Nei mesi di novembre e di dicembre del 2009, il secondo e il quarto canale della BBC. British Broadcasting Corporation, la società radiotelevisiva pubblica del Regno Unito, hanno mandato in onda un ciclo di documentari dal titolo Modern Beauty, che intendeva esaminare la percezione della bellezza nelle forme artistiche classiche e moderne. Il quinto della serie, intitolato Why Beauty Matters, diretto da Louise Lockwood e mandato in onda la prima volta il 28-11-2009, è stato affidato allo scrittore e filosofo britannico Roger Scruton. Nato nel 1944, Scruton si è laureato a Cambridge nel 1965 e ha insegnato Estetica al Birkbeck College dell’Università di Londra dal 1971 al 1992. Fondatore nel 1982 del trimestrale The SalisburyReview, lo ha diretto fino al 2000. Insegna attualmente presso l’università di St. Andrews in Scozia ed è visiting scholar dell’American Enterprise Institute a Washington. Con l’autorizzazione dell’autore pubblichiamo il testo di Why Beauty Matters. La traduzione — che riduce le ripetizioni tipiche dello stile parlato —, la suddivisione in paragrafi, le inserzioni fra parentesi quadre e le note sono redazionali. Parte delle considerazioni svolte si possono ritrovare, con una maggiore articolazione, nell’opera di Scruton, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica, trad. it., Vita e Pensiero, Milano 2011.
Perché la bellezza ha importanza, di Roger Scruton
1. A qualunque persona istruita — e in un qualunque momento storico fra il 1750 e il 1930 — fosse stato chiesto di descrivere lo scopo della poesia, della pittura, della scultura o della musica, la risposta sarebbe stata: “La bellezza”. E, se aveste chiesto ragione della risposta, vi avrebbero insegnato che il bello è un valore importante almeno quanto il vero e il bene.
Poi, nel secolo XX, la bellezza ha smesso di essere importante. Il fine dell’arte è diventato con sempre maggior frequenza quello di turbare, di rompere tabù morali. Non è più stata la bellezza a essere glorificata, ma l’originalità, comunque raggiunta e a qualunque costo morale.
Non solo la pittura e la scultura hanno affermato il culto della bruttezza; anche l’architettura è diventata senz’anima e sterile. E non è solo ciò che fisicamente ci circonda a esser diventato brutto: il nostro linguaggio, la nostra musica e le nostre maniere sono diventati sempre più scabri, egocentrici e offensivi, come se la bellezza e il buon gusto non trovassero più un loro posto nelle nostre vite.
Una parola è scritta a chiare lettere su tutte queste brutte cose. Questa parola è: “Io”. Il “mio” guadagno, i “miei” profitti, i “miei” desideri, il “mio piacere”. E l’arte non ha null’altro da dire in risposta a quest’atteggiamento se non: “Bene! Vatteli a prendere!”.
Personalmente, penso che stiamo rischiando di perdere la bellezza. E vi è il pericolo che, con lei, perderemo anche il senso della vita.
2. Mi chiamo Roger Scruton, filosofo e scrittore. La mia attività consiste nel porre domande. In questi ultimi anni mi sono interrogato sulla bellezza. Per oltre duemila anni essa ha avuto un ruolo centrale nella nostra civiltà. Dai suoi albori, nell’antica Grecia, la filosofia riflette sul posto che il bello occupa nelle arti figurative, nella poesia, nella musica, nell’architettura e nella vita di tutti i giorni.
I filosofi sostenevano che, attraverso il perseguimento della bellezza, noi diamo al mondo la forma di una dimora e riusciamo anche a comprendere la nostra natura di esseri spirituali. Il nostro mondo, tuttavia, ha deciso di voltare le spalle al bello. Di conseguenza, ci scopriamo circondati dalla bruttezza e dall’alienazione. Vorrei convincervi che la bellezza ha una sua importanza. Non è soltanto una questione soggettiva, ma una necessità insopprimibile dell’essere umano. Quando s’ignora questo bisogno, ci si ritrova in un deserto spirituale. Mi piacerebbe mostrarvi una via per uscire da questo deserto. È una via che permette di ritrovare la strada di casa.
I grandi artisti del passato erano consapevoli che la vita umana è caratterizzata dalla confusione e dalla sofferenza, ma essi trovavano a ciò un rimedio: la bellezza è il suo nome. L’arte riesce a portare consolazione nella sofferenza e conferma nella gioia. Essa mostra che la vita umana è degna di essere vissuta.
Sembra che molti artisti contemporanei si siano stancati di questo sacro compito. La casualità della vita, sostengono, non può essere redenta dall’arte. Al contrario, essa va esibita. Ha fatto da apripista e da modello quasi un secolo fa l’artista francese Marcel Duchamp [1887-1968], che ha messo una firma fittizia su un orinatoio e lo ha proposto per una mostra. Il gesto era satirico, intendeva deridere il mondo dell’arte e lo snobismo che lo accompagna. Eppure, è stato interpretato in un altro modo: esso provava che qualunque cosa può essere arte[1].
Come una luce che si accende e si spegne[2], un barattolo di alluminio contenente escrementi[3] o un mucchio di mattoni[4].
L’arte non ha più uno status sacrale, né ci eleva, moralmente o spiritualmente, a un livello superiore. Si tratta di un gesto, di un atto umano come tutti gli altri, non più denso di significato di una risata o di un grido. Un tempo, l’arte aveva prodotto il culto della bellezza. Il culto della bruttezza ne ha ora preso il posto[5]. Sembrerebbe che, poiché il mondo disturba e allarma, l’arte debba avere le stesse caratteristiche. Quelli che nell’arte cercano la bellezza sarebbero unicamente quelli che hanno perso il contatto con la realtà contemporanea.
Talvolta, l’intento è di sconcertare. Tuttavia, ciò che la prima volta ci sbalordisce, ci annoia e ci sembra vacuo quando viene ripetuto. Questo trasforma l’arte in un gioco sofisticato che, ormai, ha smesso di essere divertente. Eppure, i critici non smettono di approvarla e di sostenerla, timorosi di denunciare che l’imperatore è nudo. Non si può dire, solo per il fatto di aver avuto un’idea, di aver realizzato dell’“arte creativa”. Naturalmente, le idee possono essere interessanti e divertenti, ma non per questo è legittimo appropriarsi della qualifica di “arte”. Se un’idea fosse sufficiente a realizzare un’opera d’arte, ognuno potrebbe diventare un artista e ogni oggetto un’opera d’arte: non ci sarebbe più alcun bisogno di talento, di gusto o di creatività.
In un’intervista rilasciata alla BBC nel 1968, Marcel Duchamp dichiarava: “Non è per me molto importante che cosa effettivamente sia un’“opera d’arte”. Non m’importa della parola “arte”: è stata così screditata! Sì, anch’io ho deliberatamente contribuito a screditarla. Io volevo liberarmene. Proprio come molte persone oggi si sono liberate della religione”[6]. Su Duchamp si è accettato di sospendere il giudizio. Personalmente, credo che egli non sia veramente pervenuto all’arte, ma solo alla creatività.
3. A ogni modo, i lavori di Duchamp continuano a influenzare il corso dell’arte ai giorni nostri. Michael Craig-Martin, che ha insegnato a molti giovani artisti nel Regno Unito e la cui opera domina il mondo dell’arte, ha seguito le orme di Duchamp con Un albero di quercia, del 1973. Quest’opera innovativa consiste in un bicchiere d’acqua appoggiato a una mensola di vetro e di un testo che spiega perché si tratterebbe di un albero di quercia[7].
[A questo punto inizia un dialogo fra Scruton e Craig-Martin]
[Scruton:] “Quando, per la prima volta, sono entrato in San Pietro e ho avuto l’impatto con La pietà di Michelangelo [Buonarroti (1475-1564)], ho vissuto un’esperienza travolgente, che in qualche modo ha cambiato la mia vita. Lei crede che qualcuno possa vivere la stessa esperienza dinanzi all’orinatoio di Duchamp, o anche al suo Albero di quercia che, in fondo, è un’opera dello stesso genere?”.
[Craig-Martin:] “Io so solo che, quando ero ancora un teen-ager e mi sono imbattuto per la prima volta in Duchamp e in oggetti ready-made[8], sono rimasto completamente ammutolito dallo stupore. Non credo che le persone vengano sopraffatte da un senso estetico di bellezza quando vedono l’orinatoio: non è stato pensato per essere bello. Questo, tuttavia, non significa che non vi sia in esso qualcosa che seduca l’immaginazione. E io penso che proprio nel sedurre l’immaginazione si trovi la chiave per comprendere ciò cui punta un’opera d’arte. Duchamp riteneva che l’arte si fosse troppo concentrata sulle tecniche e sui fenomeni ottici e che si fosse corrotta intellettualmente e moralmente. La motivazione che lo spinse a proporre un’opera d’arte che non rientrava nei canoni stabiliti dal sistema non fu il cinismo. Duchamp intendeva dire: “Sto sperimentando una forma d’arte che rinneghi tutte le caratteristiche che, si ritiene comunemente, l’arte deve avere. Vorrei far capire che ciò che costituisce la sostanza dell’opera d’arte risiede altrove””.
[Scruton:] “Concedo che le cose dovessero cambiare e Duchamp provava a farlo, ma quale direzione intendeva imprimere al cambiamento?”.
[Craig-Martin:] “Duchamp non avrebbe mai potuto neanche lontanamente immaginare quello che poi effettivamente è accaduto. Sono sicuro che egli stesso non avesse una chiara idea della pregnanza che avrebbe assunto la situazione in cui si era invischiato: dopo di lui, essenzialmente, un’opera d’arte è tale perché noi la pensiamo come tale. Va detto, secondo me, che la nozione di bello si è in qualche modo estesa a oggetti che ne erano esclusi. E questa è una delle funzioni dell’artista: rendere bello, far sì che qualcuno trovi bello qualcosa che, fino a quel momento, non era ritenuto tale”.
[Scruton:] “Capisco. Anche un barattolo contenente escrementi, quindi?”.
[Craig-Martin:] “Beh, non sono sicuro che sia bello, ma quell’esempio particolare non aspira a essere bello. Se, invece, come esempio, consideriamo un Jeff Koons[9]… Koons ha creato cose di una bellezza stupefacente”.
[Scruton:] “Opere che a me appaiono, in verità, molto kitsch, anche se con dello zucchero sopra…”.
[Craig-Martin:] “Il kitsch può riferirsi ai soggetti che sceglie per le sue opere, ma non alla loro sostanza”.
[Scruton:] “Ma a che cosa serve questo tipo di arte? Quale tipo di aiuto può dare alle persone?”.
[Craig-Martin:] “Penso, anzi, spero che aiuti le persone a guardare il mondo in cui vivono in modo che questo risulti loro più pieno di significato. Non un mondo ideale, un mondo altro o migliore, ma il mondo qui e ora, da accettare e da vivere con meno inquietudine”.
4. Così, l’arte contemporanea mostrerebbe il mondo com’è, qui e ora, con tutte le sue imperfezioni. Ma i suoi esiti possono veramente dirsi arte? Una cosa è certa: non si può parlare di “opera d’arte” solo perché si porta all’attenzione una porzione di realtà, bruttezza inclusa, e la si definisce arte.
L’arte ha bisogno della creatività e questa, a sua volta, ha a che fare con la condivisione: è un appello rivolto agli altri perché guardino il mondo come lo vede l’artista. Questa è la ragione per cui troviamo della bellezza nei lavori naïf dei bambini, che non ci propongono idee al posto di immagini creative, né si crogiolano nella bruttezza. Essi provano a dichiarare il modo in cui vedono il mondo e a condividere quello che sentono.
Qualcosa del puro diletto infantile del creare sopravvive in ogni vera opera d’arte. Ma la creatività, da sola, non basta e il talento del vero artista mostra il reale alla luce dell’ideale e, così, lo trasfigura. Questo è il risultato che, a esempio, Michelangelo Buonarroti riesce a conseguire con il suo David. Aggiungo, tuttavia, che quando c’imbattiamo in una riproduzione del David, magari collocato in un giardino, non vi troviamo alcuna bellezza: manca quell’ingrediente necessario costituito dalla creatività.
Discussioni come quelle che ho ingaggiato sono pericolose. Nella nostra cultura democratica le persone sono portate a pensare che giudicare i gusti del prossimo sia un atto intimidatorio. Vi è addirittura chi ritiene offensivo il solo formulare l’ipotesi che esista una differenza fra il buon gusto e il cattivo gusto o che non sia indifferente ciò che si decide di guardare, di leggere o di ascoltare. Ma questa è una posizione che non produce alcun frutto. Vi sono standard di bellezza fortemente radicati nella natura umana che noi dobbiamo cercare e ricostruire nelle nostre vite.
Probabilmente la perdita della fede nella bellezza è dovuta al fatto che si è persa quella negl’ideali. Tutto ciò che conta — qualcuno è tentato di teorizzare — è il mondo degli appetiti: non vi sono altri valori all’infuori di quelli strettamente utilitaristici. Una cosa vale nella misura in cui è utile. Quale sarebbe, invece, l’utilità della bellezza? “L’arte, tutta, è perfettamente inutile”[10], scriveva Oscar Wilde [1854-1900]. Nelle sue intenzioni l’osservazione voleva essere elogiativa, giacché per Wilde la bellezza aveva un valore superiore all’utilità. Le persone hanno bisogno di cose inutili in misura pari, o addirittura maggiore, a quelle che hanno un’utilità. Si pensi soltanto a quale possa essere l’utilità dell’amore, dell’amicizia o del culto. Proprio nessuna. Della bellezza si può dire la stessa cosa.
La nostra società consumista pone l’utilità prima di tutto e la bellezza non è più importante di un effetto collaterale. Poiché l’arte non ha alcuna utilità, non ha alcuna importanza ciò che si legge, si guarda o si ascolta. Siamo assediati da ogni parte da messaggi, stuzzicati, tentati da appetiti mai prima d’ora sollecitati. Questa è una delle ragioni per le quali la bellezza sta scomparendo dal nostro mondo. “Acquistando e spendendo — scriveva Wordsworth [William (1770-1850)] — noi sciupiamo le nostre energie”[11]. Oggi, l’annuncio pubblicitario ha maggior rilievo dell’opera d’arte e le elaborazioni artistiche, spesso, cercano di catturare la nostra attenzione come fanno le pubblicità, scegliendo di essere impertinenti e oltraggiose come il teschio di platino di Damien Hirst[12]. Come la pubblicità, l’arte punta a creare un marchio. Non avendo alcun prodotto da vendere, gli artisti vendono sé stessi.
5. La bellezza subisce un assalto da due diverse direzioni: il culto della bruttezza nelle arti e quello dell’utilità nella vita di ogni giorno. Nell’architettura moderna questi culti sono presenti entrambi. Agl’inizi del secolo XX gli architetti, come gli artisti, hanno iniziato a dare segni d’impazienza nei confronti del bello e lo hanno sostituito con l’utile. L’architetto americano Louis [Henry] Sullivan [1856-1924] enunciava il credo dei modernisti dicendo: “La forma segua la funzione”[13]. In altre parole, bisogna smetterla di riflettere su come un edificio appare e soffermarsi, piuttosto, sulla sua destinazione d’uso. La dottrina di Sullivan è stata invocata per giustificare il più grande crimine compiuto contro il bello che il mondo abbia mai visto: il crimine dell’architettura moderna.
Sono cresciuto nei dintorni di Reading, che era un’amena cittadina vittoriana con strade a schiera e chiese gotiche, impreziosita da edifici pubblici prestigiosi e hotel eleganti. Tuttavia, negli anni 1960, le cose hanno cominciato a cambiare. Al centro della città l’unica strada è stata demolita per lasciar spazio a enormi isolati esclusivamente destinati a uffici, a una stazione per gli autobus e a parcheggi, tutti progettati senza alcuna considerazione per la bellezza. Il risultato dimostra, nella misura più lampante possibile, che, quando l’utilità è il solo criterio preso in considerazione, le cose che si costruiscono diventano presto inutili.
Ecco un edificio che è stato sgomberato e murato perché nessuno vi trovava alcuna utilità. Nessuno vi trovava alcuna utilità perché nessuno desiderava starci dentro. Nessuno desiderava starci dentro perché è dannatamente brutto. Ovunque si giri lo sguardo, si trovano bruttezza e mutilazione. Gli uffici e la stazione degli autobus sono stati abbandonati. Gli unici che si sentono a casa lì sono i piccioni che sporcano i lastricati. Ogni cosa è stata oggetto di vandalismi, ma non dobbiamo prendercela con chi li ha compiuti. I veri vandali sono quelli che hanno costruito questo posto; chi ha aggiunto i graffiti ha solo terminato il lavoro.
La maggior parte delle città e delle metropoli ha aree come quella, dove edifici costruiti per mera utilità ne sono presto diventati completamente privi. Né pare che gli architetti abbiano imparato qualcosa dai disastri prodotti. Quando il pubblico ha iniziato a reagire contro lo stile disumano dell’edilizia “concreta” degli anni 1960, gli architetti si sono limitati a sostituirlo con un altro tipo di robaccia: pareti e muri di vetro sorretti da strutture d’acciaio con rifiniture assurde che non si armonizzano.
Nel bel mezzo di questa desolazione, a Reading c’imbattiamo in un edificio sopravvissuto alle demolizioni. Un tempo fucina di fabbro, adesso ospita un caffè: persone provenienti da ogni quartiere della città si ritrovano qui, perché è l’unico posto in cui sia rimasta un po’ di vita, ed è l’edificio a emanarla. Ci torna, allora, in mente l’osservazione di Oscar Wilde sull’inutilità dell’arte: metti l’utilità al primo posto… e la perderai; se invece vi metterai la bellezza, ciò che fai sarà utile per sempre. In altre parole, nulla è più utile dell’inutile.
Lo vediamo negli esiti dell’architettura tradizionale, con i suoi dettagli decorativi. L’ornamento libera dalla tirannia dell’utile e soddisfa la nostra esigenza di armonia; in un qualche strano modo l’ornamento ci fa sentire a casa, ci ricorda che, al di là dei bisogni materiali, noi avvertiamo anche l’esigenza di qualcos’altro. Non siamo semplicemente animati da appetiti animali, dal desiderio di mangiare e di dormire; vi sono anche necessità spirituali e morali. E ci sentiremo insoddisfatti nella misura in cui non riusciremo a provvedervi.
6. Ognuno di noi sa che cosa significhi, nella vita di ogni giorno, essere improvvisamente portati lontano da qualcosa che vediamo, strappati via dal mondo ordinario degli appetiti verso la sfera luminosa della contemplazione. Un raggio di sole, il ricordo di una melodia, il volto di una persona amata, ci vengono in mente nei momenti più impensati e in cui siamo più turbati. E, improvvisamente, sentiamo che la vita è degna di essere vissuta. Sono momenti fuori dal tempo in cui avvertiamo la presenza di un mondo altro, superiore. Fin dagli albori della civiltà occidentale i poeti e i filosofi hanno interpretato l’esperienza della bellezza come segno di una nostra vocazione al divino. Platone [427-347 a.C.], per esempio, che è vissuto nell’Atene del IV secolo avanti Cristo, sosteneva che la bellezza è il segno di un ordine altro e superiore. “Quando vedrà la bellezza con gli occhi dello spirito — scriveva —, quest’uomo potrà coltivare in sé la vera virtù e sarà per questo amato dagli dèi”[14].
Platone era un idealista: credeva che gli esseri umani attraversino questo mondo come pellegrini, con una costante aspirazione al regno eterno che vi è al di là di esso, dove saremo finalmente uniti a Dio. Dio esiste in un mondo trascendente, cui l’uomo aspira, ma che non può essere conosciuto per via diretta. Un modo, tuttavia, per carpire qualcosa di quella sfera celestiale, anche giù da noi, vi è e passa attraverso l’esperienza della bellezza. Questa tesi sembra condurre a un paradosso: per Platone la bellezza era, per prima cosa e soprattutto, la bellezza del volto e della forma umana. L’attrazione verso la bellezza, sosteneva, ha origine nell’eros, una passione avvertita da ciascuno di noi. Oggi chiameremmo questa passione “amore romantico”. Per Platone l’eros era una forza cosmica che fluisce dentro di noi sotto forma di desiderio sessuale. Ma se l’allure della bellezza desta il desiderio, come può questa avere alcunché in comune con il divino? Il desiderio è proprio dell’individuo che vive in questo mondo; è una passione imperiosa. Il desiderio sessuale pone dinanzi a una scelta: o l’adorazione o l’appetito, o l’amore o la lussuria. La lussuria ha a che fare con il prendere. L’amore, invece, con il dare. La lussuria porta con sé la bruttezza, quella che s’instaura nelle relazioni umane quando un essere umano tratta un altro essere umano come uno strumento a sua disposizione. Per raggiungere la fonte della bellezza bisogna andare oltre la lussuria.
Il desiderio depurato della lussuria è ciò che intendiamo oggi per “amore platonico”. Quando noi scorgiamo la bellezza in un giovane uomo o in una giovane donna è perché intravediamo la luce dell’eternità che in quelle forme brilla grazie a una fonte celestiale situata al di là di questo mondo. La bellezza della forma umana invita a unirsi a lei spiritualmente, non fisicamente. La nostra propensione per la bellezza è, perciò, religiosa più che un’emozione sensuale. Questa teoria di Platone è sbalorditiva. La bellezza è, dal suo punto di vista, un visitatore proveniente da un altro mondo. Non possiamo fare nient’altro che contemplarne il puro fulgore. Qualunque altra cosa la sporca, la dissacra, distruggendo la sua aura sacrale.
Al giorno d’oggi, la teoria di Platone potrebbe sembrare piuttosto antiquata. Eppure non vi sono molte teorie che, nella storia, abbiano avuto un’influenza così grande. Lungo i secoli della civiltà occidentale, poeti, romanzieri, pittori, sacerdoti e filosofi hanno trovato nella visione di Platone sul sesso e sull’amore una fonte d’ispirazione o di riflessione.
Dall’angolo della mia biblioteca dedicato alla poesia, prendo qualche esempio di autori che hanno provato a esprimere nella poesia amorosa il punto di vista platonico: Thomas Malory [1405 ca.-1471] con Le mort d’Arthur[15], John Donne [1572-1631], il poema arturiano del secolo XIV Sir Gawain and the Green Knight[16] e gli altri poemi del manoscritto Pearl[17], le cui tinte espressioniste erano assolutamente all’avanguardia per l’epoca; Geoffrey Chaucer [1343 ca.-1400], specialmente con il Knight’s Tale[18]; Guido Cavalcanti [1259 ca.-1300], che fu maestro di Dante Alighieri [1265-1321] e sicuramente anche lo stesso Dante; Edmund Spenser [1552 ca.-1599] con The Faerie Queene[19]; e infine il gallese Dafydd Ap Gwilym [1315 ca.-1370 ca.].
Il pittore del primo Rinascimento Sandro Botticelli [1445-1510] esemplifica la teoria con la famosa Nascita di Venere, la dea dell’amore. Venere appare sulla tela in un luogo incontaminato dal desiderio. La dea c’invita a trascendere i nostri appetiti e a unirci a lei in nome del puro amore della bellezza. Il volto della Venere di Botticelli era quello di Simonetta [Cattaneo de Candia] Vespucci [1453-1476]. Botticelli l’ha amata sino alla fine della di lei breve vita e ha chiesto di essere sepolto ai suoi piedi. Aveva trovato in lei l’incarnazione dell’ideale platonico di bellezza: una bellezza da contemplare, non da possedere.
Platone e Botticelli vogliono dirci che la bellezza si situa oltre la sfera del desiderio sessuale. Siamo capaci d’individuare la bellezza non solo in una persona giovane e attraente, ma anche in un volto carico di anni, di dolore e di saggezza, come nei dipinti di Rembrandt [Harmenszoon van Rijn (1606-1669)][20]. La bellezza di un volto è simbolo della vita che esso esprime; è carne che diventa spirito. Infiggendovi lo sguardo, ci sembra quasi di attraversarlo e guardare dritto dentro l’anima. L’importanza di pittori come Rembrandt sta nel fatto che c’insegnano quanto la bellezza possa appartenere alle cose ordinarie della vita quotidiana. Si può trovare ovunque attorno a noi; abbiamo solo bisogno di occhi per vederla e di un cuore per coglierla. Un evento, il più ordinario possibile, può trasformarsi in qualcosa di bello grazie alla mano di un pittore che riesca a guardare nel cuore delle cose.
7. Nella misura in cui la fede in un Dio trascendente è rimasta fermamente ancorata nel cuore della nostra civiltà, artisti e filosofi hanno continuato a trattare la bellezza alla stregua di Platone: il bello era un rivelarsi del divino nel qui e ora.
Quest’approccio di tipo religioso al bello è stato prevalente per duemila anni. Poi, la Rivoluzione Scientifica del secolo XVII ha iniziato a piantare i semi del dubbio. La Chiesa medievale aveva accettato la visione del mondo antico in base alla quale la Terra era collocata al centro dell’universo. Poi Copernico [Mikołai Kopernik (1473-1543)] e Galileo [Galilei (1564-1642)] hanno provato che è la Terra a girare attorno al Sole[21] e Isaac Newton [1642-1727] ha perfezionato l’opera descrivendo l’universo come un orologio meccanico nel quale ogni momento segue deterministicamente quello che l’ha preceduto: ecco la visione del mondo propria dell’illuminismo, in cui non vi era più alcun posto né per Dio né per lo spirito, né per valori né per ideali. Non vi era posto per nient’altro che non fosse il moto meccanico e regolare cui si doveva la rivoluzione, priva di un qualunque fine, della Luna attorno alla Terra e quella della Terra attorno al Sole.
Proprio nel cuore dell’universo di Newton vi è una “lacuna a forma di Dio”[22], un vuoto spirituale. Un filosofo, in particolare, ha provato a colmarlo: Anthony Ashley Cooper, terzo conte di Shaftesbury [1671-1713]. La scienza spiega le cose, ma — sosteneva Shaftesbury — dà una descrizione del reale non esauriente. Noi possiamo vedere il mondo da un’altra prospettiva, non con un fine utilitaristico o per spiegarlo, ma provando piuttosto a contemplarne le manifestazioni, come un paesaggio o un fiore. L’idea che il mondo sia intrinsecamente pieno di senso e d’incanto — che non richiede l’adesione ad una particolare dottrina religiosa per essere colta — risponde a una profonda esigenza emotiva: la bellezza non è stata impiantata nel mondo da Dio, ma scoperta lì dagli esseri umani.
L’idea di Shaftesbury incoraggia il culto della bellezza, che eleva l’apprezzamento dell’arte e della natura al posto un tempo occupato dall’adorazione di Dio. La bellezza avrebbe riempito la lacuna a forma di Dio creata dalla scienza. Gli artisti, non più illustratori di storie sacre, né più al servizio della Chiesa, sceglievano da soli i soggetti, provando a interpretare i segreti della natura. I paesaggi, fino ad allora meri sfondi d’immagini sacre in primo piano, diventarono il soggetto principale e le figure umane elementi che, spesso, quasi si perdono in esso[23]. Tuttavia, per Shaftesbury, non è necessaria un’opera d’arte per imbattersi nella bellezza del mondo: bisogna solamente osservare la natura con occhi limpidi e libere emozioni. Quello che Shaftesbury tenta di dirci è di smetterla di cercare nelle cose che vediamo il modo in cui possono tornarci utili, di spiegarle e di spremerle quanto è possibile. Limitiamoci, invece, a guardarle: solo allora potremo capire quello che significano. Il messaggio del fiore… è il fiore. Anche i buddisti zen propongono un punto di vista simile. Solo dopo aver abbandonato ogni prospettiva utilitaristica, potremo percepire la vera essenza di un fiore e scoprirne la bellezza.
Il più grande fra i filosofi dell’illuminismo, Immanuel Kant [1724-1804], è stato fortemente influenzato dalle idee di Shaftesbury. Kant sosteneva che l’esperienza della bellezza è possibile solo mettendo da parte ogni nostro interesse utilitaristico per l’oggetto, rivolgendosi a esso non per raggiungere uno scopo o spiegare come funziona, né per soddisfare un bisogno o un appetito. Si tratta semplicemente, per così dire, di assimilarlo aderendo a quello che è. Pensate alla gioia che si prova tenendo fra le braccia il bimbo figlio di amici. Il bambino non soddisfa alcun tuo interesse specifico: non vuoi mangiarlo, non vi sono fini per i quali vuoi utilizzarlo, non vuoi condurre un esperimento scientifico su di lui. Tutto ciò che desideri è guardarlo e sentirti inondato del diletto che t’investe quando concentri tutti i tuoi pensieri su questo bimbo e assolutamente nessuno su te stesso. Questo è ciò che Kant descriveva come “atteggiamento disinteressato” che sta alla base della nostra esperienza della bellezza[24].
È estremamente difficile spiegarlo: se non se n’è fatta esperienza, non si potrà mai capire veramente di che cosa si tratta. Ognuno di noi, tuttavia, che abbia almeno una volta sentito un brano musicale bello, o guardato un panorama sublime, o letto una poesia che sembra contenere l’essenza delle cose che descrive, può dire: “Sì, mi basta l’esperienza che ho fatto per capirlo”.
Ma perché è così importante questo tipo di esperienza? L’incontro con la bellezza è così vivido, così immediato, così personale che sembra difficile possa appartenere alle cose ordinarie della vita quotidiana. Eppure la bellezza riluce su di noi proprio da esse. È una caratteristica del mondo in sé o è una finzione, un frutto dell’immaginazione?
Per la maggior parte del tempo, le nostre vite sono regolate dalle preoccupazioni quotidiane. Tuttavia, una volta ogni tanto, ci ritroviamo scalzati dalla nostra compiacenza e ci sentiamo alla presenza di qualcosa di gran lunga più significativo dei nostri interessi e desideri più immediati. Qualche cosa che non fa parte di questo mondo.
Da Platone a Kant, i filosofi hanno provato ad afferrare e a comprendere il modo peculiare in cui la bellezza si comunica a noi: come un raggio di luce solare o come una ricerca di amore. Per Platone, la spiegazione di una tale esperienza poteva solo sussistere in un’origine trascendente: parla a noi come la voce di Dio. E anche Kant, in un modo molto più sobrio, sosteneva che l’esperienza della bellezza ci mette in comunicazione con il mistero supremo dell’essere: la bellezza ci conduce alla presenza del sacro. Possiamo forse capire meglio ciò cui alludevano questi filosofi se riflettiamo sulle nostre sensazioni di fronte alla morte, specialmente a quella di una persona amata. Guardiamo con timore reverenziale il corpo da cui la vita è fuggita via. Siamo riluttanti a toccare il corpo morto; in un certo senso lo consideriamo non propriamente parte del nostro mondo, quasi fosse un visitatore da chissà quale altra sfera.
Lo stesso senso del trascendente si manifesta nell’esperienza che ispirò Platone: quella dell’innamoramento. Anche questo è un universale umano e si tratta di un’esperienza assolutamente singolare. Il volto e il corpo della persona amata sono intensamente permeati di vita. Eppure, da un punto di vista che è decisivo, sono equiparabili al corpo di un defunto: sembrano non appartenere al mondo della vita quotidiana. I poeti hanno speso migliaia di parole su questo tipo di esperienza che nessuna parola sembra totalmente in grado di afferrare.
Questi due grandi cambiamenti agli estremi della vita — il desiderio ardente di unirsi a un’altra persona e la perdita di una persona amata — sono momenti che noi cogliamo come sacri.
8. Dando uno sguardo alla storia dell’idea di bellezza, ci rendiamo conto che artisti e filosofi avevano le loro buone ragioni per mettere in relazione la bellezza e il sacro e per ritenere che la nostra esigenza di bellezza sia profondamente radicata nella nostra natura. È uno dei modi in cui si estrinseca il bisogno di consolazione in un mondo pieno di pericoli, di sofferenze e di angoscia. Oggi molti artisti guardano con disprezzo all’idea di bellezza, che sarebbe un rimasuglio di un modo di vivere ormai scomparso, non avente più alcuna reale connessione con il mondo che ci circonda.
Si è diffuso un desiderio di dissacrare l’esperienza del sesso e della morte che, espresso nel modo più volgare e impersonale, riesce a distruggerne il significato spirituale[25]. Allo stesso modo in cui quelli che, avendo perduto la fede nella loro religione, sentono l’impulso di deriderla, gli artisti sentono l’urgenza di umiliare la vita umana e di deridere il perseguimento della bellezza[26]. Questa dissacrazione deliberata comporta anche un rinnegamento dell’amore, un tentativo di rifare il mondo in modo tale che l’amore non vi faccia più parte. Questo, a mio parere, è l’aspetto più rilevante della cultura post-moderna, che è una loveless culture, una cultura senza amore che ritrae il mondo umano come sgradevole e non amabile.
Naturalmente l’atteggiamento d’indugiare sugli aspetti angosciosi della vita umana non è una novità. Fin dagli albori della nostra civiltà uno degli obbiettivi dell’arte era proprio quello di redimere in un’opera di bellezza ciò che della condizione umana vi era di più doloroso[27].
L’arte ha la capacità di redimere la vita, trovando bellezza anche nell’aspetto più orribile delle cose. La Crocifissione di Andrea Mantegna [1431-1506] esibisce la più crudele delle morti, riuscendo però a esprimere una maestà e una serenità capaci di redimere l’orrore che mostra. Di fronte alla morte, l’essere umano può ancora dimostrare nobiltà, compassione e dignità; e l’arte può aiutare ad accettare la morte presentandola in tale luce.
9. Che cosa si può dire, invece, degli aspetti che non sono tragici, quanto piuttosto sordidi o depravati? Può l’arte trovare bellezza anche in quest’ambito?
Il Letto disfatto dipinto nel 1828 da Eugène Delacroix [1798-1863] mostra il letto dell’artista in tutto il suo sordido disordine. L’opera riesce a portare la bellezza dove essa è assente, riversando una sorta di benedizione sul proprio caos emotivo. Delacroix sembra dire: “Guardate come queste lenzuola sgualcite e sudate rimandano all’energia e ai sogni tormentati della persona che vi era coricata. Guardate come la luce riesce ad animarle, quasi che l’uomo che vi dormiva si stia ancora rivoltando in esse”. L’atto creativo trasforma un semplice letto in qualcos’altro: un simbolo vivido della condizione umana capace di creare un legame fra noi e l’artista.
Vi sono persone che descrivono My Bed di Tracey Emin, del 1998, allo stesso modo, ma non vi potrebbe essere distanza più grande fra una vera opera d’arte — che riesce a rendere bello il brutto — e un’opera d’arte posticcia, che non fa altro che condividere il brutto che sfoggia[28]: questa sarebbe la vita moderna, esibita in tutta la sua aleatorietà e il suo disordine.
[A questo punto il documentario propone un brano di un’intervista di David Frost a Tracey Emin per il programma Breakfast with Frost del 1999:]
[Frost:] “Che cos’è che rende My Bed “arte” piuttosto che un letto in disordine?”.
[Emin:] “La cosa principale che lo rende “arte” è che io dico che lo sia”.
[Frost:] “Lei dice che lo è”.
[Emin:] “Sì, esatto”.
[Frost:] “…e in secondo luogo il fatto che lo dice la Tate. Che cosa le piacerebbe che dicesse il visitatore della Gallery? Forse: “Penso che sia bello”?”.
[Emin:] “No, ero io che pensavo a quello mentre lo facevo”.
[Frost:] “Quindi lei pensa che sia bello…”.
[Emin:] “Certamente. In caso contrario, non avrei voluto condividerlo con gli altri”.
[Riprende Scruton, riferendosi a My Bed:] Come può trattarsi di un’opera d’arte “bella” se manca il sia pur minimo tentativo di trasformare il materiale grezzo di un’idea? È solamente un frammento sordido di reale fra tanti altri; letteralmente, un letto non rifatto.
10. Siamo tornati al problema sollevato dall’orinatoio di Duchamp. È forse vero che ogni cosa può essere arte? Su questa domanda s’interrogano tanto i sedicenti innovatori tanto i tradizionalisti come Alexander Stoddart, uno scultore monumentale le cui opere campeggiano in numerosi luoghi pubblici di varie parti del mondo, non ultima la Queen’s Gallery a Buckingham Palace.
[Scruton dialoga con Stoddart]
[Scruton:] “Un difensore dell’arte concettuale[29] potrebbe sostenere che un’idea può essere bella. Vi è qualcosa di sbagliato nell’arte concettuale in quanto tale?”.
[Stoddart:] “Questa è un’opinione che può essere espressa in ogni campo delle attività umane: un avvocato, o anche un uomo di Stato, può ritenere bella un’idea. Il punto, tuttavia, è che, anche quando il medico ha una “bella” idea per la cura del cancro, non ritiene per questo di essere un artista.
“L’arte concettuale è legata interamente alla parola e si esaurisce nella sua descrizione verbale. Basta veramente che tu dica: “Mezza mucca in un contenitore pieno di formaldeide” e hai raggiunto il tuo scopo[30]. In sé, l’oggetto che realizza l’idea può anche essere buttato via. Anche il letto di Tracey Emin è un esempio che calza a pennello per ciò che intendo dire. Se ci s’imbattesse in quel letto in una discarica, lo si oltrepasserebbe senza neanche notarlo. La reazione sarebbe ben diversa trovando in quello stesso luogo il Torso del Belvedere[31]. Ci fermeremmo e, probabilmente, proveremmo anche ad arrampicarci per recuperarlo.
“Molti studenti vengono da me, dalle scuole di scultura delle accademie. Segretamente, però. Non vogliono dire ai loro professori che vengono a trattare con il nemico. Mi dicono che, quando provano a modellare una scultura figurativa, i docenti suggeriscono loro di rinunciarvi, di tagliarla a metà, di buttarci sopra del latte o qualcuno dei suoi derivati, così da renderla più “interessante””.
[Scruton:] “Ecco quello che provo io dinanzi all’ordinaria dissacrazione compiuta da ciò che, ai nostri giorni, s’intende per “arte”: credo, a dire il vero, che si tratti di una sorta d’immoralità; in un certo qual modo, un tentativo di annientare un qualunque senso insito nella forma umana”.
[Stoddart:] “…o di cancellarne completamente il concetto”.
L’establishment dell’arte ha voltato le spalle all’antico curriculum che poneva al primo posto la bellezza e il talento del mestiere. Quelli come Alexander Stoddart che intendono restaurare l’antica connessione fra la bellezza e il sacro sono ritenuti antiquati e insensati. Lo stesso tipo di critica investe i tradizionalisti nel campo dell’architettura. Fra gli architetti nel mirino vi è, ad esempio, Léon Krier che ha realizzato, seguendo le indicazioni del Principe del Galles [Charles Philip Arthur George Windsor], il quartiere di Poundbury, estensione urbana di Dorchester. Progettando strade discrete disposte in modo tradizionale, ricorrendo ad amatissime e rodate rifiniture, celebrate nel corso dei secoli, Léon Krier ha creato una cittadina semplice e schietta: le proporzioni sono a misura d’uomo e le rifiniture sono un riposo per la vista. Non è un’architettura grandiosa né originale e non intendeva esserlo. È solo un tentativo senza pretese di fare le cose nel modo giusto, seguendo modelli ed esempi suggeriti dalla tradizione. Non è questione di nostalgia, ma di conoscenza sedimentatasi un’epoca dopo l’altra.
Un’architettura che non rispetta il passato non rispetta il presente, poiché non considera il bisogno primario delle persone che l’architettura deve soddisfare: costruire una dimora duratura.
11. Ho già mostrato i vari modi in cui artisti e architetti hanno risposto alla chiamata della bellezza. Nel farlo, hanno dato un senso a questo mondo. I maestri del passato riconoscevano che siamo portatori di esigenze spirituali oltre che di appetiti animali. Per Platone la bellezza è un sentiero che porta a Dio. I pensatori dell’illuminismo hanno visto in essa e nell’arte un modo che ci salva da routine senza senso in cui la vita quotidiana può trasformarsi e ci eleva a un livello superiore. In seguito, l’arte ha voltato le spalle alla bellezza. È diventata una schiava al servizio del consumismo, che alimenta i nostri piaceri e le nostre dipendenze e si compiace in forme di autoripugnanza. Mi sembra questa la lezione delle manifestazioni più brutte dell’arte e dell’architettura contemporanee. Non intendono mostrare la realtà, piuttosto si vendicano contro di essa, deturpando quella che poteva essere una dimora e lasciandoci vagare sconsolati e alienati in un deserto spirituale. È naturalmente vero che molto ci distrae e c’inquieta del mondo che oggi ci circonda. Le nostre vite sono costellate di rovine, siamo costretti a combattere immersi nel rumore e in stati d’ansia e niente sembra risolversi. La giusta reazione, in ogni caso, non consiste nell’accettare questo tipo di alienazione, ma d’incamminarsi all’indietro lungo il sentiero che ci ha condotto nel deserto, lungo la direzione che ci condurrà in un luogo dove la realtà e l’ideale possano ancora convivere in armonia.
Nel corso della mia vita, ho trovato più facilmente questo sentiero attraverso la musica che in ogni altra forma d’arte. Giovanni Battista Pergolesi [1710-1736] aveva ventisei anni quando ha scritto il suo Stabat Mater, che descrive il dolore della Santa Vergine dinanzi alla Croce del Cristo morente. Le sue squisite frasi musicali riassumono in sé tutto il dolore del mondo. Giacché ai tempi della composizione del pezzo Pergolesi soffriva di tubercolosi, anche lui è quel figlio che sta morendo sulla Croce. Difatti, è morto pochi mesi dopo aver completato lo Stabat Mater.
Non è un’opera musicale complessa o ambiziosa. Semplicemente, è un’espressione sincera della fede del compositore. Essa mostra il modo in cui profonde e travagliate emozioni possono conseguire unità e libertà attraverso la musica. Il testo dell’inno mariano è affidato a due solisti; la melodia si eleva, lenta e dolorosa, e risolve le dissonanze solo chiudendosi in una nuova dissonanza quando le voci si scontrano, a rappresentare il conflitto e la pena dentro di Lei. “Siamo di fronte — spiega il soprano Catherine Bott — a un testo molto semplice e molto sacro. La Madre sta, dolorosa e piangente, presso la Croce cui è appeso il Figlio. Non vi è nient’altro da dire”. “Anche una persona del tutto ineducata musicalmente — aggiunge il controtenore James Bowman — riesce a carpire immediatamente il messaggio. È un pezzo che vuole comunicare un dolore che ogni cuore è capace di comprendere”.
La musica s’impossessa delle parole e ti parla tramite un linguaggio altro che si rivolge direttamente al tuo cuore. “Il che significa che, anche nel presente — dice Catherine Bott —, in un mondo secolarizzato, può essere fonte di diletto e commuovere, anche quando chi ascolta non sa esattamente di che cosa si tratti”.
Proprio così: senza bisogno di alcun impianto teologico, noi impariamo che questa cosa chiamata “sofferenza” esiste, che è il destino di ognuno di noi, ma che, allo stesso tempo, non è la fine.
12. In questo documentario ho descritto la bellezza come una risorsa essenziale. Attraverso il perseguimento della bellezza noi diamo al mondo la forma di una dimora e, così facendo, amplifichiamo le nostre gioie e troviamo consolazione per i nostri dolori. Le arti e la musica illuminano di senso la nostra vita quotidiana e, tramite loro, siamo maggiormente in grado di affrontare i problemi che ci angustiano. In loro presenza è più facile trovare pace e consolazione. Questa capacità della bellezza di redimere la sofferenza fa sì che la bellezza possa essere intesa come un succedaneo della religione. Ma perché dare priorità alla religione? Perché non dire il contrario? E cioè che è la religione a essere un succedaneo della bellezza?
In realtà non bisogna per forza opporre l’una all’altra come fossero rivali: il bello e il sacro camminano fianco a fianco. Sono due porte che si aprono entrambe su un unico scenario, lì dove troveremo la nostra dimora.
Note al testo
[1] Nel 1917, con il titolo Fontana e firmato “R. Mutt”, l’orinatoio fu sottoposto all’attenzione della Society of Independent Artists, un’associazione statunitense del cui direttivo faceva parte lo stesso Duchamp, per l’eventuale inclusione in una mostra. Sebbene la giuria avesse deciso di non esporre il pezzo, una fotografia dell’opera fu pubblicata sulla rivista The Blind Man, edita dallo stesso Duchamp, che, fingendo di difendere l’ignoto autore, scrisse: “Non è importante se Mr. Mutt abbia fatto Fontana con le sue mani o no. Egli l’ha SCELTA. Egli ha preso un articolo ordinario della vita di ogni giorno, lo ha collocato in modo tale che il suo significato d’uso è scomparso sotto il nuovo titolo e il nuovo punto di vista — ha creato un nuovo modo di pensare quell’oggetto” (cit. in Herman Hertzberger, Space and the Architect. Lessons in Architecture. 2, 010 Publishers, Rotterdam 2000, p. 35).
[2] Il riferimento è all’opera dell’inglese Martin Creed, conosciuta con il nome di Opera 227: le luci si accendono e si spengono e risalente al 2000. Consiste semplicemente in una stanza illuminata a intermittenza da lampadine tremolanti di vario formato, che ogni cinque secondi si spengono, per poi ricominciare a emettere la loro luce precaria. L’installazione ha conosciuto dal 2001 a oggi un grande successo di presenze nei musei di tutto il mondo ed è stata valutata più di 110.000 sterline.
[3] Il 21-5-1961, Piero Manzoni (1933-1963) applicò su novanta barattoli di conserva un’etichetta con la scritta “merda d’artista” in inglese, in francese, in tedesco e in italiano, identificando ognuno di essi con un numero progressivo da 1 a 90 accanto alla propria firma e mettendo in vendita i barattoli di circa trenta grammi ciascuno a un prezzo pari all’equivalente di trenta grammi d’oro. Agostino Bonalumi, fondatore con Manzoni della rivista Azimuth, ha dichiarato che all’interno delle famose scatole, in realtà, non vi è che gesso. Attualmente, i barattoli sono conservati in diverse collezioni d’arte in tutto il mondo e il valore di ciascuno è stimato intorno ai 70.000 euro. A Milano, il 23-5-2007, nel corso di un’asta da Sotheby’s, un collezionista privato europeo si è aggiudicato l’esemplare 18 a 124.000 euro.
[4] Lo scultore statunitense minimalista Carl Andre ha realizzato nel 1966 ed esposto alla Galleria Tibor de Nagy di New York Equivalents, cioè otto composizioni di 120 mattoni a due livelli sovrapposti di 60 mattoni ciascuno, accostati secondo le matrici di 3×20, 4×15, 5×12, 6×10 e proposti in due disposizioni diverse.
[5] Le immagini del documentario propongono a questo punto l’opera A Thousand Years, realizzata nel 1990 dall’inglese Damien Hirst: una grande cassa di vetro contenente una testa mozzata di mucca in decomposizione con vermi e mosche svolazzanti.
[6] L’intervista è stata mandata in onda il 5-6-1968 sul canale BBC2 nel corso del programma Late Night Line Up, presentato dalla giornalista Joan Bakewell.
[7] Nel testo, che è in forma di domande e risposte, fra l’altro si afferma: “Ma la quercia esiste solo nella mente. No. La quercia è effettivamente e fisicamente presente, ma in forma di bicchiere d’acqua. Esattamente come il bicchiere d’acqua è un preciso bicchiere d’acqua, anche la quercia è una quercia specifica. Perché concepire la categoria “quercia” o figurarsi una quercia particolare non è la stessa cosa che comprendere e sperimentare una quercia che ha l’aspetto di un bicchiere d’acqua. Così come non è percepibile, non è concepibile. La quercia specifica esisteva già da qualche parte prima che prendesse la forma del bicchiere d’acqua? No. Questa particolare quercia non esisteva prima. Vorrei inoltre sottolineare che non ha, e non avrà mai, altra forma al di fuori di quella di un bicchiere d’acqua. Per quanto tempo continuerà a essere una quercia? Finché non la cambio io” (cit. in Tony Godfrey, Conceptual Art, Phaidon, Londra 1998, p. 248).
[8] Il ready-made è un comune manufatto di uso quotidiano — un attaccapanni, uno scolabottiglie, un orinatoio, e così via —, che assurge a opera d’arte una volta prelevato dall’artista e posto in una situazione diversa da quella che gli sarebbe propria, in questo caso un museo o una galleria d’arte. Il valore aggiunto dell’artista consisterebbe nell’operazione di scelta, o anche d’individuazione casuale di acquisizione e d’isolamento dell’oggetto.
[9] Jeffrey Lynn “Jeff” Koons è nato a York, in Pennsylvania, nel 1955. Il suo stile opera una sintesi fra il ready-made di Duchamp e la pop art di Andy Warhol (1928-1987). Nel 1985 acquisisce notorietà grazie a Three Ball Total Equilibrium Tank, un acquario contenente tre palloni da pallacanestro immersi in acqua distillata. Sono anche molto noti Puppy, del 1992 — una scultura floreale alta tredici metri che raffigura un gigantesco fox-terrier —, nonché i suoi cani e fiori gonfiabili. Negli anni 1989-1990 Koons ha proposto Made in Heaven, un ciclo di sculture, dipinti e fotografie dai contenuti sessuali espliciti in cui l’autore stesso posa con Elena Anna “Ilona” Staller, attrice pornografica ungherese all’epoca deputata del Partito Radicale italiano, che Koons sposa — ma il matrimonio naufraga ben presto — nel 1991.
[10] Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, trad. it., Giunti, Firenze-Milano 2004, p. 22.
[11] Si tratta del secondo verso del sonetto The World is Too Much for Us; Late and Soon, scritto fra il 1806 e il 1807 e raccolto, per esempio, in Andrew Jackson George (a cura di), The Complete Poetical Works of William Wordsworth in Ten Volumes, vol. V, Cosimo, New York 2008, p. 36.
[12] La scultura di Damien Hirst For the Love of God — un teschio umano fuso in platino e tempestato di diamanti — fa la sua prima apparizione nel 2007 presso la White Cube Gallery di Londra. Per il titolo dell’opera sembra che Hirst si sia ispirato alle parole della madre: “Per l’amor di Dio, che cosa farai la prossima volta!?”.
[13] Sullivan ha fatto suo questo slogan coniato da Horatio Greenough (1805-1852) nell’articolo The Tall Office Building Artistically Reconsidered, in Lippincott’s Magazine, n. 57, Filadelfia (Pennsylvania) marzo 1896, pp. 403-409, disponibile all’indirizzo Internet <http:// academics.triton.edu/ faculty/ fheitzman/ tallofficebuilding.html>.
[14] “Non pensi […] che solamente allora, quando vedrà la bellezza con gli occhi dello spirito ai quali essa è visibile, quest’uomo potrà esprimere il meglio di se stesso? Non una falsa immagine egli contempla, infatti, ma la virtù più autentica, in piena verità. Egli coltiva in sé la vera virtù e la nutre: non sarà forse per questo amato dagli dèi? Non diverrà tra gli uomini immortale?” (Platone, Simposio, cap. XXIX, 212a, trad. it., Armando Editore, Roma 2008, pp. 121-122).
[15] Cfr. Thomas Malory, La morte di Artù, trad. it., Il Minotauro, Roma 1997.
[16] Cfr. Anonimo, Sir Gawain e il Cavaliere Verde, trad. it., Adelphi, Milano 1986.
[17] Cfr. Christopher Tolkien (a cura di), John Reuel Tolkien, Sir Gawain e il Cavaliere Verde – Perla e Sir Orfeo, trad. it., Edizioni Mediterranee, Roma 2009.
[18] Il racconto del cavaliere è il primo dei Racconti di Canterbury, scritti a partire dal 1387. Cfr. Geoffrey Chaucer, I racconti di Canterbury, trad. it., Mondadori, Milano 2004.
[19] Cfr. Edmund Spenser, La Regina delle Fate, trad. it., Sansoni, Firenze 1954.
[20] Ne sono esempi il ritratto della madre dell’artista, del 1630, quello di Nicolaes Ruts, del 1631, e quello di Aechje Claesdr, del 1634.
[21] In realtà, né Galileo né Copernico esibirono una prova definitiva che la Terra si muovesse lungo la propria orbita di rivoluzione. L’esperimento concernente le parallassi stellari annue risale, infatti, al 1837 ed è dovuto a Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846).
[22] L’espressione è solitamente attribuita al filosofo e scienziato francese Blaise Pascal (1623-1662); ciò che più vi si avvicina è il pensiero n. 425: “Che cosa gridano questa avidità e questa impotenza, se non che vi fu un tempo nell’uomo una felicità vera, di cui oggi rimane in lui soltanto il segno e l’impronta vuota, ed egli cerca inutilmente di riempirla con tutto quanto lo circonda, chiedendo alle cose assenti il soccorso che non ottiene dalle presenti, ma tutte ne sono incapaci, perché quel baratro infinito non può essere colmato se non da un oggetto infinito e immutabile, cioè da Dio stesso” (Blaise Pascal, Pensieri, trad. it., Città Nuova, Roma 2003, p. 179).
[23] Le immagini del documentario, a questo punto, propongono un confronto fra la Madonna con Bambino di Raffello Sanzio (1483-1520) e i paesaggi pastorali di Claude Lorraine (1600-1682).
[24] “Il miglior modo per commentare questa importantissima proposizione è di contrapporre alla pura e disinteressata soddisfazione del giudizio di gusto quella legata all’interesse” (Immanuel Kant, Critica del giudizio, trad. it., UTET, Torino 1993, p. 181).
[25] Fra le immagini che esemplificano il concetto Scruton propone l’opera Chicken Knickers, “mutande di pollo”, della britannica Sarah Lucas. L’opera è così descritta sul sito della Tate Gallery: la foto del 1997 ritrae “[…] la parte inferiore del corpo dell’artista che indossa un paio di mutande cui è stato attaccato un pollo. Il suo orifizio posteriore è collocato all’incirca in prossimità della vagina di lei. Lucas usa alimenti come sostituti dei genitali, sia maschili sia femminili, dai primi anni ’90“. Cfr. la descrizione all’indirizzo Internet: <http:// www.artinfo.com/ news/ story/ 30161/ sarah-lucas>.
[26] Un esempio in tal senso è Shitty Word, del 1994, del duo Gilbert [Prousch] & George [Sullivan], dove i corpi nudi dei due artisti campeggiano, disposti paratatticamente in un panorama dominato da gigantesche feci a forma di croce.
[27] Il documentario propone a questo punto la struggente scena del Re Lear di William Shakespeare (1564-1616), in cui il sovrano porta fra le braccia il corpo della figlia Cordelia.
[28] L’opera, inizialmente esposta nella Tate Gallery e poi acquistata da Charles Saatchi per 150.000 sterline, consiste in un letto sfatto con lenzuola imbrattate di secrezioni organiche, con biancheria intima sporca e con altri detriti sparsi ai suoi piedi.
[29] Il movimento dell’”arte concettuale”, di cui sono precursori Renè François Ghislain Magritte (1898-1967) e Marcel Duchamp, si sviluppa a partire dagli anni 1960 adottando una concezione dell’arte che rifiuta d’identificare il lavoro dell’artista con la produzione di un qualsiasi oggetto di più o meno rilevante qualità estetica. I concettualisti ritengono, piuttosto, che l’essenza dell’arte sia invece nell’idea, nel concetto che precede e conforma l’opera. Caposcuola riconosciuto dell’arte concettuale è lo statunitense Joseph Kosuth che, nel 1965, esibisce Una e tre sedie: accanto a una vera e propria sedia vi sono una fotografia della sedia stessa e una riproduzione ingrandita del relativo lemma di vocabolario.
[30] Stoddart si riferisce all’opera di Hirst premiata con il Turner Prize nel 1995.
[31] La statua ricordata con questo nome, pervenutaci priva della testa e di gran parte degli arti inferiori, fu scolpita a Roma nell’ultimo secolo della repubblica dall’ateniese Apollonio. Rimangono incerti la ricostruzione dell’opera originale e l’identità di chi vi è rappresentato. Michelangelo l’ha studiata disegnandola sotto ogni aspetto.



