Giacomo Poretti: il primo ricordo. «Forse quella cosa lì, la vita, non doveva essere poi così male...»
- Tag usati: giacomo_poretti
- Segnala questo articolo:
Riprendiamo sul nostro sito un testo di Giacomo Poretti, tratto da Poretti G., Alto come un vaso di gerani, Mondadori, Milano, 2012, pp. 133-135, dove è l’ultimo capitolo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per altri testi dello stesso autore, cfr. il tag giacomo_poretti.
Il Centro culturale Gli scritti (15/5/2016)
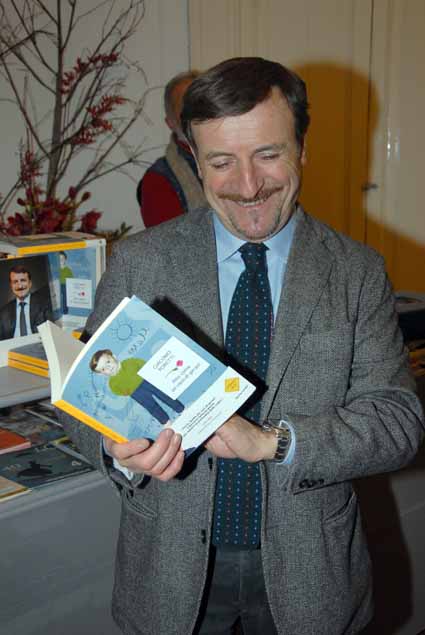
Il primo ricordo
Ho cominciato a piangere che eravamo quasi arrivati in ospedale. Calcolando che saranno passati almeno quaranta minuti dalla chiamata effettuata dall'unico telefono del paese, più almeno un quarto d'ora in cui la levatrice, prima di arrendersi, mi ha malmenato, immerso nell'acqua sia fredda sia calda, urlato nelle orecchie e pizzicato, insomma ci ho impiegato quasi un'ora a urlare tutto lo stupore che provavo per essere venuto al mondo. Un'ora in apnea con il fiato sospeso a guardare dove ero capitato. Ma come avrò fatto?
Si stava stretti nell'ambulanza e tutti mi davano per spacciato: la levatrice, la nonna grande e la nonna piccola (si chiamavano entrambe Maria le nonne, e per non confonderle le avevamo ribattezzate in quel modo), l'autista e il portantino, tutti pensavano di portarmi al cimitero anziché all'ospedale. Solo mia mamma aveva fiducia in me, nonostante fossi diventato color blu cobalto e mi ostinassi a non piangere. Forse una delle nonne, mossa da pietà, deve avermi messo nelle braccia di mia mamma, come a dire «guarda com'è ridotto, non ci fanno neanche salire in pediatria...». Dopo un secondo che ero nella posizione dov'ero sempre stato e dove avrei voluto rimanere per sempre, ho emesso un urlo tale che ho fatto sbandare l'autista dell'ambulanza. Sono sicuro che la mamma mi ha capito: «Ma cosa mi hai combinato, dove mi hai portato, mamma?...».
Lei mi ha accarezzato la testa e io mi sono addormentato, era il Millenovecentocinquantasei.
Al mio papà non gliel'ho mai chiesto dove fosse in quel momento, ma, conoscendo la sua timidezza imbarazzante negli attimi cruciali, forse stava inseguendo l'ambulanza in bicicletta. Certo che avrei potuto salutarlo con la manina, dopo che mi sono messo a piangere, ma non riuscivo a staccare gli occhi dalla mamma.
Che roba strana la vita, non sapevo se essere contento o spaventato.
Molti sostengono che si inizia a pensare dopo qualche anno, ma non è vero: io, dalla paura, ho iniziato subito, e mi sono accorto che i pensieri venivano da soli, senza che io li chiamassi alla forma o ne ordinassi con volontà una direzione piuttosto che un'altra. No, venivano da sé, io potevo solo registrare il loro formarsi e il loro turbinare: «La vita, chissà perché c'è? E invece, piuttosto che esserci, perché non c'è niente? Perché c'è qualcosa e non il vuoto, il nulla?».
Me le sono sempre sentite addosso queste domande, fin dal primo momento che l'aria è potuta entrarmi dalla bocca, fin da quando ho aperto gli occhi, insomma. Avrei voluto rivolgere quei perché a mia madre, alle nonne, poi al medico in ospedale: «Perché? Ehi, ascoltatemi! Cos'è questa roba? Perché c'è la vita, perché? Ehi, dottore, dico a lei, perché?...».
Ma erano tutti indaffarati a farmi piangere, più piangevo e più erano contenti, e io li accontentavo, cercavo i loro occhi e avrei voluto parlare, ma ho scoperto, dopo, che sarebbe passato almeno un anno prima di poter sbiascicare soltanto qualche monosillabo. Eppure li guardavo negli occhi e mi sorridevano contenti, ma nessuno intuiva l'inquietudine che avevo dentro il cuore, la mamma era così felice che io piangessi che si sciolse in lacrime anche lei, e così ho pensato che forse quella cosa lì, la vita, non doveva essere poi così male...



