Una lezione sul Risorgimento. File audio di una lezione di Andrea Lonardo
- Tag usati: file_audio_andrea_lonardo, risorgimento
- Segnala questo articolo:
Riprendiamo sul nostro sito il file audio di una lezione di Andrea Lonardo sul Risorgimento tenuta presso la chiesa di Santa Maria in Traspontina il 25/10/2014. Per ulteriori file audio vedi la sezione Audio e video.
Il Centro culturale Gli scritti (2/11/2014)
| Registrazione audio Download risorgimento_20141025.mp3. Riproducendo "risorgimento 20141025". |
ANTOLOGIA DI TESTI UTILIZZATA NEL CORSO DELL'INCONTRO
Il Risorgimento e la Chiesa (presso Santa Maria in Traspontina)
(www.gliscritti.it www.catechistiroma.it Canale Youtube: Catechistiroma FB: Andrea Lonardo)
Appuntamenti e news
- È on-line il nuovo sito con i video per la formazione dei catechisti corredato di testi per l’approfondimento e immagini al link Nuovo sito con i video per la formazione dei catechisti corredato di testi per l’approfondimento e immagini
- domenica 9 novembre, nuovo incontro con Franco Nembrini sulle regole e l’educazione, presso Ognissanti (teatro), ore 21.15
-mercoledì sera 12 novembre, ore 19.00, e sabato mattina, ore 10.00, Una Bibbia da amare. Il male nella Sacra Scrittura (sono già previsti gli interventi del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni su Genesi 3, di Bruna Costacurta su Giobbe, di Antonio Pitta su Romani, di Andrea Lonardo su il male nel linguaggio della catechesi), presso il Seminario Maggiore
- 21-23 novembre (venerdì pomeriggio ore 16.00 circa-domenica mattina ore 13.00 circa), stage su Disabilità e catechesi presso l’Università cattolica con interventi specifici su sussidi nella catechesi, autismo, pastorale dei sordi
1/ I luoghi del potere temporale e del Risorgimento a Roma: immagini a mo’ di introduzione
1a/ Città leonina (Leone IV), con le mura di passetto di Castello e l’origine del potere temporale della Chiesa
Tor Cervara ed il Campus barbaricus

La battaglia di Ostia (Raffaello, Stanze di Raffaello)
1b/ Città Leonina e Risorgimento
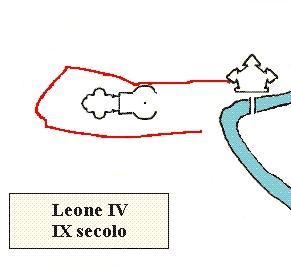
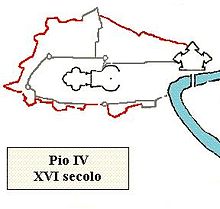
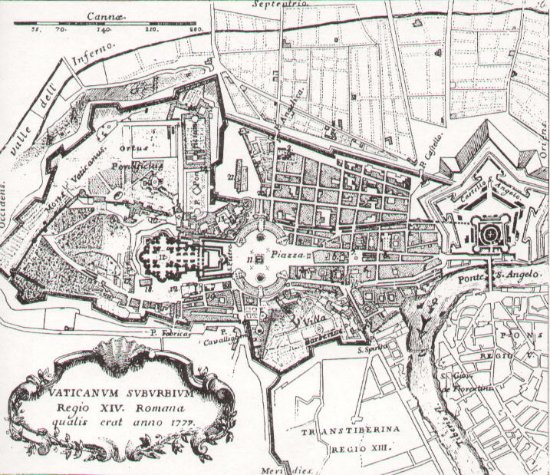
La breccia di Porta Pia e l’amicizia non solo “inimica”. Non ci fu solo il 20 settembre 1870, ma anche il 21 settembre che rivela un incredibile dialogo fra la nuova Italia e Pio IX. Appunti di Andrea Lonardo sulla documentazione immediatamente successiva alla Presa di Porta Pia (su www.gliscritti.it )
«Nella sua lettera a Pio IX dell’8 settembre 1870[1] con cui annunciava l’ingresso delle truppe italiane in quel che rimaneva del secolare Stato della Chiesa, il re d’Italia Vittorio Emanuele II aveva invitato il pontefice a non voler cogliere in questo “provvedimento di precauzione” un atto ostile, quanto piuttosto una “indeclinabile necessità” motivata dalla comune apprensione “per la sicurezza dell’Italia e della santa Sede”, e gli aveva esplicitamente promesso, all’art. 2 del modus vivendi accluso, che una parte di Roma, detta città leonina[2], sarebbe rimasta sotto la “piena giurisdizione e sovranità” del capo della Chiesa[3]»[4].
Così scrive S. Marotta: incredibile è quella “comune” apprensione di due contendenti, il re Vittorio Emanuele II e papa Pio IX, che pure sembrano amici e si stimano!
Dai documenti appare chiaro che la decisione di lasciare al Papa un sia pur esiguo dominio - senza specificare espressamente se tale territorio avrebbe avuto lo statuto di vero e proprio stato o un differente tipo di sovranità - venne da parte piemontese[5]:
«Se dunque l’atto ufficiale di capitolazione della Piazza di Roma, firmato a Villa Albani il 20 settembre, recitava ancora una volta che l’intera città con bandiere ed armamento era consegnata al re d’Italia “tranne la parte che è limitata al sud dai bastioni di Santo Spirito, e che comprende il monte Vaticano e Castel Sant’Angelo, costituenti la città leonina”, ciò non fu dovuto ad un’istanza sollevata dai rappresentanti dell’esercito pontificio, ma all’iniziativa del generale Cadorna che, inserendo tale clausola, si atteneva a precise direttive del governo di Firenze, confermategli per telegramma il 18 settembre[6]. La preoccupazione di evitare fino all’ultimo l’atto di violenza era stata all’origine della lunga attesa davanti alle mura di Roma, prima di iniziare le operazioni di attacco, e di nuovo la necessità di garantire al pontefice un pur esiguo lembo di territorio era stato il criterio con cui il generale italiano aveva proceduto all’occupazione della città, arrestando infatti le truppe prima dell’attraversamento di ponte Sant’Angelo».
La non chiara definizione dello status del territorio governato dal papa persisterà fino al Concordato del 1929, ma l’origine di tale autonomia ha inizio nel 1870. Mai le autorità italiane negli anni che seguirono violarono i confini assegnati al pontefice, ma, al contempo, come aveva ben scritto Giosuè Carducci chiamando Mastai “cittadino”, più volte si opporranno alla pretesa del papa di avere una voce autonoma che si rivolgesse direttamente ai capi delle nazioni, come avvenne ad esempio in occasione della I guerra mondiale: solo il re ed il suo governo dovevano avere rapporti immediati con le diverse nazioni, il pontefice li doveva avere previa consultazione con le autorità italiane[7].
La concordia discorde che nacque il 20 settembre 1870 è evidente nei fatti che avvennero il giorno successivo. Non è chiaro se alla sera del 20 o nella notte si verificarono dei tumulti nella città leonina– si può ipotizzare che furono provocati da personaggi di un più accesso anticlericalismo, come mazziniani o garibaldini, che probabilmente, approfittando della situazione volevano forzare la mano ai piemontesi, introducendosi nei Palazzi apostolici o, comunque, nella città leonina.
Allora – raccontano le fonti – il papa Pio IX richiese al generale Cadorna di occupare la città leonina, arrestandosi al colonnato del Bernini ed alle mura del palazzo Apostolico.
Così recitano le fonti[8]:
«Sera. Il ministro e il capo dello stato maggiore sono ricevuti dal papa e dal cardinale Antonelli. (…) d’ordine di Sua Santità si scrive al generale Cadorna, invitandolo a occupare la città leonina. Questa lettera è portata l’indomani dal barone Arnim a Cadorna, mentre questi assiste allo sfilamento delle truppe pontificie. Cadorna ordina che il desiderio del papa sia esaudito e occupata la città leonina»[9].
Al tenore del testo di questo Diario corrisponde la richiesta esplicita che fu recapitata al generale Cadorna[10]:
«A S.E. il generale Cadorna – Comandante il 4° corpo d’esercito
Roma, 21 settembre 1870
La Santità di Nostro Signore mi incarica significarle che desidera che Ella prenda delle disposizioni energiche ed efficaci per la tutale del Vaticano, mentre essendo state sciolte tutte le sue truppe non ha modo d’impedire disordini sotto la sua residenza sovrana. Con distinta considerazione
Il generale comandante le truppe - Kanzler»[11]
Il generale Cadorna informò il re della richiesta, dichiarando che riteneva opportuno obbedire alla richiesta pontificia[12]:
«T. riservato.
Roma, 20 settembre 1870, ore 23,50 (pervenuto ore 2,15 del 21)
Per disordini successi in città leonina, causati da sdegno popolare contro Gendarmi pontifici, papa chiese truppe con insistenza per tutela ordine. Ho aderito, parendomi ciò opportuno e conveniente. Ne informo V.E.»[13]
Al generale giunse la risposta del re che lo rassicurava, invitandolo a procedere come suggeriva di fare, poiché tutto doveva essere adempiuto, nei limiti del possibile, per venire incontro ai desideri di Pio IX[14]:
«Il suo contegno verso il Pontefice deve essere sommamente benevolo e conciliativo, usargli tutti i riguardi dovuti ad un sovrano, rassicurarlo sulla ferma volontà del governo italiano d’impedire ogni offesa o sfregio alla religione e ai suoi ministri, mantenere severamente l’ordine e la sicurezza delle persone, delle proprietà. (…) Del resto si ispiri ai sensi espressi da S.M. nella lettera al Pontefice, ed alle istituzioni date al conte di San Martino. Lanza»[15].
Il generale Cadorna rispose al pontefice, sottolineando comunque, a scanso di equivoci, che le truppe entravano nella città leonina solo perché richieste dal papa e non per iniziativa italiana[16]:
«Ho aderito immantinente alla richiesta fatta da S. Santità per la tutela del Vaticano, rappresentatami dalla S. V. che poteva ancora riconoscere come organo del governo pontificio perché prima della reddizione. Ciò ho fatto molto di buon grado sebbene deciso, come da disposizioni avute dal governo di S.M. il Re d'Italia, ad astenermi da qualsiasi ingerenza nella città leonina, ma trattandosi della tutela dell'ordine specialmente nella residenza del Sommo Pontefice, io non ho esitato un istante ad annuirvi.
Su’ (sic) tale riguardo però debbo soggiungerle come io dovessi ritenere dopo quanto Ella mi disse verbalmente nel trattare delle condizioni della resa, che con le truppe e milizie non combattenti che desiderava stessero nella città leonina, fosse pienamente assicurato l'ordine e la tranquillità; di modo che non erami sfuggito che ciò era si grande interesse, ma solo credeva esservisi provvedute dopo le assicurazioni esplicite dell’E.V.»[17].
Marotta così esplica il motivo di tale dichiarazione:
«Esprimendo la propria sorpresa per una tale richiesta, Cadorna teneva ad allontanare da sé eventuali accuse di imprevidenza, sottolineando come fosse stato Kanzler stesso ad assicurargli il 20 settembre che la truppa rimasta a disposizione del papa sarebbe stata sufficiente a garantire l'ordine e la sua sicurezza. A suo parere, non era dunque per negligenza dell'esercito italiano che si erano verificati quegli incidenti, del resto prevedibili»[18].
Cadorna si preoccupò comunque di affrontare immediatamente la questione delle fasi successive all’ingresso delle truppe italiane nella città leonina: la presenza di esse doveva essere considerata permanente? Anche in questo dettaglio non irrilevante emerge l’atteggiamento di benevolenza del governo italiano nei confronti del papa, quasi esistesse un’“amicizia” fra i due contendenti:
«Nella giornata del 22 settembre Cadorna ricevette due brevissimi telegrammi, indirizzatigli rispettivamente il primo da Visconti Venosta e il secondo da Lanza. Al ministro degli esteri il generale alle 12 circa aveva scritto: “Come V.E. già conosce, occupata ieri con truppe in seguito di richiesta che ho desiderato autentica anche città leonina. Mi occorre ora conoscere nettamente dal Governo se debbo dichiarare che truppe saranno ritirate dietro richiesta consimile”[19]. Appunto alle 14,30 Visconti Venosta brevemente gli rispondeva: “Ella può dichiarare esplicitamente che le truppe saranno ritirate dalla città leonina sulla medesima richiesta per la quale furono mandate”[20]. Alle 18,45 un telegramma riservato del presidente del consiglio gli confermava: “riguardo alla continuazione della occupazione della città leonina per parte delle nostre truppe di cui al suo telegramma n. 198 si conformi volontà papa”[21]»[22].
Le disposizioni erano, quindi, ancora una volta di conformarsi alla volontà del papa. E subito il generale Cadorna informò di tale decisione il pontefice:
«Prima della reddizione della Guarnigione di Roma ricevei dal Generale Kanzler, che allora avea ancora carattere Ufficiale, una Nota con cui chideami che avessi provveduto alla tutela dell’ordine nella città leonina, minacciata da turbolenze di piazza. Io avea ragione di credere che ciò non avvenisse, dopo le dichiarazioni avute personalmente dal Generale Kanzler, quando si recò al mio Quartier Generale di Villa Albano (sic!) per trattare delle condizioni di resa. Ne era tanto più convinto, in quanto che avea annuito interamente e di buon grado, secondo le istruzioni formali ed esplicite del Governo di S.M. il Re d'Italia, a tutte le dimande da lui fattemi per ritenere le Truppe e milizie non dipendenti dal Ministero per le armi, le quali rimasero ad esclusiva dipendenza di S.S. il Sommo Pontefice nella città leonina. Tuttavia chiestami della Truppa pel Vaticano la mandai subito a tutela dell’ordine, che è mia cura serbare dovunque, e molto più presso la residenza di S.S.
Stando le cose in tali termini, io ho l’onore di dichiarare ora all’E.V. eminentissima, che come le Truppe Italiane sono entrate nella città leonina per desiderio di S.S. il Santo Padre, così saranno immediatamente ritirate ad ogni cenno me ne verrà fatto dell’E.V. giacché il Governo di S.M. il Re d’Italia tiene a rispettare l’indipendenza del Sommo Pontefice.
Con quest'occasione aggiungo all’E.V. come un Uffiziale che è a Castel Angelo si è a me rivolto perché provvedessi alle munizioni ed armi che sono in detto forte senza cura né custodia, e che potrebbero dar luogo ad inconvenienti; ma io mi asterrò da qualunque passo, senza averne formale invito dall'E.V.
Spero che l’E.V. vorrà scorgere in questa comunicazione che ho l’onore di rivolgerle i sensi di ossequio e di rispetto che fedele interprete dei sensi di S.M. il Re D’Italia e del suo Governo, ho pel Sommo Pontefice e per l’indipendenza della sua Autorità, soggiungendoLe come ascriverei a mia grande ventura, se mi si offrisse l’opportunità di fare personalmente atto di omaggio al Santo Padre.
Il Luogotenente Generale Comandante il 4° Corpo d'Esercito R. Cadorna»[23].
Una volta che giunse tale dichiarazione, la risposta del pontefice si fece attendere per due giorni. Evidentemente doveva essere chiaro da parte vaticana che il tenore della risposta avrebbe implicato indirettamente l’accettazione o meno della definitiva presenza di truppe italiane nella città leonina. Infine giunse la risposta del cardinale Antonelli, di cui è conservato l’originale estremamente tormentato, fino alla redazione finale:
«Facendomi un dovere di corrispondere a siffatta di Lei comunicazione è mestievi il premettere un qualche schiarimento all’uopo necessario. Le truppe non dipendenti dal Ministero delle armi consistono in poche Guardie nobili <che prestano un servizio di Anticamera, e di scorta nelle sortite del S. Padre>, in un centinaio di uomini della Guardia Svizzera ed in pochi gendarmi destinati [al servizio] <alla perlustrazione> interna de’ palazzi di S. S., mentre la Guardia Palatina [che] è un corpo non assoldato, ma bensì di volontari, <nella generalità auti[sti]<eri><che [presta servizio] adempie al suo istituto abitual[e]<mente> come Guardia d'onore nelle anticamere del Santo Padre, e nelle sagre funzioni. Con sì ristretto numero di militari, cui incombe di prestare assistenza onorevole alla S.S. e di attendere alla polizia interna de’ Sagri palazzi apostolici, vedrà facilmente l’E.V. esser loro impossibile di provvedere all'ordine esterno, ed insieme all’officio proprio della polizia nel Vaticano, avuto specialmente riguardo alla condizione in cui [trovasi] è ridotta questa capitale. Il perché si ravvisò opportuno il presidio da Lei destinatovi, come ne sarà [<per ora>] opportuna la continuazione.
Quanto al rilievo da Lei dedotto rapporto al Castel s. Angelo, ed alle munizioni ed armi, che vi si conservano, non saprei in che modo provvedervi [nella scarsezza della milizia] <nel ristretto numero di veterani> lasciat[a]<i> al S. Padre, e nel bisogno altronde sentito di custodir[lo]<e quel Forte> [ed anco] <e di> preserva[rlo]<ne l'armamento> da ogni possibile pericolo.
[Mi riservo di parteciparle in seguito quando possa l’E.V. conseguire lo scopo del desiderio espressomi] <Del resto nella posizione [condizione] in che trovasi <oggi>[ridotto] il Santo Padre non saprei indicarle quando potrebbe offrirsi l’opportunità cui accenna l’E.V.> nella fine del citato suo foglio, ed intanto mi valgo del presente incontro per dichiararle i sensi della mia considerazione»[24].
Quando sopraggiunse la risposta vaticana il segretario agli esteri Albert Blanc comunicò al ministro questo messaggio[25]:
«Papa e Antonelli esprimono in conversazioni particolari bienveillant (sic) per le nostre truppe di cui riconoscono condotta esemplare. L’impressione generale è che il Vaticano non è radicalmente ostile tuttavia non è impossibile che sia ancora lanciata la scomunica»[26].
Il tenore di questo telegramma mostra che in quei giorni ci furono conversazioni frequenti fra le autorità italiane e quelle pontificie e che, nonostante la possibilità di scomunica, da parte papale si riconosceva la condotta esemplare delle truppe.
Blanc, che era come si è detto l’inviato degli Esteri a Roma, testimoniò addirittura della disponibilità da parte vaticana a concedere alloggio e assistenza medica ai soldati nelle strutture ospedaliere pontificie che erano all’interno della città leonina, come, ad esempio, il Santo Spirito in Sassia[27]:
«Il Cardinale mi parlò poi dell’opportunità che noi, senza preoccuparci di questioni politiche che è inteso debbono essere lasciate da parte, riducessimo le nostre truppe anche nelle caserme della città leonina come nel Castello Sant'Angelo, per non lasciarle in questa stagione e nella notte all'aria aperta. Io osservai che il generale poneva in ciò tanto scrupolo che non permetteva neppure che s'inviassero negli ospedali della città leonina altri ammalati che quelli dei distaccamenti stanziati nella città leonina stessa. A ciò il Cardinale replicò che era per il papa quistione di semplice carità d’aprire tutti gli ospedali ai nostri soldati; egli mi pregò di dire al Generale che disponesse pure degli ospedali militari anche della città leonina e s’impegnò spontaneamente di ottenere dal papa che ordinasse al Commendatore capo dell’Ospedale di Santo Spirito, di fondazione particolare, di ammettere gratuitamente i nostri militari in quello stabilimento»[28].
Lo stesso atteggiamento di disponibilità, sebbene con alcune varianti, emerge anche nella relazione che Cadorna fece al ministro Ricotti il 26 settembre 1870[29]: «A questo ufficiale diedi pure lo incarico di far sentire al prefato (sic) cardinale, che sarebbe stato necessario per l’igiene che le truppe destinate a tutela dell’ordine nella città leonina, fossero quivi ricoverate in qualche locale, invece di rimanere al bivacco per le piazze e per le vie, come stettero finora. Ed inoltre che i malati di queste truppe fossero ricoverati nell’Ospedale di S. Spirito e nell’Ospedale militare che trovasi in quella parte della città. Alla prima domanda rispose adesivamente il cardinale, ed anzi egli spontaneamente, non conoscendo al momento quali fossero i locali da utilizzarsi per alloggiare Truppe della città leonina, propose che si occupasse da noi il Castello S. Angelo, che pel bisogno di cui trattasi offre considerevoli risorse. (...) In quanto alla seconda richiesta, cioè per gli Ospedali, si riservò di rispondere, perché non dipendeva totalmente da lui il poter dare l’adesione: promise però d’interessarsene. S. eminenza il cardinale Antonelli fece pure verbalmente istanza all’Ufficiale di Stato Maggiore, perché fossero ritirate altre munizioni abbandonate sui bastioni dietro al palazzo Vaticano, e si vuotassero i cannoni rimasti carichi. E finalmente dimostrò il desiderio che i veterani (circa 200) rimasti in Castel S. Angelo fossero provvisti da noi di viveri e delle loro competenze»[30].
In questa versione dei fatti sembra essere il generale italiano a fare la richiesta di poter alloggiare le truppe nell’ospedale di Santo Spirito, ma tale richiesta mostra, a suo modo, le relazioni “amichevoli” fra le due parti.
Tra l’altro Cadorna così scrisse successivamente al cardinale Antonelli il 26 settembre[31]:
«Sono riconoscente a Vostra Eminenza che nell’interesse dell’igiene delle Truppe mi abbia spontaneamente fatta facoltà di poter accasermare porzione delle medesime nel Castello S. Angelo ed in quegli altri locali già ad uso militare in codesta parte della città. Con questa misura mi sarà dato di raccogliere in siti più convenienti per la loro salute i drappelli che ora bivaccano per le piazze e per le vie e che forniscono appunto le Sentinelle e le pattuglie a tutela della pubblica quiete.
Ringrazio pure l’Em.V. dell’intenzione manifestatami per mezzo del precisato ufficiale di Stato maggiore d’interessarsi onde siano accettati all’Ospedale di S. Spirito e nell’Ospedale Militare gli individui appartenenti alle Truppe alloggiate nella città leonina i quali cadessero ammalati: su questo riguardo attenderò dall’Em.V. il cenno che ebbe la cortesia di promettermi»[32].
Addirittura si giunse, da parte italiana, all’atto di dissuadere gli ufficiali italiani dal visitare i Musei Vaticani – diversi ufficiali dovevano essersi presentati in quei giorni per ammirarne le opere, altrimenti non si spiegherebbe un tale intervento disciplinare – per non infastidire le autorità pontificie che dovevano aver fatto presente il fatto in forma privata[33]: «Eppure in una comunicazione “minore” al Segretario di Stato, con la quale lo avvertiva di aver provveduto ad evitare che gli ufficiali italiani si presentassero in Vaticano per visitare i musei, onde rimediare ad una scomoda presenza di cui il Pontefice evidentemente si era lamentato, Cadorna sembrerebbe non riuscire a trattenere una certa reazione polemica: “Benché le domande degli Uff. possono essere giustificate e sensate dal desiderio di ammirare le meraviglie artistiche raccolte nel Vaticano, tuttavia ho dato ordine che d’or innanzi si attengano dall’inoltrare simili domande”»[34].
La stessa “delicatezza” appare nella relazione con cui Blanc riferisce dell’incontro avuto con il cardinale Antonelli in merito alla possibilità che un’autorità di alto livello da parte italiana renda visita al pontefice[35]:
«Dissi poi che ero informato come lo era anche il Generale Cadorna che sua Maestà non avea mandato espressamente un personaggio a Sua Santità per pura delicatezza, ma che se Sua Eminenza credesse che al papa non dispiacesse ricevere un suo inviato Sua Maestà gli manderebbe subito uno dei Ministri, essendo suo vivissimo desiderio fare ogni cosa possibile per rendere la situazione meno penosa per Sua Santità. Il cardinale mi rispose che apprezzava la delicatezza di un’astensione che era preferibile per ora, l’invio d’un ministro o altro personaggio espressamente mandato non potendo attualmente che accrescere la difficoltà»[36].
2/ Quirinale

La Torretta del Quirinale con bandiera italiana, europea e presidenziale,
croce, campane, iscrizione pontificia e Madonna con Bambino
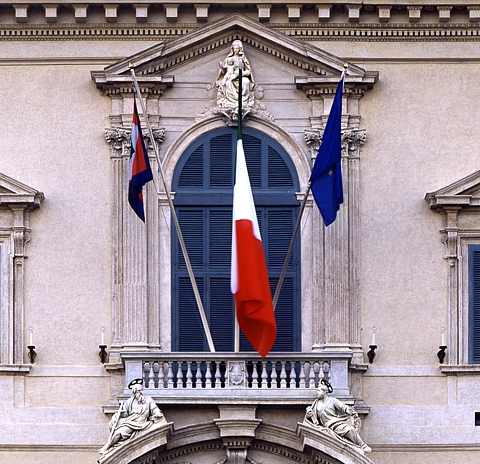
La Loggia delle benedizioni sopra il Portale d’ingresso del Quirinale
con le 3 bandiere, Madonna con Bambino e SS. Pietro e Paolo
3/ Il Vittoriano
Il Vittoriano: breve guida alla comprensione dei simboli del monumento al primo re d’Italia ed all’Unità della Patria. Un monumento risorgimentale che cela però la storia d’Italia, di Andrea Lonardo (www.gliscritti.it )
La statua del re Vittorio Emanuele II, fulcro del monumento del Vittoriano a lui dedicato, poggia su di un basamento marmoreo dove sono rappresentate le città d'Italia: è l'Italia dei comuni su cui si poggia l'unità della patria. Lì si vedono i simboli della cultura e della tradizione italiana e non solo quelli creati artificialmente nell'ottocento. E lì, ovviamente, appare anche il simbolo della croce, ad esempio, nelle raffigurazioni di Genova e di Milano. Ma appaiono anche altri simboli cristiani, come il leone dell'evangelista San Marco, a rappresentare Venezia.
Oltre ai simboli cristiani appare nell’iconografia delle 14 città prescelte – Torino, Venezia, Palermo, Mantova, Urbino, Napoli, Genova, Milano, Bologna, Ravenna, Pisa, Amalfi, Ferrara, Firenze – tutta una simbologia che, pur non essendo esplicitamente cristiana, rinvia alla storia della nazione che ha visto, fra gli altri, anche il ruolo decisivo giocato dal cristianesimo e dalla chiesa: si pensi, ad esempio, a Ravenna, che è rivestita delle vesti bizantine dell’esarcato, a Firenze con la testa coronata di alloro, a motivo dei suoi poeti Dante e Petrarca, a Bologna con la toga dottorale ed il libro a ricordo della sua università medioevale voluta dai pontefici.
Tutto il resto del monumento rimanda, invece, esplicitamente all’Unità del Paese sorta proprio con il Risorgimento. Spesso, però, la simbologia è intellettualistica e chiaramente creata a freddo nel clima post-risorgimentale (la costruzione del Vittoriano iniziò nel 1885, mentre gli ultimi interventi risalgono al 1935). Non è particolarmente originale affermare che il monumento nell’insieme non convince.
In alto, in cima al monumento, sono le due quadrighe dell'Unità e della Libertà. Due iscrizioni in latino ne indicano esplicitamente il tema: a destra, Patriae Unitati, a sinistra, Civium libertati.
La quadriga dell’Unità reca anche uno scudo con la scritta Hic manebimus optime che fa riferimento a Tito Livio (Ab Urbe condita libri, V, 55) – è l’espressione di un centurione che fa comprendere a tutti che non si deve abbandonare l’urbe – ma anche a Gabriele D’Annunzio che la utilizzò come motto per l’impresa di Fiume (1919-1920, mentre le quadrighe furono poste alla sommità nel 1927).
Il grande porticato è costituito da 16 colonne che recano in alto la raffigurazione delle 16 regioni italiane, così come si configuravano al tempo(mancano la Val d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, il Tentino Alto Adige, il Molise).
Il bassorilievo frontale posto a decorazione della scalea che sale al monumento di Vittorio Emanuele II ha al centro la dea Roma con alla destra la raffigurazione dell’Amor Patrio ed alla sinistra quella dell'Agricoltura e dell'Industria (1925).
Ai piedi della statua della dea Roma, è posta, dal 4 novembre 1921, la Sepoltura del Milite Ignoto, che custodisce la salma di un giovane militare italiano della I guerra mondiale che venne scelta da una vedova di guerra a sua volta sorteggiata a rappresentare i tanti sacrifici umani sopportati dall’intera nazione nel conflitto. In questa maniera il monumento collega idealmente il Risorgimento con la storia d’Italia fino al primo dopoguerra.
Sei gruppi scultorei, i primi due in bronzo ed i quattro restrostanti in marmo, rappresentano sei valori dell’Unità d’Italia che si vollero simbolicamente evidenziare e, precisamente, da sinistra a destra, La forza (1911), La concordia (1911), Il pensiero (in bronzo, 1912), l’Azione (in bronzo, 1912), Il sacrificio (1911) e Il Diritto (1911).
Nella Forza un nudo personaggio in posa guerresca si erge con a fianco due figure che rappresentano la forza nel lavoro, nella Concordia un personaggio femminile conduce all’abbraccio un vecchio togato ed un giovane, nel Pensiero la dea Minerva alata aiuta il popolo italiano a sollevarsi, nell’Azione un gruppo di combattenti issa il tricolore che reca scritto "Italia" e "Vittorio", mentre il leone di Venezia si libera dalla tirannide, nel Sacrificio un eroe morente è assistito dalle raffigurazioni della libertà e della famiglia, nel Diritto una figura ripone nel fodero la spada, gettando le basi dello Stato.
Più in basso, a livello della strada, due raffigurazioni rappresentano i due mari d’Italia, l'Adriatico a sinistra del monumento, con il simbolo del leone di San Marco, ed, a destra, il Tirreno, con il Tevere che vi sfocia, con la lupa di Roma e la sirena Partenope.
A completare l’iconografia le due porte che danno accesso all’interno del monumento recano in alto le raffigurazioni della Politica e della Filosofia, da un lato, e della Rivoluzione e della Guerra, dall’altro, mentre ancora più in alto sopra le porte dei due propilei stanno le raffigurazioni dell’Architettura e della Musica da un lato e della Pittura e della Scultura dall’altro. Le lunette del propileo dedicato all’Unità recano all’interno i mosaici del Lavoro, della Forza, della Fede e della Sapienza, mentre quelli all’interno del propileo dedicato alla Libertà rappresentano la Legge, il Valore, la Pace e l’Unione.
Nel soffitto del portico, invece, dietro le 16 colonne, il mosaico con le Nuove Scienze.
Il Vittoriano fu eretto demolendo il convento di Santa Maria in Ara Coeli, che era stato confiscato dopo la presa di Roma, e nascondendone la chiesa che era precedentemente l’edificio che si stagliava all’orizzonte della via del Corso. Contestualmente al convento vennero demolite anche le altre costruzioni che sorgevano sul fianco del colle del Campidoglio.
2/ Una breve sintesi e due tesi di fondo che propongo
2.1/ Una breve sintesi
2.2/ “Provvidenziale” l’origine del potere temporale della Chiesa di Roma, come la sua fine/riduzione al minimo
- Lonardo, Il potere necessario sull’origine del potere temporale della Chiesa (non una necessità “teologica”, ma una necessità storica (la politica alta forma di carità)
- dell’Allocuzione di Sua Santità Pio XI ai Parroci e ai Predicatori del periodo Quaresimale tenuta l’11 febbraio 1929 in occasione della Firma del Trattato e del Concordato nel Palazzo Lateranense
Che sarà domani? Questa domanda Ci lascia anche più tranquilli, perché possiamo semplicemente rispondere: Non sappiamo. L’avvenire è nelle mani di Dio, quindi in buone mani. Qualunque cosa ci prepari l’avvenire, sia essa disposizione o permissione della Divina Provvidenza, fin d’ora diciamo e proclamiamo che qualunque sia per essere il cenno della Divina Provvidenza, dispositivo o permissivo, lo seguiremo fidenti sempre ed in qualunque direzione chiami.
Le critiche saranno anche più numerose; ma facilmente si divideranno in due grandi categorie. Gli uni diranno che abbiamo chiesto troppo, gli altri troppo poco. E questo tanto più avverrà, se si distingueranno i campi in cui Noi avremmo chiesto troppo o troppo poco.
Forse alcuni troveranno troppo poco di territorio, di temporale. Possiamo dire, senza entrare in particolari e precisioni intempestive, che è veramente poco, pochissimo, il meno possibile, quello che abbiamo chiesto in questo campo: e deliberatamente, dopo aver molto riflettuto, meditato e pregato. E ciò per alcune ragioni che Ci sembrano e buone e gravi. Innanzi tutto abbiamo voluto mostrare di essere pur sempre il Padre che tratta coi figli, che è dire la disposizione Nostra a non rendere le cose più complicate, e più difficili, ma più semplici e più facili. Inoltre volevamo calmare e far cadere tutti gli allarmi, volevamo rendere addirittura ingiuste, assolutamente irragionevoli, tutte le recriminazioni fatte o da farsi in nome di una, stavamo per dire, superstizione di integrità territoriale del paese. Ci parve così di seguire un pensiero provvido e benefico a tutti per il presente e per il futuro, provvedendo ad una maggiore tranquillità di cose, prima ed indispensabile condizione per una stabile pace e per ogni prosperità.
In terzo luogo volevamo mostrare in un modo perentorio che nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perché una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio, senza del quale questa non potrebbe sussistere, perché non avrebbe dove poggiare. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in San Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l’anima. Così per altri Santi: il corpo ridotto al puro necessario per servire all’anima e per continuare la vita umana, e colla vita l’azione benefica. Sarà chiaro, speriamo, a tutti, che il Sommo Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l’esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in beneficio di uomini; non esitiamo a dire che Ci compiacciamo che le cose stiano così; Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall’immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire.
Vero è che Ci sentiamo pure in diritto di dire che quel territorio che Ci siamo riservati e che Ci fu riconosciuto è bensì materialmente piccolo, ma insieme è grande, il più grande del mondo, da qualunque altro punto di vista lo si contempli.
Quando un territorio può vantare il colonnato del Bernini, la cupola di Michelangelo, i tesori di scienza e di arte contenuti negli archivi e nelle biblioteche, nei musei e nelle gallerie del Vaticano; quando un territorio copre e custodisce la tomba del Principe degli Apostoli, si ha pure il diritto di affermare che non c’è al mondo territorio più grande e più prezioso. Così si può abbastanza vittoriosamente, tranquillamente rispondere a chi obietta d’aver Noi chiesto troppo poco: mentre poi non si riflette forse abbastanza quel che significhi di incomodo e di pericoloso (diciamo al giorno d’oggi) aggiungere al governo universale della Chiesa, l’amministrazione civile di una popolazione per quanto minuscola.
La piccolezza del territorio Ci premunisce contro ogni incomodo e pericolo di questo genere. Sono sessant’anni ormai che il Vaticano si governa senza particolari complicazioni.
Altri invece diranno, anzi hanno già detto od accennato, che abbiamo chiesto troppo in altro campo: si capisce, e vogliamo dire nel campo finanziario. Forse si direbbe meglio nel campo economico, perché non si tratta qui di grandi finanze statali, ma piuttosto di modesta economia domestica.
A costoro vorremmo rispondere con un primo riflesso: se si computasse, capitalizzando, tutto quello di cui fu spogliata la Chiesa in Italia, arrivando fino al Patrimonio di San Pietro, che massa immane, opprimente, che somma strabocchevole si avrebbe? Potrebbe il Sommo Pontefice lasciar credere al mondo cattolico di ignorare tutto questo? Non ha egli il dovere preciso di provvedere, per il presente e per l’avvenire, a tutti quei bisogni che da tutto il mondo a lui si volgono e che, per quanto spirituali, non si possono altrimenti soddisfare che col concorso di mezzi anche materiali, bisogni di uomini e di opere umane come sono?
da G.B. Montini, Roma e il Concilio, in Studi Romani 10 (1962), pp. 503-504
Pare innanzitutto notevole il fatto che questo imminente Concilio si celebra a Roma, la quale lo accoglie con molto onore e con molta circospezione, e si trova in condizioni ben diverse dalla Roma che accolse il primo Concilio Vaticano; Roma papale quella, Roma italiana questa. Il confronto fra l'Urbe del 1870 e la città del 1962 sorge spontaneo alla mente per rilevare non tanto l'aspetto esteriore, enormemente e splendidamente migliorato della Roma odierna e assai differente dal volto, sempre regale ma invecchiato e sofferente della Roma ottocentesca di allora, quanto per ricordare il comportamento ideale e politico, stanco e inquieto a quel tempo, febbrile e vario, ma ben delineato al tempo nostro. Non si può dimenticare che la presenza del Concilio Ecumenico a Roma nel '70 non valse a placare il fermento politico che dentro e fuori l'agitava, né a contenere la pressione degli avvenimenti, che portarono, proprio in quei giorni, alla caduta del potere temporale del Papa, ed insieme, con la Bolla Postquam Dei Munere del 20 ottobre 1870, alla sospensione del Concilio Vaticano primo, praticamente - lo abbiamo appreso adesso - alla sua fine. Parve un crollo; e per il dominio territoriale pontificio lo fu; e parve allora, e per tanti anni successivi, a molti ecclesiastici e a molti cattolici non potere la Chiesa romana rinunciarvi, e accomunando la rivendicazione storica della legittimità storica della sua origine con l'indispensabilità della sua funzione, si pensò doversi quel potere temporale recuperare, ricostituire. E sappiamo che ad avvalorare questa opinione, per cui fu così travagliata e priva delle sue più cospicue forze, quelle cattoliche, la vita politica italiana, fu l'antagonismo sorto tra lo Stato e la Chiesa. […] Ma la Provvidenza, ora lo vediamo bene, aveva diversamente disposto le cose, quasi drammaticamente giocando negli avvenimenti. Il Concilio Vaticano I aveva da pochi giorni proclamata somma e infallibile l’autorità spirituale di quel Papa (il voto sull’infallibilità avvenne nella quarta sessione il 18 luglio 1870 ndr.) che praticamente perdeva in quel fatale momento la sua autorità temporale. Il Papa usciva glorioso dal Vaticano I per la definizione dogmatica delle sue supreme potestà nella Chiesa, e usciva umiliato per la perdita delle potestà temporali. Ma fu allora che il papato riprese con inusitato vigore le sue funzione di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così da salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione morale sul mondo.
dal discorso di Paolo VI in visita al Presidente della Repubblica Italiana, 11 gennaio 1964
Com' Ella vede, Signor Presidente, i Nostri sentimenti si svolgono in una linea semplicissima, come è proprio di sentimenti che partono dal cuore, e subito si fanno augurio, ed in Noi si accendono in preghiera. E ciò che diciamo per la Sua persona e per il Suo ufficio vogliamo dire per il Popolo Italiano, non senza avvertire il bisogno di ricordare, ancora una volta, la novità - rispetto alla storia pochi decenni trascorsi non bastano per considerarla altrimenti - la novità del titolo con cui Noi ad esso Ci rivolgiamo. Il titolo non è più quello d'una sovranità temporale, che qualificava sudditi gli Italiani degli Stati Pontifici e forestieri quelli delle altre regioni; ma solo quello della Nostra potestà spirituale, che guardava ieri e tanto più guarda oggi all'Italia come ad un popolo costituente nella sua grande maggioranza, e, sotto certi aspetti, vorremmo dire nella sua totalità, una comunità cattolica.
Ci chiediamo perciò se ancora, da questa sede, tale titolo puramente spirituale Ci autorizza a interloquire con l'Italia, la Nostra diletta Italia: e pare a Noi che non solo possiamo, ma dobbiamo dirle, anche in una circostanza come questa, le cento cose che abbiamo per essa nel cuore: che vogliamo bene, un bene tutto spirituale, tutto pastorale, oltre che naturale, a questo magnifico e travagliato Paese; vogliamo dire che non dimentichiamo i secoli durante i quali il Papato ha vissuto la sua storia, difeso i suoi confini, custodito il suo patrimonio culturale e spirituale, educato a civiltà, a gentilezza, a virtù morale e sociale le sue generazioni, associato alla propria missione universale la sua coscienza romana ed i suoi figli migliori; vogliamo assicurarlo che desideriamo per esso ogni moderna prosperità nell'ordine civile, nella giustizia sociale, e, come Vostra Eccellenza ha ben detto, nella pace internazionale; vogliamo ricordargli che Noi sempre impegniamo quanti del nome cattolico si onorano a dare al Paese stesso esempio di integri e forti costumi e concorso di leale collaborazione per ogni libero e onesto incremento.
2.3/ Avevano ragione sia il Risorgimento sia Pio IX (ed avevano entrambi torto, ma i tempi non erano maturi per una soluzione che eliminasse quel torto)
C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011 (un testo che qualsiasi docente dovrebbe leggere!)
2.4/ Contro le due opposte scuole storiografiche, quella che accusa il Risorgimento di non aver rotto con la Chiesa e quella che lo accusa precisamente di aver rotto con la Chiesa
da Risorgimento, Unità d’Italia, Chiesa cattolica, di Carlo Cardia (da www.gliscritti.it )
Nel bel libro-intervista di Emilio Gentile il nodo dei rapporti con la Chiesa è interpretato come una delle ragioni per la quale difettiamo del senso dello Stato, e la prova sarebbe nel fatto che manteniamo tante festività religiose ma non abbiamo una vera festa nazionale, come per altri è il 4 o 14 luglio.
È riemerso anche un filo di intransigentismo storiografico nelle analisi (per altri aspetti condivisibili) di Ernesto Galli della Loggia, e in più recenti scritti di Massimo Viglione, per i quali l’Italia dell’Ottocento nel farsi Stato avrebbe dichiarato guerra alla tradizione cattolica, lacerato il Paese nella sua identità. Desidero anticipare, con riferimento al mio libro “Risorgimento e religione”, che insieme ai grandi autori classici che hanno scandagliato le relazioni tra unità d’Italia e cattolicesimo, Francesco Ruffini, Arturo Carlo Jemolo, Giacomo Martina, hanno fatto da guida alla mia ricerca il pensiero e le analisi di Giovanni Spadolini, spirito laico per eccellenza ma sostenitore strenuo della libertà religiosa, alieno da ogni estremismo o partigianeria.
Io credo che il Risorgimento non meriti i giudizi appena riportati, soprattutto perché l’intreccio tra Risorgimento e religione è stato continuo, ricco, fecondo anche nei momenti di conflitto, e perché questo conflitto è stato sempre ricomposto in una sintesi più alta di cui siamo tutti eredi anche se non sempre ce ne accorgiamo. Cominciamo dal primo punto.
Noi abbiamo una pluralità di feste e celebrazioni (laiche e religiose) proprio perché non abbiamo voluto spezzare la continuità della nostra storia; non abbiamo bisogno di una data esclusiva per la nostra identità nazionale perché questa è assai più antica rispetto a quella di altri popoli, non ne abbiamo mai espunto una parte, provandone vergogna.
Caso mai, il problema è opposto, siamo rinascimentali anche nelle feste, non riusciamo a liberarci neanche di quelle patronali. Con l’unità d’Italia la nostra storia non si spezza, è portata a compimento da un Risorgimento che esalta il nostro passato e le nostre tradizioni facendone la leva per affermare il diritto all’indipendenza, che nessuno all’epoca può negare.
Solo così si spiega come il Risorgimento abbia potuto affrontare e risolvere, in un arco di tempo assai ridotto, tra il 1848 e il 1861, con l’appendice del 1870, compiti assai più ardui di quelli propri di altri Paesi. E l’ha fatto senza guerre di religione o persecuzioni di alcun genere, senza fratture definitive tra le parti sociali, senza gli estremismi che hanno segnato la storia di altri Stati. Nessuna recriminazione può cancellare questo tratto di distinzione e di nobiltà della doppia rivoluzione risorgimentale, per libere istituzioni e per l’indipendenza.
Le tesi che accentuano le tensioni tra Italia e Chiesa cattolica evitano, infatti, di confrontare la nostra storia con quella di altri Paesi che sono diventate Stati unitari con lacerazioni, guerre, conflitti a noi sconosciuti. Lo mette bene in risalto Alberto Mario Banti quando rileva le tragedie e i massacri che accompagnano la formazione dei grandi Stati moderni, come Inghilterra, Francia, Stati Uniti d’America, di cui dovremmo essere invidiosi, e mette in rilievo che la loro lunga e feroce gestazione dovrebbe confermarci nel carattere positivo, più dolce della nostra storia e del Risorgimento.
La nostra storia non è lacerata anche perché sin dall’inizio il Risorgimento è strettamente legato, a livello popolare e di intellettualità, alla Chiesa e alla fede religiosa dei suoi protagonisti. Già nel primo Ottocento sono poeti e letterati, prima che politici e rivoluzionari, a reclamare il diritto storico dell’Italia all’unità e all’indipendenza, e lo fanno con opere e immagini che rimandano di continuo alla fede, al cristianesimo, alla religione che ha alimentato la nostra storia secolare.
Lo fa Alessandro Manzoni con i suoi inni e le sue tragedie, e soprattutto con quel romanzo storico dei Promessi sposi che mette in scena la lotta epica e senza fine della giustizia contro l’ingiustizia, dell’innocenza contro la sopraffazione, e che in chiara allegoria parla dell’Italia moderna che può redimersi da ogni dominio straniero e farsi libera e indipendente. Romanzo più cattolico e patriottico dei Promessi sposi non si può immaginare, su di esso si sono formate generazioni di italiani sino ai giorni nostri per sognare e realizzare una storia unitaria tenendo fermo il legame con un cammino di civilizzazione più lungo e profondo di quello di altri Paesi.
E lo fa, prima di lui, Giacomo Leopardi il quale, pur non professando una fede positiva tuttavia propone ed elabora le domande che da sempre gli uomini si pongono, e lo accostano al cielo con uno spirito universale che solo da Roma può sprigionarsi. Le più grandi poesie di Leopardi superano la terra, fanno volare la mente in cielo e sulla luna, vogliono conoscere il senso e il segreto della vita, possedere l’universo nella notte del deserto e perdersi nell’infinito quando lo intravedono, anche se poi si ritraggono, non afferrano la mano tesa della fiducia che è lì a portato d’uomo. Leopardi cerca ovunque la trascendenza, ogni volta si rattrista perché non riesce a farla sua e ad amarla. La sua poetica è così alta e struggente che rapisce, scende nell’intimo, suggerisce quasi a chi legge le risposte che la sua ragione rifiuta, e per paradosso molti lettori afferrano quella mano tesa che lui respinge.
In Leopardi non c’è sopraffazione, aggressione, gusto della violenza, ma gentilezza e profondità, c’è quel pensiero infinito che gli fa rinnovare la grandezza italiana del passato. Leopardi è il cantore di ogni tempo e luogo, seppure non varca la soglia della fede, però la suggerisce, la insinua, la fa desiderare a chiunque lo legga. Se Manzoni fa della fede la via verso la salvezza dell’Italia, Leopardi è, per dirla con Benedetto XVI, tra coloro che cercano Dio in continuazione e così facendo in qualche modo l’hanno già raggiunto.
La fede religiosa che nutre gli animi e li spinge a volere un’Italia libera e unita, è presente e attiva quando prende l’avvio l’azione politica e l’impegno civile per conseguire il traguardo unitario. Perfino negli anni della solitudine, quando le speranze sono affidate all’eroismo individuale, ai martiri solitari (democratici, mazziniani, cattolici, liberali) che preparano il Risorgimento, la fede cristiana permea, avvolge e sostiene chi sale sul patibolo, subisce il carcere o l’esilio, al di là delle convinzioni politiche.
Ciro Menotti, la notte prima di salire il patibolo, dopo aver ricevuto i sacramenti, scrive alla moglie Cecchina dandole appuntamento nei luoghi dell’eternità e l’assicura che Iddio gli dà la forza per incontrare la morte come la mercede del giusto.
Silvio Pellico, con la sua opera parla poco di politica ma narra la forza della fede che l’ha sostenuto nel patire le prigioni austriache, commuove l’Europa più di tanti manifesti e proclami. Con i martiri di Belfiore sono giustiziati sacerdoti cui vengono scorticate le dita che avevano sorretto l’ostia, né vale il soccorso dei vescovi a salvarli perché la repressione è cieca.
Negli stessi anni, infine, una generazione di intellettuali cattolici, Gioberti e Rosmini, Niccolò Tommaseo ed Alessandro Manzoni, elaborano il sogno unitario, guelfo o non guelfo, radicano gli ideali risorgimentali nel cuore e nella mente dei cattolici. Queste pagine di storia che riempiono la prima metà dell’Ottocento non possono essere cancellate, o sottovalutate, alla luce delle successive difficoltà e tensioni, proprie di un nuovo sistema politico democratico che si affermando in Piemonte e poi in Italia.
3/ In Italia esiste prima la nazione e poi lo Stato: non è lo Stato a fare la nazione italiana come in altri paesi (e nemmeno i filosofi dell’ottocento, pro o contro il papa, da Gioberti, Manzoni, Rosmini, ecc. ecc.)
da L’inno di Mameli. Frammenti dal commento di Roberto Benigni, Festival di Sanremo, 17/2/2011
L’Italia è l’unico paese al mondo dove è nata prima la cultura e poi la nazione. L’ha tenuto insieme la lingua e la cultura, immensa.
Un paese che non proclami forte i propri valori è pronto per l’oppressione e la servitù.
Risorgimento poi è una parola... Risorgere viene dal vangelo, è una cosa mistica, religiosa... è proprio una resurrezione.
Nessun altro luogo del mondo ha avuto un’avventura impressionante, scandalosamente bella come la città di Roma.
In dialetto non si può scrivere la Divina Commedia. Non si può.
La bandiera venne inventata, trovata, scelta da Mazzini da un verso di Dante Alighieri – come al solito – che nel canto XXX del Purgatorio, l’apparizione di Beatrice... Quindi la bandiera viene da Dante Alighieri.
Uniamoci, amiamoci, l’unione e l’amore... L’unione e l’amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Queste.... sono le idee di Gioberti, cattolicesimo e liberalismo insieme.
Abbiamo inventato noi la libertà, nel 1100, 1200... i comuni liberi.
Loro hanno imparato a morire per la patria, perché noi potessimo vivere per la patria.
Lo canta... non perché protegge la terra dei suoi padri, ma perché tutela la vita dei suoi figli.
da C. Cardia, Prefazione
[Spesso si] sottovaluta l'idealità e l'eroismo profusi ovunque nella Penisola dai giovani, dai volontari, da persone di ogni classe sociale, per raggiungere l'obiettivo unitario.
Di un altro fatto si parla poco, o se ne parla in modo distorto. Il Risorgimento non forma una nazione, con relativa cultura, religione, memoria storica, ma unifica in Stato una nazione che esiste da secoli, con una storia grande di respiro universale, che conosce e celebra imperatori e condottieri, filosofi e scienziati, papi, teologi e santi, che hanno parlato al mondo, agli uomini di tutta la terra, che il mondo ci riconosce e ammira più di quanto riusciamo a fare noi stessi.
Questo onore, ed onere, della nazione italiana dovrebbe essere vanto del Risorgimento, ma c'è chi lo tace e lo nasconde, perché crede che se fosse conclamato farebbe risaltare in controluce limiti e modestia dell'epopea risorgimentale. In realtà è il contrario. Disconoscendo l'elemento nazionale che per ogni italiano preesiste allo Stato unitario si commette un peccato d'orgoglio che priva il Risorgimento della sua grandezza: il processo unitario è stato breve e nobile perché la nazione italiana ha una lunga storia, nessuno può negare la sua identità conosciuta in tutto il mondo, essendo la più universale.
D'altra parte qualunque studente, anche fra i tanti che ignorano quando l'Italia s'è unita, interrogato di quale sia la nazionalità di Giulio Cesare o San Benedetto, Giotto o Raffaello, ancora di Dante, Petrarca, Savonarola, Leopardi, Beccaria, e mille altri, non esiterebbe a dire che sono italiani ovunque essi siano nati. Questa peculiarità è ancora oggi sottostimata, impedisce di dare la giusta collocazione all'unificazione politica dell'Ottocento, evento eccezionale ma che non oscura il patrimonio di eredità di cui siamo custodi da secoli.
da Dopo 150 anni in Italia si parla italiano. I meriti della scuola, dei giornali e anche della Chiesa, di Luca Serianni
È notissima la valutazione di Tullio De Mauro, il quale nel 1963 calcolò che appena il 2,5 per cento dei parlanti potevano considerarsi italofoni. La percentuale è stata discussa, ma è vero che i termini del problema non cambierebbero anche se quella quota dovesse essere moltiplicata di due o tre volte. Se nel 1861 erano pochi i cittadini in grado di parlare l'italiano, non è però sostenibile un eventuale corollario, secondo il quale sarebbe esistito solo l'italiano scritto della tradizione letteraria, chiuso in una specie di teca museale.
Il linguista ticinese Sandro Bianconi ha dimostrato nel 1991, esplorando i ricchissimi carteggi dei cardinali Borromeo (circa 60.000 lettere), che l'italiano già nel secondo Cinquecento era diventato anche nei centri minori "la lingua della comunicazione scritta ai diversi livelli della società"; Francesco Bruni ha accertato la circolazione di un italiano ampiamente usato nel Levante dal XVI al XIX secolo in funzione di lingua veicolare diplomatica. E non va sottovalutata, per la circolazione di un modello scritto o comunque italianizzato presso le masse, l'azione della Chiesa e l'abituale ricorso all'italiano, non al dialetto, nella predicazione: un canale a cui era esposta regolarmente la quasi totalità della popolazione dialettofona.
da Don Bosco l'italiano. La cultura come coscienza e identità di un popolo, di Francesco Motto
Che la nostra identità abbia radici nel passato e che, prima ancora del carattere politico assunto con il Regno d'Italia nel 1861, da secoli abbia un suo carattere nazionale linguistico, religioso, letterario, artistico è indubitabile.
Può essere allora interessante e anche inedito vedere l'apporto di don Bosco a tale italianità già nel quindicennio precedente l'Italia unita. Del resto nel 1846 indicava alla massima autorità di Torino che egli intendeva insegnare ai suoi ragazzi quattro "valori": l'amore al lavoro, la frequenza dei santi sacramenti, il rispetto a ogni superiorità e la fuga dai cattivi compagni. Li avrebbe successivamente sintetizzati nella celebre espressione "onesto cittadino e buon cristiano".
Nel 1845 pubblica dunque un volume di 400 paginette: la Storia ecclesiastica ad uso delle scuole, utile ad ogni ceto di persone. In evidenza sono subito due dimensioni: quella religiosa e quella di taglio giovanile e popolare. Gli ecclesiastici, gli studiosi, le persone colte, gli allievi delle (poche) scuole superiori avevano già a loro disposizione grossi volumi; non così sempre i ragazzi delle scuole inferiori, dei collegi, dei piccoli seminari; non così i giovanotti semianalfabeti che frequentavano le scuole festive e serali; non così la gran massa della popolazione semianalfabeta dell'epoca.
Quella di don Bosco non ha nulla a che vedere con le storie dotte e con quelle pure similari di Antoine-Henri de Bérault-Bercastel, di Réné F. Rohrbacher, di Johann J. I. von Döllinger. L'obiettivo che si propone è educativo, apologetico, catechistico: formare religiosamente i lettori, soprattutto i giovani studenti, con una bella storia, dando spazio ai "fatti più luminosi che direttamente alla Chiesa riguardano", soprattutto ai papi e ai santi, tralasciando o appena accennando i "fatti del tutto profani e civili aridi o meno interessanti, oppure posti in questione". L'Educatore. Giornale di educazione e di istruzione primaria lo recensiva positivamente, sottolineandone il principio educativo sotteso ("illuminare la mente per rendere buono il cuore") e apprezzandone il periodare "schietto e facile", "la lingua abbastanza pura"e "la sparsa unzione, che dolcemente ti commuove e alletta al bene", Il volume ebbe 25 edizioni-ristampe fino al 1913.
Non passano due anni che don Bosco dà alle stampe un'opera analoga, ossia La storia sacra per uso delle scuole, utile ad ogni stato di persone, arricchita di analoghe incisioni. Come sempre, onde "giovare alla gioventù", l'autore si prone la "facilità della dicitura e popolarità dello stile", anche se con ciò non può garantire "un lavoro elegante".
I modelli ancora una volta sono libriccini esistenti sul mercato. Il volume è ben accolto dalla critica. Sul citato periodico di pedagogia torinese un maestro scrive che apprezza tanto l'opera al punto da adottarla e da consigliarla ai suoi colleghi: "I miei scolari vanno a ruba per averla nelle mani, e la leggono con ansietà e non rifiniscono di presentarla agli altri e di parlarne, chiaro segno che la capiscono". Tale comprensione è dovuta, a giudizio del maestro, alla "forma di dialogo" e alla dicitura "popolare, ma pura ed italiana". Potrebbe essere stato questo apprezzamento uno dei motivi per cui don Bosco, sul finire del 1849, avanza richiesta alle autorità scolastiche del regno di adottare come testo scolastico un suo Corso di Storia Sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento che intende "pubblicare, adorno anche di stampe, in modo acconcio per l'ammaestramento delle scuole elementari".
La domanda in un primo momento parve poter venire accolta favorevolmente, stante "l'assoluta mancanza di un libro migliore". Nel corso della seduta del consiglio superiore della Pubblica istruzione del 16 dicembre 1849 si esprimono sì delle riserve "dal lato dello stile e della esposizione", ma esse vengono compensate dalle "opportunissime considerazioni morali" e dalla "necessaria chiarezza" che fa "emergere assai bene dai fatti i dogmi fondamentali della religione".
L'intervento critico e autorevole del relatore don Giuseppe Ghiringhello fa però mutare opinione allo stesso consiglio per i "molti errori grammaticali e ortografici", che rendono "meno utile quel lavoro per altro verso assai commendevole". Evidentemente le esigenze del teologo Ghiringhello docente di Sacra Scrittura nella facoltà teologica della città non erano quelle dei maestri di scuole elementari (e di don Bosco), quotidianamente alle prese con fanciulli appena alfabetizzati, che normalmente si esprimevano in dialetto. La "fortuna" dell'opera è comunque notevole se alla morte di don Bosco (1888) le edizioni-ristampe sono arrivate a 19, e tante altre sarebbero state immesse sul mercato editoriale e scolastico fino al 1964.
Alla trilogia mancava ancora una storia, quella d'Italia che peraltro era richiesta dall'aria che si respirava. Ed ecco don Bosco darla alle stampe nel 1855: La storia d'Italia raccontata alla gioventù da' suoi primi abitatori sino ai nostri giorni, corredata da una carta geografica d'Italia. Questa volta la narrazione, che attinge come sempre ai compendi e manualetti dell'epoca, è più limpida del passato, dal momento che l'autore è ormai allenato da un decennio a scrivere. Sono però sempre pagine di uno scrittore che si adegua all'intelligenza dei suoi lettori, di un sacerdote che vuole presentare fatti fecondi di ammaestramenti spirituali, di un educatore di giovani "poveri ed abbandonati" che non fanno storia, ma la subiscono dalla prepotenza dei grandi. Non se ne rese conto Benedetto Croce 60 anni dopo quando - nonostante il rispettabile successo di ben 31 edizioni fino al 1907 - per la presenza di certe pagine lo definisce un "povero libro reazionario e clericale", mentre il coevo ministro cavouriano Giovanni Lanza lo encomia. Niccolò Tommaseo ne tesse gli elogi, pur notando che "non tutti i giudizi di lui sopra i fatti a me paiono indubitabili né i fatti tutti esattamente narrati", ma senza tacere che "non pochi de' moderni (...) nella storia (...) propongono a se un assunto da dover dimostrare e quello perseguono dal principio alla fine; e a quello piegano e torcono i fatti e gli affetti".
4/ La natura “dolce” del Risorgimento: il miglior processo europeo di costruzione di una nazione
da A.M. BANTI, Nel nome dell'Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze nei documenti e nelle immagini, Bari 2011, pp. VII-VIII.
Pensate alla Gran Bretagna: lì ci vuole un secolo di massacri - il XVII - per costituirla; e i massacri continuano ancora per almeno tre secoli (con cicli e cronologie diversi) in aree territoriali marginali come la Scozia o l'Irlanda. Pensate alla Francia: dalla Rivoluzione alla Comune è una guerra civile incessante tra partiti di diverso orientamento ideologico a Parigi, in Vandea, e altrove in provincia fino alla repressione della Comune ( 1871) che in pochi giorni miete decine di migliaia di vittime. Pensate agli Stati Uniti, che nascono con una prima secessione violenta e che, proprio negli anni del brigantaggio italico, sprofondano nelle violenze di una seconda secessione, la guerra civile che costa agli Stati Uniti tanti caduti quanti ne sono stati causati da tutte le guerre combattute dagli americani nel XX secolo.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 15-16
L'esempio inglese è assai significativo, perché un conflitto religioso e di nazionalità lacerante segna la restaurazione della grande monarchia quando nel 1534 Enrico VIII si separa da Roma e organizza una Chiesa anglicana tutta fatta in casa, e per tre secoli le isole britanniche non hanno pace. Cattolici, anglicani, presbiteriani scozzesi squassano e dividono il Paese, le loro diatribe sono filtrate e risolte dagli equilibri dinastici, intramezzate dalla guerra civile dei puritani di Cromwell che nel secolo successivo compie l'indicibile mettendo a morte il Re. Nel Cinquecento Enrico VIII manda a morte alcune sue mogli facendole imprigionare e giustiziare nella Torre di Londra, ma sua figlia Maria Tudor «la sanguinaria» cerca di restaurare la tradizione e si macchia di stragi che non saranno mai perdonate ai cattolici. Elisabetta I da parte sua fa giustiziare Maria Stuarda per prevenire un' altra restaurazione papista e colpire l'indipendentismo scozzese. L'equilibrio civile viene infranto nel secolo successivo da Cromwell che fa giustiziare Carlo I, proclama la repubblica (Commonwealth), unisce a forza le tre nazioni (Inghilterra, Scozia, Irlanda), umiliando democrazia, diritti di libertà, identità nazionali. Cromwell subisce poi la damnatio memoriae perché Carlo II fa riesumare la sua salma dall'abbazia di Westminster e la sottopone all'esecuzione postuma (hanged, drawed and quartered). Il corpo viene gettato in una fossa comune, tranne la testa, infilata su un palo ed esposta davanti all'Abbazia di Westminster fino al 1685. Solo nel 1960 il trofeo, passato nel frattempo di mano in mano, viene sepolto nel cimitero del Sidney Sussex College. La topografia delle inumazioni riflette in qualche modo le lotte dinastiche e civili dell'epoca. Le mogli fatte giustiziare da Enrico VIII, Anna Bolena e Catherine Howard, sono sepolte nella Chiesa della Torre di Londra St. Peter in Chains (San Pietro in vincoli). Nell'Abbazia di Westminster, invece, sono insieme vittime e carnefici, amici e nemici, Maria I d'Inghilterra (la sanguinaria) ed Elisabetta I, e Maria Stuarda messa a morte da Elisabetta, quasi che il passaggio all' aldilà implichi il perdono per le colpe terrene. L'unificazione dell'Irlanda porta ad una delle più dure e lunghe repressioni della storia europea, mentre la guerra civile inglese si conclude nel 1688 con l'avvento al trono di Guglielmo d'Orange e la sua accettazione del Bill of Rights che dà basi costituzionali ai poteri del Parlamento e allo Stato inglese moderno che nel secolo XIX inizierà a riconoscere diritti civili e libertà di religione alle minoranze. È vero che è una storia lontana da noi, e noi la studiamo poco, ma non è questo un buon motivo per invidiarla o pensare che lo Stato inglese si sia affermato in poco tempo, senza divisioni intestine, non abbia fatto tante vittime.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 17-18
La storia dei Paesi compattamente cattolici, poi, smentisce nettamente che soltanto in Italia lo Stato unitario si sia formato in contrapposizione alla propria religione. Al contrario, Francia e Spagna realizzano guerre e repressioni religiose mai conosciute in Italia, con un radicamento di odi e ostilità che non trovano spazio neanche per un momento nel nostro risorgimento, anche perché il papato svolge in Italia un ruolo di ammortizzatore nei passaggi di più acuto conflitto politico. In Francia lo Stato nasce e si fa grande su base monarchica e cattolica, ma nel 1789 la rivoluzione abbatte la monarchia e dichiara guerra alla religione. La formazione dello Stato unitario attraversa diverse fasi, a cominciare dal XIII-XIV secolo quando inizia la lotta di emancipazione dall'Inghilterra, e con Filippo il Bello che sottrae per la prima volta la Francia dalla egemonia teocratica, sconfiggendo in Bonifacio VIII l'ultimo papa teocratico della storia. Al termine della guerra dei cento anni (1337-1453) la Francia consegue l'unità nazionale, e il suo Stato si afferma attraverso periodiche stragi di eretici e dissidenti religiosi, ed è frutto di una monarchia «talmente nazionale che, all'indomani della sua caduta, la nazione si regge anche senza di essa e nonostante la rivoluzione dell’89». Ma la rivoluzione del 1789-1794 scatena un conflitto generalizzato contro la religione e l'identità cattolica con repressioni e rappresaglie che inaugurano in Europa quell'antitesi amico-nemico che è a base di ogni forma di totalitarismo. Si tratta di una guerra continua al cattolicesimo che esplode, in termini di repressione sanguinaria nel periodo del terrore, di emarginazione sociale nel secolo XX con la Loi de séparation del 1905. Vengono i brividi a pensare cosa sarebbe potuto accadere in Francia, se si fosse dovuto porre fine al potere temporale dei papi, rispetto a quanto avviene in Italia nell'Ottocento.
da C. Cardia, Prefazione
Si può tornare a riflettere, con obiettività, sul carattere moderato con il quale il Risorgimento ha gestito il conflitto con la Chiesa. Lo si può fare tenendo presente ciò che è avvenuto, in analoghe circostanze, in altri Paesi dove lo scontro è diventato guerra di religione, aspra, senza confini e spazi di mediazione, ha portato ad esiti sanguinari sconosciuti alla nostra storia. Nel Risorgimento, il rapporto conosce fasi positive e negative, ma entrambe le parti non superano mai la soglia dell’irreversibile.
La Destra storica, per propria lungimiranza e per saggezza degli artefici del Risorgimento, ammoderna il Piemonte e l’Italia, introduce la libertà e l’eguaglianza religiosa, la laicità dello Stato, cede a qualche asprezza, ma non spezza mai il cordone ombelicale con la tradizione cattolica: quando abolisce gli ordini religiosi lascia che questi si ricostituiscano fruendo di intelligenti tolleranze; non cancella l’insegnamento cattolico nelle scuole elementari, dimodoché quasi tutti i bambini in Italia dall’Ottocento ad oggi sono stati educati ricevendo almeno i rudimenti di quella religione che addolcisce, eleva, deposita nell’animo semi che germogliano nella coscienza; non attenta mai all’autonomia della Chiesa né pensa come la Francia rivoluzionaria di realizzare quella reformatio ecclesiae che costituisce l’incubo della Chiesa nell’epoca dei totalitarismi.
L’Italia non conosce la paura che si creino chiese fittizie, asservite allo Stato, strutturate con falso democraticismo, anche perché liberali e cattolici su un punto sono d’accordo, che compito della Chiesa è quello di essere spirituale, non democratica. Sembra poco, invece è moltissimo. D’altra parte, i cattolici colpiti dalla legislazione eversiva, protestano ma obbediscono, obbediscono alle leggi, si impegnano per cambiarle, non negano mai il riconoscimento di legittimità al nuovo ordine nazionale. Vi sono momenti del Risorgimento nei quali un inchiostro simpatico quasi scrive dei sottili, ma formidabili, compromessi utili alle due sponde del Tevere per non farsi la guerra e intessere nuove relazioni nei tempi storici giusti.
Infine, e soprattutto, il conflitto con la Chiesa esiste ma è limitato alla sfera istituzionale, senza mai investire quella dottrinale e della fede. I cattolici partecipano sin dall’inizio al movimento per l’indipendenza nazionale con grandi personalità della cultura e della politica, combattono nelle guerre patriottiche, progettano, si impegnano per un’Italia unita e solidale. Dai neo-guelfi ai cattolici liberali, dal clero che cura e assiste combattenti e prigionieri, ai religiosi che soffrono ma proseguono nel servizio per i più poveri e gli ultimi della società, il cattolicesimo italiano è parte integrante della storia d’Italia dell’Ottocento che trasforma la nazione in uno Stato unitario, aperto ai diritti di libertà.
Se si guarda all’Ottocento italiano con sguardo positivo si ha una visione più gratificante e obiettiva del Risorgimento. Possiamo leggerlo come naturale approdo di una storia nazionale plurisecolare, comprendere che lo Stato unitario ha fruito di una eredità religiosa e culturale che altri Stati hanno impiegato secoli a costruire. Chiunque di noi sa, con ogni rispetto, che se Carducci e Pascoli, Collodi o De Amicis, anche D’Annunzio, hanno contribuito a cementare l’unità culturale italiana, in realtà la nostra identità preesiste al Risorgimento ed insieme alla lingua, all’arte, alla religione, essa ha potuto riempire con orgoglio il nuovo Stato, altrimenti debole, che si andava costruendo.
Il Risorgimento dona unità politica ad un popolo che è nazione da sempre, lo introduce nella modernità consentita dai tempi. Parla molte lingue, vive molti contrasti, ma li supera senza estremismi, senza umiliare nessuno, seguendo il filo rosso di quella storia nobile che è propria delle popolazioni italiane. In una lettura non retorica possiamo scoprire anche le nostre virtù, l’inclinazione ad essere moderati, a rifiutare la violenza sistematica, a farci carico delle ragioni degli altri, virtù che ci distinguono da popoli e Stati che hanno realizzato magari grandi rivoluzioni ma portano il peso di una violenza e aggressività che hanno fatto la storia al negativo. Nella nostra storia più dolce, è la radice di un cammino che ci ha condotti ad un sistema di diritti di libertà, di laicità positiva e accogliente verso tutte le religioni, che resta ancora oggi il nostro vanto in Europa e in Occidente.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 98
Le critiche [alla correttezza dei plebisciti] sono fondate (valgono anche per i plebisciti a Savoia e Nizza) ma sono cosa piccola rispetto alla sostanza dei fatti. L'Italia del 1860 è come altri Paesi, le svolte politiche sono determinate da minoranze attive, con l'assenza delle masse rurali e della popolazione analfabeta, ma il movimento per l'unità del Paese è maggioritario in tutta la borghesia, quasi uno sbocco naturale di un processo storico inevitabile, approdo di un movimento che è riconosciuto a livello internazionale.
Il biennio 1859-60 dimostra che l'obiettivo dell'unità nazionale ha grande forza intrinseca, capace di abbattere ogni ostacolo, di superare ogni previsione o accordo diplomatico. La partecipazione dei cattolici alla guerra contro l'Austria è di vaste proporzioni, discende dalla diffusione del pensiero liberale moderato tra il clero e i fedeli. I vescovi Piemontesi, e con essi quelli della Toscana e della Lombardia, non hanno difficoltà a recitare l'orazione Pro tempore belli nella guerra del 1859, a collaborare in tutto ciòche è lecito per il successo della guerra, mentre il clero svolge una funzione positiva tra la popolazione e conferma piena compatibilità tra le esigenze patriottiche e l'appartenenza alla Chiesa. Altrettanto accade alla fine della guerra quando le nuove autorità sono accettate e riconosciute non solo per legittimismo ma per autentica convinzione. Il quadro, invece, si complica, non appena gli eventi slittano verso l'occupazione e lo smembramento dei territori pontifici, fino alla loro annessione al Piemonte. Si complicherà di più, provocando tensioni tra cattolici e unità nazionale, quando il nuovo Regno estende automaticamente le leggi eversive ai territori annessi, e soprattutto quando nel 1866 ne fa di nuove e più gravi con l'abolizione degli ordini religiosi e l'accentuazione delle posizioni anticlericali.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 101-102
La vicenda unitaria non finisce con l'elezione del Parlamento dello Stato del centro-nord, perché subito si verificano moti insurrezionali in Sicilia che permettono a Giuseppe Garibaldi di realizzare la spedizione dei mille, un geniale colpo di mano che conferma un dato storico: l'unità d'Italia è considerata inevitabile, anche da Napoleone III e l'Inghilterra, che pure non pensano a risultati del genere quando appoggiano le rivendicazioni del Piemonte. Contro la spedizione dei mille si ripetono ancora oggi dure critiche. Si tratta di una furbizia piemontese, con Cavour che la permette senza assumerne la paternità: fa partire i mille, proibisce che abbiano armi vere, vieta di approdare sui territori pontifici, è pronto a prenderne le distanze, magari ad arrestare Garibaldi se le cose si mettono male; essa si avvale inoltre di una finta neutralità inglese che si fa sentire al momento dello sbarco a Marsala, vince perché utilizza violenza e corruzione nei confronti della popolazione e dell'esercito legittimi sta di Francesco di Borbone. Tutto ciò è abbastanza vero. Ma non si vede l'altra faccia della medaglia, il fatto che nello spazio di pochi mesi un regno intero va in disfacimento, gran parte del suo esercito si sfalda, mentre cresce il sostegno popolare a Garibaldi, in alcune zone anche di clero e religiosi. Lucio Villari coglie questo aspetto quando osserva, in riferimento ai soldati borbonici, che «scarsa cultura e nessun ideale di italiano dovevano illuminarli. Fu per questo che il bene armato esercito borbonico, privo di supporti culturali e di alte idealità, agì stupito fino al tradimento del 1860. Un castello di carte che sarebbe crollato, tranne un estremo guizzo di orgoglio, sotto l'impeto patriottico delle camice rosse di Garibaldi».
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 19-22
Le popolazioni italiane non hanno mai conosciuto l'altro terribile male dell'Occidente, quello dei conflitti razziali e della schiavitù elevata a sistema che condiziona alcuni Stati e la loro storia moderna. Non l'hanno conosciuto perché la schiavitù s'è dissolta nel tempo ad opera del cristianesimo, e perché esse hanno vissuto un universalismo di religione, d'arte e di mercato, mai di conquista. Più precisamente, gli italiani sono stati conquistati da altri e si sono dovuti destreggiare tra diverse dominazioni, ma vivono per secoli nel crocevia del mediterraneo ove vanno e vengono popolazioni d'ogni genere; per essi nessun popolo è estraneo, o inferiore agli altri, prima o poi se li trovano in casa e devono convivervi, con difficoltà ma senza odio. È esattamente il contrario di ciò che accade ad altre nazioni, a cominciare da quella americana, la quale nasce religiosamente plurale ma con una malattia mortale provocata da un corpo estraneo alle sue etnie bianche, quello dei neri importati a forza dall'Africa e considerati schiavi a servizio degli Stati del Sud che li usano e sfruttano considerandoli antropologicamente inferiori. L'ombra lunga del razzismo non è esclusiva degli USA ma ha radice in settori del protestantesimo europeo e accompagna la storia di diversi Stati. Dell'Inghilterra che coltiva a lungo la schiavitù e solo nel XIX secolo la abolisce, fino a quando nel 1873 a Zanzibar il Governo inglese firma il trattato per la messa al bando del commercio arabo degli schiavi. Dell'Olanda la cui Chiesa calvinista dice ai coloni che vanno in Sud Africa, la terra del sole e dei diamanti, che le razze non bianche sono inferiori anche davanti a Dio. In questo Stato, la minoranza prende tutto il potere e decreta l'apartheid che si protrae sino ai giorni nostri. Ancora nel 1954 si giustifica la segregazione razziale perché «da differenza di colore non è che la manifestazione fisica tra due modi di vita inconciliabili, tra la barbarie e la civiltà, tra il paganesimo e il cristianesimo e, infine, tra il numero schiacciante da un lato e il numero insignificante dall'altro. Era così all'origine (dalla creazione della prima colonia olandese al Capo nel 1652) e, nell'insieme, è ancora oggi»[1]. Il cattolicesimo romano non ha mai usato questo linguaggio, né mai ha spinto un popolo a schiavizzare un altro: anche se non siamo soliti pensarci, è così.
Invece, negli Stati Uniti d'America, terra di approdo di tutte le Chiese protestanti, schiavitù e razzismo riescono a macchiare anche la Dichiara zione di indipendenza del 1776 che pure fa sognare gli uomini di tutto i mondo: «consideriamo come evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono stati creati e dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà, il conseguimento della felicità». In realtà, quel sogno resta a lungo un sogno di bianchi, perché tra gli uomini chiamati alla libertà e alle felicità non vi sono le persone di colore che per due secoli sono portate a forza dall'Africa per essere schiavizzate e che la Suprema Corte degli Stati Uniti considera nel 1857 «come una classe di esseri subordinati e inferiori, che erano stati soggiogati dalla razza dominante e che, fossero emancipati o meno, rimanevano tuttavia soggetti alla autorità dei bianchi»; essi erano
talmente inferiori che il negro poteva essere «comprato e venduto, e trattato come un articolo ordinario di mercato e commercio, quando poteva esserne tratto profitto». D'altronde, la Corte ricorda che la schiavizzazione dei neri «in nessuna nazione era più fermamente radicata e più uniformemente applicata che nel governo Inglese e nel popolo Inglese. Non solo li catturavano sulla costa africana, e li vendevano e li mantenevano in schiavitù per il loro uso privato, ma li portavano come ordinari articoli di mercato in ogni Paese in cui potevano trarre un profitto della loro vendita, ed erano largamente più impegnati in questo commercio di qualunque altra nazione al mondo». Abraham Lincoln libera i neri dalla schiavitù ma non dal razzismo, e dopo la abolizione delle catene la loro condizione resta quella di esuli in patria. Ricorda Alexis de Tocqueville che «nel Nord dell'Unione la legge permette ai negri e ai bianchi di contrarre matrimoni legittimi, ma l'opinione pubblica dichiara infame il bianco che si unisce a una negra e sarebbe molto difficile citare esempi di un simile fatto. In quasi tutti gli Stati in cui la schiavitù è stata abolita si sono concessi ai negri i dirittielettorali, ma se uno di loro sipresenta a votare rischia la vita. (...) I suoifigli sono esclusidalle scuole frequentate dai bianchi; nei teatri egli non può neanche a prezzo d'oro sperare di sedersi vicino a colui che fu suo padrone; negli ospedali giace a parte. Si permette al negro di pregare lo stesso Dio dei bianchi, ma non di pregarlo allo stesso altare; egli ha i suoi sacerdoti e i suoi templi. Non gli si chiude la porta del cielo: l'ineguaglianza si ferma appena alle porte dell'altro mondo». Nel 1896 la Corte Suprema legittima questo razzismo che negli USA sfiora quasi il XXI secolo perché «la legge non ha il potere di sradicare gli istinti razzisti o di abolire le distinzioni basate sulle differenze fisiche. (...) Se una razza è inferiore all'altra socialmente, la Costituzione degli Stati Uniti non può porle entrambe sullo stesso piano».
Nessuno lo dice mai, ma l'Italia non soffre nell'anima di nessuno di questi mali, perché il suo essere nazione da secoli l'ha resa immune da malattie mortali, le ha permesso di vivere una storia più dolce, meno aspra di altri. L'Italia non è razzista, è aperta a chiunque, anche per merito della romanità e della cattolicità. Non ha odio violento per il nemico, perché un sentimento di umanità traspira dalla sua religione, dalla sua letteratura ed arte. Non ha ansia di conquista e dominio sugli altri, è più pacificata con se stessa, forse perché troppo debole per sognare il colonialismo e l'imperialismo. Gli italiani si dividono, e forse lo faranno sempre perché sono stati sempre divisi, inseguono utopie bellissime, sapendo che le realizzeranno solo in minima parte. Ma le divisioni non cancellano né un sentire comune né la voglia di sognare degli italiani. A modo suo, anche Giuseppe Garibaldi è figlio di questa universalità utopica, perché va in soccorso di chiunque ritiene debole o oppresso, correndo il rischio di prendere grossi abbagli (difende persino l'estremismo della Comune di Parigi nel 1871), e lo fa con coraggio e temerarietà che affascinano mezzo mondo, da Londra a Washington, da Parigi a Varsavia. Potrebbe andare a combattere per il Nord nella guerra di secessione americana, ma il progetto non si realizza forse per le richieste di Garibaldi che sembrano eccessive anche per la generosità degli USA. Nel 1860, all'epoca della spedizione dei mille, accorrono a lui volontari dalla Gran Bretagna, e formano una brigata con operai di Londra e Glasgow, e perfino in Russia l'anarchico Bakunin sente dei contadini siberiani che sperano di essere un giorno liberati da «Garibaldov». Garibaldi inaugura, senza saperlo, l'ingerenza umanitaria che soccorre chiunque subisca soprusi, magari combinando qualche pasticcio. Per queste ragioni l'Italia non ha bisogno di avere un 4 luglio come gli americani, i quali hanno solo quella data da festeggiare, non avendo altra storia dietro di sé. Non può celebrare un 14 luglio come fanno i francesi perché ha tante ricorrenze storiche, religiose, artistiche, che si festeggiano un po' dovunque, sono ricorrenze di gioia e di fede senza memoria di rivoluzioni sanguinarie. Gli italiani studiano, conoscono, a volte festeggiano, le date della loro antichità, della lunga storia cristiana, prediligono le festività mariane, quelle dei Patroni locali, la memoria di illustri connazionali del passato lontano e recente. Ridurre tutto ciò ad una o due date a carattere esclusivista ferirebbe la nostra identità ricca di modulazioni. Le popolazioni italiane hanno una coscienza nazionale vivissima che però non è legata solo allo Stato unitario, affonda memoria e radici più lontano nel tempo, comprende valori più ampi rispetto a quelli statuali. Il risorgimento quindi si sviluppa in un Paese che ha una storia positiva, si realizza in un'epoca di grande sviluppo e civiltà, non deve pagare prezzi di ferocia a nessuno, si compie in una nazione che coltiva molte virtù, insieme a qualche difetto, ma non ha nel DNA la violenza, o l'istinto repressivo, si evolve lucrando sulle virtù. Mettendole a frutto.
5/ Senza dimenticare la durezza del Risorgimento dal punto di vista dello stato e dal punto di vista nella Chiesa…
5.1/ La Repubblica Romana
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 74
G. Mazzini nel I intervento alla Repubblica Romana
A Roma deve sfiorire il papato, gli italiani si appropriano della sua universalità, la sovranità del popolo farà scomparire ogni potere, temporale o spirituale: «dopo la Roma degli imperatori, dopo la Roma dei Papi, verrà la Roma del popolo. Una nuova epoca sorge, la quale non ammette il cristianesimo, né riconosce l'antica autorità.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 75-77
Ispirata da Mazzini, la Repubblica Romana anticipa un carattere tipico del risorgimento italiano, l'essere contro la Chiesa-istituzione e volere al tempo stesso la sua benedizione. Mai in Italia si cantano tanti Te Deum come nell’800 per ringraziare Dio di eventi del tutto opposti: per le repubbliche francesizzanti e per le restaurazioni assolutiste, per la Repubblica Romana e per l'Austria che reprime i patrioti, per lo Statuto Albertino e il nuovo Regno che abbatte lo Stato pontificio, per Garibaldi che vince quasi sempre, e naturalmente per Pio IX e la Chiesa. I triumviri decidono che il giorno di Pasqua 8 aprile venga celebrata una solenne messa in San Pietro e di fronte al rifiuto dei canonici, fanno celebrare il rito da Mons. Spola con l'assistenza del barnabita Alessandro Gavazzi e del teatino Gioachino Ventura. Il tricolore viene integrato nelle cerimonie religiose, il venerdì santo in San Pietro viene posta una croce illuminata con i colori bianco rosso e verde, alla messa della domenica Mazzini assiste in posizione speciale con sciarpa tricolore.
Alla Chiesa si chiede di celebrare riti, e cantare inni, per la Repubblica o i suoi governanti, si puniscono vescovi e preti che si rifiutano di obbedire. Il Decreto dell'Assemblea costituente del 26 marzo istituisce «un Triduo solenne alla Divinità in Roma e nello Stato, ad inaugurare, colle benedizioni del Cielo, la Guerra italiana». Il Decreto dei Triumviri del 30 aprile, dopo lo sbarco a Civitavecchia e il prevedibile attacco delle truppe francesi di Oudinot, dispone che «al primo suono della campana a stormo, sarà esposto nelle principali Chiese il Santissimo per implorare la salute di Roma e la vittoria del buon diritto». Nel pieno della resistenza anti-francese il Decreto del ministro dell'Interno del 6 giugno dispone che in ciascuna Chiesa si solennizzi «il giorno dedicato a festeggiare l'Ostia di Pace e d'Amore» e che «le umili preci dei Cristiani, sceverate dal fasto, s'innalzino al Cielo, e più gradite saranno accolte ad espiazione dei peccati ed a soccorso del Popolo pregante e fidente in quel Dio che benedice e tutela la causa degli oppressi». La rivoluzione parla il linguaggio del papa esiliato.
La Repubblica realizza, almeno teoricamente, un opera di spoliazione integrale della Chiesa, nazionalizzando «tutti i beni ecclesiastici dello Stato romano» (Decr. 9 febbraio), e promette di provvedere al sostentamento del clero, secondo le decisioni assunte dal Decreto dei Triumviri del 27 aprile. Il Decreto avvisa, però, che il pagamento degli stipendi al clero sarà effettuato «dal giorno in cui l'amministrazione del demanio incomincerà ad introitare tutte le rendite della famiglia ecclesiastica», e ciò non è possibile perché la Repubblica finisce il 4 luglio successivo. In effetti, quasi tutti i provvedimenti repubblicani, soprattutto quelli relativi ai beni ecclesiastici, sono virtuali perché non vi è il tempo per realizzarli 25, ma il decreto del 26 febbraio pone «i Palazzi così detti apostoli ci e loro dipendenze, sotto la sorveglianza del ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà alle necessarie riparazioni», e il Decreto dell'8 marzo dispone che «i giardini del Quirinale e del Vaticano, incominciando da domenica 18 corrente, saranno aperti al pubblico tutte le domeniche dalle dieci del mattino fino al tramontar del sole». Il 14 marzo, l'Assemblea costituente dichiara «incapaci di acquistare per qualsivoglia titolo, sia lucrativo sia oneroso, tanto per atti tra vivi che di ultima volontà (…), le Chiese, le Corporazioni religiose, gli stabilimenti di pubblica beneficenza, ed in generale le manomorte». Infine, per il Decreto del Triumvirato del 27 aprile «la società non riconosce perpetuità di voti particolari ai differenti ordini religiosi così detti regolari», ed è «in facoltà d'ogni individuo facente parte di un ordine religioso qualunque di sciogliersi da quelle regole, all'osservanza delle quali s'era obbligato con voto». Lo Stato accoglierà «con gratitudine tra le file delle sue milizie quei religiosi che vorranno colle armi difendere la patria, per la quale finora hanno innalzato preghiere a Dio».
Soltanto il 3 luglio è promulgata la Costituzione della Repubblica Romana che afferma, tra l'altro, i fondamentali diritti di libertà, tra i quali il diritto di libertà religiosa, l'abolizione della pena di morte, la libertà della scuola, l'unicità di giurisdizione, e conferma che «il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale». Ma le guarentigie del papa sarebbero quelle di un vescovo qualsiasi, con una Chiesa nazionalizzata, con pochi ordini religiosi e senza beni propri, con i preti stipendiati dallo Stato. La breve vita della Repubblica Romana non è contrassegnata da particolari violenze, né da una parte né dall'altra. Certo, il clero rimane in maggioranza ostile, così come la più parte della popolazione rimane passiva, alcuni cardinali e vescovi sono arrestati, o allontanati dalla sede, non mancano ostilità clericali, e manifestazioni di anticlericalesimo. Ma nell'insieme si può parlare di un limitato tasso di violenza, come si ricava dalla notificazione del 14 febbraio in cui si legge: «Oggi è stato affisso un avviso ai Sacerdoti che ha tutti i caratteri di una morale violenza fatta ad una rispettabile classe di cittadini. Noi riproviamo altamente quest'atto di prepotente licenza, e siano risoluti a prendere le misure più rigorose contro gli autori, stampatori, o pubblicatori di siffatti scritti, che evidentemente sono mascherati nemici nostri, e che disonorerebbero un Popolo che li lasciasse impuniti. La Repubblica non è l'anarchia; la libertà non è la licenza. Tutti i principi d'ordine e di temperanza civile, fanno la gloria suprema di questa nostra santa rivoluzione».
Mazzini, figlio del dio progresso, di Marco Roncalli (da Avvenire, su www.gliscritti.it )
Ci sono le venti paginette Dal Papa al Concilio scritte nel 1832 e riviste nel 1849 con un’analisi spietata in cui si dichiara «spento moralmente il Papato» e si invoca un Concilio «raccolto da un popolo libero e affratellato nel culto del Dovere e dell’Ideale, dei migliori per senno e virtù fra i credenti nelle cose eterne, nella missione della creatura di Dio sulla terra, nell’adorazione della Verità progressiva».
E c’è la lunga lettera Dal Concilio a Dio , scritta nel 1870, due anni prima della morte in casa Rosselli, sorta di testamento politico-religioso in cui, rivolto ai Padri riuniti al Vaticano I sull’infallibilità del pontefice, l’autore esplicita non solo punti di dissenso dalla Chiesa cattolica, ma la sua Weltanschauung, religiosa, ma tutt’altro che cristiana: «Il vostro dogma si compendia nei due termini: Caduta e Redenzione; il nostro nei due: Dio e Progresso. Termine intermedio tra la Caduta e la Redenzione è, per voi, l’incarnazione del Figlio di Dio: termine intermedio per noi tra Dio e la sua Legge è l’incarnazione progressiva di quella Legge nell’Umanità, chiamata a scoprirla lentamente e compirla attraverso un avvenire incommensurabile... Noi crediamo nello Spirito, non nel Figlio di Dio».
C’è il breve testo Dubbio e fede del 1862, amaro, ma non rassegnato, in cui la fiducia in Dio si lega al dovere per il riscatto della Patria contro la tirannide papale e il cancro del materialismo. E c’è, infine, una ancor più breve Preghiera a Dio per i piantatori , nata nel 1846 come un contributo sull’abolizione della schiavitù, nella quale si chiede a Dio di intercedere non nei confronti degli schiavi, ma dei proprietari, i piantatori di cotone, affinché «l’angelo del pentimento discenda e si accosti al loro guanciale di morte».
I quattro scritti mazziniani appena illustrati, senza dimenticare i Doveri dell’uomo non solo ci dicono molto sull’importanza della religione per il celebre genovese così deciso a tenere separati potere temporale e spirituale, nonché tenace oppositore di ogni assolutismo clericale o laico, ma, a ben guardare, sembrano andar oltre il loro legame con la lotta per l’unità d’Italia, pur così evidente.
Resta chiaro il dato di una religione che è solo quella del Progresso e di una Rivelazione che, per Mazzini, configura un fenomeno molto più grande della vicenda narrata nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Con un approccio a Gesù considerato «fratello» ma non «Signore e Redentore», «uomo esemplare», sì, ma non Dio, né mediatore tra l’uomo e Dio, che è Dio di tutti e non d’una casta, che «esiste, perché noi esistiamo», che «vive nella nostra coscienza, nella coscienza dell’Umanità, nell’Universo che ci circonda», «Dio resta, come resta il Popolo, immagine di Dio sulla terra».
Insomma, un Mazzini meno conosciuto quello in questa raccolta curata da Andrea Panerini, sintesi di un pensiero religioso (nonostante l’influenza nella formazione della madre, Maria Drago, religiosissima e di alcuni sacerdoti giansenisti) lontano da tutte le ortodossie cristiane. «Crediamo in un cielo nel quale siamo, moviamo, amiamo, che abbraccia, come Oceano seminato d’isole, la serie indefinita delle nostre esistenze; crediamo nella continuità della vita, nella connessione di tutti i periodi diversi, attraverso i quali essa si trasforma e si svolve, nell’eternità degli affetti virtuosi, serbati con costanza fino all’ultimo giorno d’ogni nostra esistenza...».
Il triumviro, che nelle poche settimane di vita della Repubblica Romana (1849), aveva fatto sventolare la bandiera con il motto dell’avvenire, 'Dio e il Popolo' più tardi così riassume il suo credo: «Splenda sulla santa Crociata il segno della Nuova fede: Dio, Progresso, Umanità. Dio, principio e fine di ogni cosa. Progresso, la legge da lui data alla Vita. L’Umanità, l’interprete, nel tempo e a tempo, di quella Legge».
Una religione in cui c’è una storia umana che ha un senso, attua un progetto divino, ma per il profeta dell’Unità nazionale, nel segno di una parola ignota all’antichità, resa a forza sacra, il Progresso, e dove il cristianesimo è ridotto a etica.
dal parroco di San Giacomo al Corso (fonte orale)
I confessionali della madre di Ciceruacchio in San Giacomo al Corso: il rivoluzionario li voleva bruciare, la madre si oppone al figlio
5.2/ Il chiudersi della Chiesa
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp.116-117
Il cardinale Sisto Riario Sforza di Napoli interviene al Concilio Vaticano I e parla dei vescovi che gemono sotto il gioco della chiesa di Stato mentre a Roma respirano l’universalità del cattolicesimo: «appena essi escono dagli angusti confini del loro paese, il loro cuore si dilata sotto il libero cielo della chiesa romana... ed essi sperimentano realmente che cosa significa che la Chiesa di Cristo è cattolica, cioè dotata di vita universale, e dalla sede romana diffusa in tutto il mondo; allora essi avvertono una nuova forza e capiscono chi essi sono, vale a dire i principi di quella comunità che spezza tutti i confini spaziali e comprende tutta la terra; ora sono fermamente convinti che solo il papa, che detiene sulla terra il posto di Cristo, per dignità episcopale è al di sopra dei vescovi».
Resta però un fatto che completa la complessità, perché la Chiesa non distingue le fonti buone del liberalismo dai frutti velenosi del laicismo, non comprende che l'Europa delle nazioni chiede cambiamenti anche al potere temporale. Soprattutto non comprende che quelle prime affermazioni dei diritti di libertà politica, religiosa, culturale, del liberalismo sono espressione di una nuova storia universale, sono frutto della civilizzazione cristiana che ha fatto crescere l'Occidente rispetto ad altre parti del mondo, immerse in una storia minore. In qualche modo Roma non riconosce la propria paternità dei diritti di libertà e di eguaglianza tra gli uomini, prende le distanze da una società più libera che essa ha contribuito a formare. L'immagine del papa che dopo il 1870 si chiude in Vaticano senza più uscirne, reclamando giustizia contro i soprusi del Regno d'Italia, ha una sua grandezza, ma tradisce l'isolamento, riflette la paura anziché la speranza, anche se la storia attesta che sul punto di principio della necessità di una vera sovranità per essere libero il papa ha ragione, e gli sarà riconosciuto più tardi.
5.3/ L’indurirsi della situazione
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp.109-110
Insieme al 1848, la guerra d'indipendenza del 1859, registra la più ampia partecipazione dei cattolici al risorgimento, per convinzione, per legittimismo, per la soddisfazione nel vedere realizzato il sogno unitario degli ultimi decenni; anche la spedizione dei mille, nelle sue tante sfaccettature, incontra consensi cattolici verso l'obiettivo di farla finita con i tanti regni italiani. Il 1860 costituisce invece l'anno di svolta, che vede questi consensi incrinarsi, prima nel clero poi nella popolazione cattolica, non solo per le vicende legate alla fine dello Stato pontificio, ma per una ragione più profonda che riguarda l'atteggiamento del nuovo Regno verso la Chiesa e il cattolicesimo. Il nuovo Regno si insuperbisce presto, i suoi governanti sono frastornati dai successi ottenuti, pensano ormai di poter fare da soli, non cercano di attirare a sé coloro che sono in una posizione di attesa. Si avvia la tendenza a vedere nei cattolici una forza antinazionale, si eccede in arresti di vescovi e sacerdoti, che poi vengono liberati perché non si sa di cosa accusarli, riprendono il via le riforme di politica ecclesiastica con la svolta definitiva dopo il 1861: la legislazione eversiva del Piemonte viene d'improvviso estesa alle regioni annesse, nel 1866-67 ed è inasprita con l'abolizione degli Ordini religiosi (e altri enti ecclesiastici) senza eccezione. Manca intelligenza e accortezza, capacità di distinguere, nel clero si diffonde la convinzione che il papa ha ragione quando si oppone al nuovo Regno, che questo è nemico della religione, aumenta la freddezza, si pongono le basi per quella ostilità cattolica che, dopo il 1870, Pio IX sfrutterà a favore della Chiesa e delle sue ragioni. Forse, la morte di Camillo Cavour, scomparso nel giugno 1861, favorisce una deriva laicista che lui non avrebbe voluto, o avrebbe mitigato con intelligenza.
5.4/ La soppressione dei Gesuiti e via via degli Ordini religiosi
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 85-86
agosto 1848
La voglia di fare piazza pulita traspare dal linguaggio virulento della Relazione che pone la domanda «se una setta religiosa, di cui le perniciose tendenze, oltre a compromettere la privata e pubblica tranquillità, minaccerebbero pure nelle stesse sue fondamenta la politica esistenza della nazione, possa o no venirvi ulteriormente tollerata», e conclude sulla necessità di «svellere nelle sue radici tutto quanto tocca nella sostanza alle massime e dottrine del Gesuitismo». Per l'articolo 1 della legge, «la Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti, ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone». La soppressione, dunque, non comporta solo (come si farà per altri ordini) la perdita della personalità giuridica ma la dispersione delle persone, l'esilio per i gesuiti non regnicoli, soprattutto il diniego della stessa libertà di riunione, criticato da quanti denunciano la contrarietà della legge allo Statuto e ai più elementari diritti dei cittadini. I gesuiti regnicoli devono rilasciare davanti alle autorità di polizia una dichiarazione di determinato e fisso domicilio. Viene accordata una pensione annua di lire cinquecento, a condizione che si presenti all'autorità di polizia una domanda formale di secolarizzazione, che il Governo inoltrerà alla Santa Sede. Non si può immaginare legge più illiberale, tuttavia essa non incontra l'opposizione che forse meriterebbe dal momento che i gesuiti non sono capaci di suscitare simpatie nei ceti popolari, neanche in in tutte le aree della Chiesa, ed è motivata dall'eccezionalità del pericolo.
5.5/ La soppressione di tutti gli ordini religiosi
Leggi del 1855 che sopprimono tutti gli ordini religiosi che non sono di vita attiva
Leggi del 1866
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp.110-112
La legge sulla abolizione degli ordini religiosi non è eguale a quella piemontese del 1855, che aveva infranto un tabù storico, ma entro confini precisi: abolizione degli ordini contemplativi, con rispetto per i religiosi e le religiose che volevano continuare a fare vita in comune. Le leggi del 1866-67 realizzano quasi i sogni rivoluzionari dell'Ottocento, spezzare la forza economica della Chiesa, cancellare la vita religiosa e le sue strutture dalla società civile, incamerare i beni ecclesiastici, mantenere soltanto le strutture che abbiano cura d'anime, a cominciare da quelle beneficiali, parrocchiali e diocesane. Entro certi limiti si può dire che accade in Italia (come in altri Stati cattolici) ciò che la Riforma protestante realizza nel secolo XVI ovunque essa trionfi, quando l'abolizione dei voti religiosi e del celibato da parte di Lutero, fa svuotare i conventi, svende i beni ecclesiastici alla nobiltà e alla borghesia più intraprendente, riduce la Chiesa a livello di una struttura statale, sostenuta e controllata dal potere politico.
C'è, però, una grande differenza tra le riforme del sec. XVI e quelle dell'Ottocento, perché le prime sono germinate nella nuova Chiesa, con il suo consenso, lo Stato si limita a coglierne i frutti magari con l'uso del braccio secolare, mentre nell'Ottocento è lo Stato che impone alla Chiesa il drastico ridimensionamento delle sue strutture, con misure giuridiche che non hanno nulla di liberale e contrastano con il diritto di libertà religiosa. Si tratta di un terremoto che interessa 25.000 enti, 1793 tra conventi, monasteri e case religiose maschili e femminili con oltre 100.000 tra religiosi e religiose in tutta Italia che devono in gran parte lasciare i conventi, tornare ad una vita civile, aiutati soltanto dalla riscossione di una pensione sociale. E che coinvolge una massa patrimoniale ingente il cui destino è molto variegato. Ancora oggi, in grandi città e nei centri di maggiore tradizione religiosa si scorgono vicino alle Chiese ex-conventuali (a Roma sono le maggiori chiese del centro storico, sedi di case generalizie dei più gloriosi ordini) postazioni di carabinieri o polizia, caserme, scuole, ospedali, allocati negli antichi conventi. Si tratta dell'uso positivo dell'espropriazione dei beni ecclesiastici, destinati a fini di pubblica utilità, propri di uno Stato moderno, che danno all'Italia quel minimo di strutture pubbliche che non potrebbe realizzare d'incanto. Molti beni ecclesiastici sono immessi sul mercato ed è abbattuta quella manomorta che, comunque la si giudichi, non è in sintonia con la modernità.
Ma ci sono anche scelleratezze e guasti che non vanno dimenticati. Ad essere colpiti sono tutti indistintamente gli ordini religiosi, quelli più solidi e di antica tradizione, e quelli meno attivi con ricchezze immobilizzate, senza distinguere, discernere, anche in un'ottica laica, ciò che può essere utile, o meno, alla collettività. Sono vanificate opere e attività sociali, soprattutto di istruzione ed educazione, che potrebbero essere importanti per il nuovo Stato unitario, viene colpito un patrimonio culturale che in Italia rappresenta qualcosa di unico al mondo. Un aspetto davvero deprimente riguarda le biblioteche e gli archivi dei maggiori ordini religiosi, dove si conservano testi e documenti antichi, che sono trattati alla stregua di ogni altro bene. Alcune divengono biblioteche comunali, con l'abbandono e l'incuria facilmente immaginabili, altre sono vendute lasciando che siano soggetti laici, italiani o stranieri, ad appropriarsene. Alcune biblioteche verranno recuperate nel secolo XX, con mezzi tecnologici avanzati (strumenti foto-visivi), e potranno ricostituirsi faticosamente le unità culturali originarie.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 112
Da un punto vista politico, la nuova legislazione ecclesiastica colpisce il corpo cattolico del Paese, dimostra insipienza, provoca amarezza, delusione, alimenta una resistenza interiore di cui lo Stato italiano non calcola bene gli effetti. Nasce in questi anni quel distacco dei cattolici, non dall'Unità d'Italia, ma dallo Stato italiano per come si struttura e agisce nei confronti della Chiesa e della religione cattolica. Nasce tra il 1860 e il 1870 quella opposizione cattolica che, compreso l'andamento delle cose, decide di raccogliersi e organizzarsi per adeguarsi ad una modernità che si è rivelata ostile, mentre poteva essere più saggia e intelligente. C'è sul punto silenzio e reticenza nella storiografia sul risorgimento, quasi a voler limitare il conflitto con la Chiesa alla questione romana, senza riconoscere l'inconciliabilità delle leggi eversive con i principi liberali classici.
6/ … ma esaltando la moderazione tipica dello Stato e della Chiesa in Italia
6.1/ Il re Vittorio Emanuele
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 89
Ma l'importanza della lettera [sulla legge sul matrimonio che decreta il matrimonio civile] sta nel biglietto accluso, con «parole in tono tutto confidenziale scritte su di un taccolino», nel quale Vittorio Emanuele confida: «sappia la Santità Vostra che sono io che non lasciò votare la legge sul Matrimonio dal Senato, che sono io che ora farò il possibile per non lasciare votare quella sui conventi. Forse fra brevi giorni questo ministero Cavour cascherà, ne nominerò uno della destra e metterò per condizione sine qua non che mi si venga al più presto ad un totale aggiustamento con Roma, (Mi faccia la carità di aiutarmi) io per parte mia ho sempre fatto quel che ho potuto. (Quelle parole al Piemonte non ci andavano adesso, ho paura che mi guasti tutto). Guarderò che la legge non passi, ma mi aiuti poi Santo Padre. Bruci questo pezzo di carta per farmi piacere». […]
È il caso di segnalare che quello inviato al papa non è l'unico biglietto imbarazzante del re, almeno un altro è fatto recapitare nel 1860 a Garibaldi che ha liberato la Sicilia e vuole liberare il resto del Regno dei Borboni. Vittorio Emanuele lo invita il 27 luglio a fermarsi, e lasciare che i siciliani decidano il loro destino. Allegato alla lettera vi è un biglietto riservato nel quale il re chiede a Garibaldi di rispondergli negativamente.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 95
Aggiunge una notizia che ci introduce nell'Italia delle alte raccomandazioni: «non ha chiesto (il Re) che una sola cosa: la conservazione delle Sacramentine, convento al quale sua Madre e soprattutto il Duca di Genova tenevano molto. Rattazzi ha preso l'impegno di aderire a questo desiderio, e le Sacramentine rimarranno malgrado la loro inutilità assoluta». Saranno eccezioni, ma anche nelle successive leggi eversive nazionali qualche convento, o ordine religioso, si salverà, forse per raccomandazione, forse per l'intelligenza delle persone.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp.99-100
[La] relativa tranquillità del papa sembra confermata dallo scambio epistolare con Vittorio Emanuele II tra maggio e giugno 1959, che verte su due punti essenzialmente. Il re vuole ottenere l'assoluzione dalle censure e scomuniche degli anni precedenti, e chiede «direttamente alla Santità Vostra, come padre caritatevole dei fedeli, onde ottenere tal grazia, osservi pure Beatissimo Padre che comando io in persona l'esercito, mi trovai già in vari scontri micidiali e sono in pericolo di morte ad ogni istante». Inoltre, poiché per ottenere l'assoluzione è anche necessario che egli ponga fine alla relazione notoria che intratteneva con Rosa Vercellana, Vittorio Emanuele aggiunge: «riguardo poi alla seconda parte diedi la mia parola a guerra finita. Credo mio dovere di farlo, non mi pento di tale risoluzione, d'altronde prevengo la Santità Vostra che tutti i miei ministri sono d'accordo con lei sul tal punto, salvo uno che non è forse il più amico di Lei Beatissimo Padre». Il ministro è Cavour. Continua ancora il re: «questa guerra, secondo ciò che Dio vorrà, anderà, se sono ancora vivo alla fine, a finire bene avrò mezzimolti nelle mani onde fare molte cose che per ora non si possono ancora fare. E spero che nell'avvenire la Santità Vostra sarà più tranquilla e contenta. Prego la Santità Vostra di non mostrare questa lettera a nessuno, e di accordarmi la Sua Santa e Paterna benedizione».
Siamo di fronte ancora a quel «doppio binario» tra pubblico e privato che Vittorio Emanuele predilige nei suoi rapporti con il papa, che presenta un profilo di intimità religiosa tutto italiano: il re vuole l'assoluzione, perché può morire da un momento all'altro, e promette che sistemerà anche la questione della relazione con Rosa Vercellana. Pio IX risponde soddisfatto: «poiché la M.V. mi scrive e mi assicura di voler metter termine assolutamente allo scandalo domestico, veggo con questa sua risoluzione aprirsi a me la via per dare ad un confessore dotto pio e prudente, come intendo di fare con la presente, tutte le necessarie facoltà per proscioglierlo da qualunque censura incorsa, e rimetterlo come lo desidero di tutto cuore in pace con Dio. Bene inteso però che quest'assoluzione per essere valida non può essere disgiunta dalla promessa da farsi dalla M.V. di riparare nel miglior modo che sarà possibile ai danni arrecati sino adesso alla Chiesa, unitamente al proposito di astenersene in avvenire, giacché la M.V. conoscerà benissimo che in caso di nuovi attentati contro la Chiesa stessa, Ella ricadrebbe (lo che Dio non permetta mai) nelle stesse censure dalle quali fosse stato assolto». In altre parole, il re avrà l'assoluzione se manterrà le sue promesse, ma deve sapere che le censure saranno rinnovate se non farà ciò che deve fare.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp.100-101
Il re aggiunge una proposta di soluzione anche per le Marche e l'Umbria, in base alla quale si potrebbe «stabilire non solo nelle Romagne ma altresì nelle Marche e nell'Umbria tale uno stato di cose che serbato alla Chiesa l'alto suo dominio ed assicurando al Sommo Pontefice un posto glorioso a capo dell'Italiana Nazione, farebbe partecipare i popoli di quelle provincie dei beneficj che un regno forte ed altamente nazionale assicura alla massima parte dell'Italia centrale». Si tratta, a ben vedere, dell'ultimo scampolo di proposta fintamente neo-guelfa che sale agli onori della cronaca politica, e che agli occhi del re costituisce una sorta di prova delle sua buona volontà i nei confronti del papa. Pio IX risponde il 14 febbraio: «la idea che V.M. ha penato di manifestarsi, è una idea non savia, e certamente non degna di un Re Cattolico, e di un Re della Casa di Savoja. La mia risposta è già consegnata alle stampe nella Enciclica all'Episcopato Cattolico, che facilmente Ella potrà leggere. Del resto lo sono afflittissimo non per Me ma per l'infelice stato dell'anima di V.M. trovandosi illaqueato dalle censure, e da quelle che maggiormente La colpiscono dopo che sarà consumato l'atto sacrilego ch'Ella coi suoi hanno intenzione di mettere in pratica». C'è qualcosa di patetico, e ineguale, in questo rapporto tra il papa e il re: il primo pronto a perdonare, pur di salvare l'anima all'altro, il secondo deciso a sfruttare questa intimità e al momento opportuno prendere lo Stato al primo facendogli capire che, essendo papa, non può usare la violenza.
6.2/ Cavour
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 81-82
L’Osservatore Romano rende onore a Cavour nel 1861 un mese dopo la sua morte riconoscendo che del grande statista il conte possedeva «le parole al servizio dell'opera, la perseveranza e la pieghevolezza, l'ardore e la pazienza, le lunghe previsioni e la prontezza a profittare dell'imprevisto, la passione che tiene sempre d'occhio lo scopo e il sangue freddo che attende il momento opportuno a raggiungerlo». Aggiunge che «quando un complesso sì raro esiste e ad un tratto sembra dissolversi (...), allora è un nostro bene, è un patrimonio comune ad un'intiera generazione che s'impoverisce». Infine, «essendo generoso lo scopo, ha creduto poterlo ottenere con qualsiasi mezzo. Egli è stato dominato da una sola nobile idea, l'affrancamento del proprio paese ed a questa sacrificò tutte le sue passioni, tutti i suoi talenti, tutto se medesimo (...). In qualunque causa si serva, quand'anche fosse più santa che quella della patria, non si dispone che del tempo che si vive e dei mezzi che si adoperano. Dio si è riservato la cura dell'avvenire e del fine». La Chiesa onora Cavour più di quanto, in cuor loro, facciano molti suoi amici.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 63
A modo suo, Cavour coglie la profondità del sentimento cattolico in Italia quando afferma, nel discorso al Senato del 9 aprile 1861, che «in Italia il partito liberale è più cattolico che in qualunque altro paese d'Europa». Prosegue ironicamente Cavour: «se la corte di Roma accetta le nostre proposte, se si riconcilia coll'Italia, se accoglie il sistema di libertà, fra pochi anni, nel paese legale, i fautori della Chiesa, o meglio, quelli che chiamerò il partito cattolico, avranno il sopravvento, ed io mi rassegno fin d'ora a finire la mia carriera sui banchi dell'opposizione» (ilarità prolungata)»(C. CAVOUR, Discorsi per Roma capitale, introd. di P. Scoppola, Roma 2010, pp. 104-105).
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 108
La divisione [fra Cavour e Garibaldi a Teano] non è soltanto formale, perché a Napoli, dove il Re entra il 7 novembre Garibaldi chiede di essere nominato luogotenente del Regno per un anno e propone che il suo esercito non sia disperso, ma le risposte sono entrambe negative. Il 9 novembre Garibaldi si ritira a Caprera. Le due anime del Risorgimento si dividono di nuovo, quella istituzionale e monarchica prevale per le solide ragioni di Cavour, il quale scrive alla contessa di Circourt il 29 dicembre 1860: «per parte mia, non ho alcuna fiducia nelle dittature e soprattutto nelle dittature civili. Un'esperienza di tredici anni m'ha convinto che un ministero onesto ed energico, che non abbia nulla da temere dalle rivelazioni della tribuna e non si lasci intimidire dalla violenza dei partiti, ha tutto da guadagnare dalle lotte parlamentari. D'altra parte non potrei tradire la mia origine, rinnegare i principi di tutta la mia vita. Se si dovesse riuscire a persuadere gli italiani che hanno bisogno di un dittatore, essi sceglierebbero Garibaldi e non me. Ed avrebbero ragione. La via parlamentare è più lunga, ma è più sicura».
6.3/ Garibaldi
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 83
Garibaldi scrive a Luigi Stefanoni, direttore del «Libero pensiero» nell'agosto 1872, per dirgli che «se l'Italia avesse un governo quale le si conviene, i preti con la vanga in spalla sarebbero occupati alla bonificazione della palude pontina».
Testamento di Giuseppe Garibaldi
Ai miei figli, ai miei amici, ed a quanti dividono le mie opinioni, io lego: l'amore mio per la libertà e per il vero; il mio odio per la menzogna e la tirannide. Siccome negli ultimi momenti della creatura umana, il prete, profittando dello stato spossato in cui si trova il moribondo e della confusione che sovente vi succede, s’inoltra e mettendo in opera ogni turpe stratagemma, propaga con l'impostura in cui è maestro, che il defunto compi, pentendosi delle sue credenze passate, ai doveri di cattolico. In conseguenza io dichiaro, che trovandomi in piena ragione oggi, non voglio accettare in nessun tempo il ministero odioso, disprezzevole e scellerato d'un prete, che considero atroce nemico del genere umano e dell'Italia in particolare. E che solo in istato di pazzia o di ben crassa ignoranza, io credo possa un individuo raccomandarsi ad un discendente di Torquemada.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 37-38
San Gennaro […] è utilizzato dagli inglesi per esaltare Garibaldi e divulgare false notizie. Il giornale inglese Harper's Weekly osanna l'impresa dei mille del 1860, informa che l'eroe dei due mondi ha liberato la città di Napoli dalla «spazzatura» religiosa, gli dedica poesia e vignetta: «il santo e l'eroe - Garibaldi che caccia da Napoli San Gennaro». Garibaldi, invece, entrato a Napoli, si reca in Duomo, canta con il popolo un Te Deum di ringraziamento, visita la cappella di San Gennaro. D'altronde, l'inviato britannico Henry Elliot informa correttamente che Garibaldi si è recato in cattedrale il 19 settembre ed ha presenziato alla liquefazione del sangue di san Gennaro.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 103-105
Nel miscuglio di fattori che contribuisce alla spedizione del 1860 anche la religione svolge un ruolo importante, e contraddittorio. Garibaldi si circonda di sacerdoti e religiosi, che sono attivi tra la popolazione, spesso fanno da cappellani ai combattenti (e ai prigionieri), ed avranno destini diversi: perché c'è chi è ortodosso, chi non regge alle lusinghe della fama, chi abbandona la Chiesa come spesso accade ai preti che si fanno conquistare da ambizioni, lecite ma mondane, che fanno esaurire la loro qualità sacerdotale. All'inizio delle operazioni si uniscono a lui, fra gli altri, l'ex barnabita Alessandro Gavazzi e un prete francescano radicale, fra' Giovanni Pantaleo, e Garibaldi si appella ai «preti buoni» perché aiutino la rivoluzione contro i Borboni, non senza espressioni ruvide nei confronti della Chiesa. E poi partecipa a manifestazioni religiose che gli portano consensi, stabilisce un rapporto proficuo e ambiguo con il clero siciliano, diverso da quello continentale perché risente dei fermenti autonomistici, delle ricorrenti ribellioni degli ultimi decenni, non lesina un certo appoggio alla spedizione di Garibaldi. Il quale nomina l'ecclesiastico Gregorio Ugdulena Ministro dell'Istruzione e del Culto, poi anche professore all'Università. Il 15 luglio 1860 partecipa a Palermo, alla festa di Santa Rosalia, patrona della città, sedendo sul trono più alto della Cattedrale nella Cappella Reale, vestito del suo poncho e con la spada «a significare che anche lui [è] il difensore della fede»; prende parte con Alessandro Dumas, tra i più famosi «garibaldini d'Europa», a Caltanissetta alla processione in onore del patrono Michele. Sul terreno della politica ecclesiastica Garibaldi è prudente, tassa gli enti religiosi, scioglie la Congregazione dei Gesuiti, e quella dei Liguorini, ma tiene buoni rapporti con Benedetto d'Acquisto, arcivescovo di Monreale, e Giovanni Battista Naselli Arcivescovo di Palermo. Nel palazzo comunale di Salemi, il condottiero ha un cattivo inizio e afferma: «so che il clero di Sicilia è con noi, ma il prete di Roma è nostro nemico. (...) C'è differenza tra il dissoluto prete di Roma, che compra mercenari per ispargere il sangue dei suoi concittadini, ed il nobile venerando sacerdote di Sicilia che si getta primo nella mischia, dando la vita al suo paese. È veramente immortale il cristianesimo». Il canonico Gregorio Ugdulena corre ai ripari, spiega le ragioni del sostegno a Garibaldi, ma mette un paletto fermo contro chi attacca la religione della Patria: «questo clero crede di non dipartirsi dallo spirito del Vangelo, propugnando la causa della libertà nazionale, ch'è la causa della umanità e della giustizia, e per conseguenza anche della religione. Fedeli alla religione dei padri nostri, e aborrenti perciò da ogni dottrina venuta di oltremonte a guastar la fede nostra, come da ogni merce straniera con la quale si è voluta adulterare l'antica civiltà italiana, noi sacerdoti di Sicilia non ci partiremo mai da dogmi, dalla disciplina, da' riti cattolici. Noi ci terremo saldi intorno al Capo visibile della nostra Chiesa al quale anco un sentimento di personal devozione ci tiene legati. (...) Noi allora, sacerdoti dell'Iddio delle misericordie e della pace, ci gitteremo nella mischia a moderare il furore della spada, ad impedir le possibili conseguenze di quella lotta. Noi vogliamo che l'Italia sia libera: ma la vogliamo cattolica».
Il richiamo di Ugdulena è accolto solo in parte da Garibaldi perché altri suoi gesti, e scelte, provocano una crisi con gli ambienti ecclesiastici, quando si circonda di elementi del clero non ortodossi, incarica addirittura don Parlo Sardo di dar vita ad «battaglione ecclesiastico», composto di preti e frati, e tiene vicini alcuni pastori protestanti che iniziano un proselitismo che urta le popolazioni. In particolare, il pastore valdese Giorgio Appia è protagonista di un proselitismo anticattolico che provoca fastidio, ottiene qualche successo, ridotto nei numeri ma sufficiente a portare turbamento nella Chiesa. Con il «battaglione ecclesiastico» si vuole giustificare l'uso delle armi da parte del clero, trasformare la rivoluzione in una crociata, e la sua origine sta nel fatto che alcuni ecclesiastici svolgono funzioni militari e di custodia sin dall'inizio della spedizione: Agostino Rotolo difende a Palermo Porta Termini, Paolo Sardo diviene custode del Palazzo di finanza, altri preti combattono sulle barricate di Palermo. Però, il 21 luglio 1860 Paolo Sardo invita il clero «ad armarsi, a spargere il sangue per la libertà», ad «animare con le armi e la voce i combattenti» apponendo sulla loro divisa un crocifisso. Cerca di giustificare l'appello con confuse motivazioni canoniche, perché così si deve fare per «la difesa degli oppressi e della patria nei casi di grandissimo bisogno». Critiche e condanne all'iniziativa giungono da ogni parte, anche liberale e governativa, il battaglione viene composto e imbarcato per il continente, ma sembra non combatta mai veramente e si limiti all'assistenza religiosa delle truppe.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 106
Garibaldi si trova di fronte a situazioni che sfuggono alla logica della sua spedizione, che ha valore politico, ma è interpretata da alcuni in senso sociale. In alcuni casi, si sollevano i contadini ritenendo giunto il momento della rivoluzione contro i proprietari terrieri, da sempre loro sfruttatori, e danno luogo a massacri di latifondisti e notabili. Garibaldi reagisce duramente, e invia Nino Bixio a Bronte che reprime duramente la rivolta con giudizi sommari ed esecuzioni immediate; quasi un'anticipazione delle repressioni «piemontesi» degli anni successivi nei confronti di chi non accetta l'esito politico dell'unificazione o si dedica al brigantaggio.
6.4/ Pio IX
da Pio IX (originale poi modificato, dopo che il generale aveva di sua iniziativa protratto i combattimenti)
Al Generale Kanzler Pro Ministro delle Armi" [Ermanno Kanzler Pro Ministro delle Armi che comandava le truppe pontificie]
Sig. Generale, ora che si va a consumare un gran sacrilegio e la più enorme ingiustizia; e la truppa di un Re Cattolico senza provocazione, anzi senza nemmeno l'apparenza di qualunque motivo cinge di assedio la Capitale dell'Orbe Cattolico, sento in primo luogo il bisogno di ringraziare Lei Sig. Generale, e tutta la truppa nostra della generosa condotta finora tenuta, dell'affezione mostrata alla S. Sede e della volontà di consacrarsi interamente alla difesa di questa S. Sede. Siano queste parole un documento solenne che certifica la disciplina, la lealtà, ed il valore della truppa al servizio di questa S. Sede. In quanto poi alla durata della difesa sono in dovere di ordinare che questa debba unicamente consistere in una protesta atta a constatare la violenza, e nulla più; cioè di pochi colpi da tirarsi contro il nemico. In un momento in cui l'Europa intiera deplora le vittime numerosissime, conseguenza di una guerra fra due grandi Nazioni, non si dica mai che il Vicario di G. C. quantunque ingiustamente assalito, abbia ad acconsentire ad un grande spargimento di sangue. La causa nostra è di Dio, e Noi mettiamo tutta nelle sue mani la nostra difesa. Benedico di cuore Lei Sig. Generale e tutta la nostra truppa. 14 settembre 1870.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 109
Per Giovanni Spadolini «il merito storico di Pio IX, dal punto di vista cattolico, è di aver compreso che la causa del Papato poteva essere salvata soltanto sul piano universalistico, sul piano della fede, e che nessuna combinazione diplomatica sarebbe riuscita a evitare il particolarismo degli Stati, a scongiurare il trionfo delle nazionalità, a prevenire il successivo definirsi e differenziarsi dei blocchi».
6.5/ Fatti
da De Amicis, l’autore del libro Cuore, inviato a Roma per la presa di Porta Pia, il 20 settembre 1870: «I ragazzi sono soldati d'artiglieria grandi e robusti come ciclopi: baciano il piede alla statua di San Pietro. Un pretino par che dica: - Sono cristiani queste bestie feroci! Meno male! Una lunga fila di soldati è inginocchiata intorno all'altar maggiore». Appunti di Andrea Lonardo
Roma, 26 settembre 1870, sei giorni dopo la Breccia di Porta Pia. Edmondo De Amicis, che nel 1886 scriverà Cuore, entrato in Roma al seguito dell’esercito comandato dal generale Cadorna, al fine di redigere un resoconto degli eventi annota:
«Comincio a capire. In mezzo alla chiesa si vede un gruppo di ragazzi intorno a una cosa alta che sembra una statua. Andiamo innanzi, innanzi, innanzi: oh cospetto! I ragazzi sono soldati d'artiglieria grandi e robusti come ciclopi; la cosa alta è la statua di S. Pietro. I soldati le baciano il piede. Un pretino poco distante guarda e sorride con un'aria di sorpresa e di compiacenza. Par che dica: - Sono cristiani queste bestie feroci! Meno male!
Una lunga fila di soldati è inginocchiata intorno all'altar maggiore. Altri, negli angoli lontani, stanno contemplando le statue, e per convincersi che sono di marmo, mettono loro le mani sulle spalle, sulle braccia, sulle ginocchia, come fanno i ciechi per riconoscere. Un gruppo di bersaglieri è estatico davanti a San Longino. Parlano tra loro. Mi avvicino e colgo la sentenza finale d'uno di essi, che mi ha l'aria di un monferrino: - Aj'e nen a dije; a l'è un bel travaj.
Siamo sotto la cupola. Su la testa. Ah! Qui l'effetto è veramente prodigioso! È bello il vedere il mutamento che si fa in tutti i visi appena si voltano in su. Molti, appena guardato, chinano la testa e chiudono gli occhi, come se avessero intravveduto l'abisso. In altri il volto e l'occhio s'illuminano come a una visione di cielo. È una meraviglia che ha dell'estasi. È il solo punto della chiesa in cui collo sguardo si sollevi al cielo il pensiero. Nelle altre parti è magnificenza che seduce e splendore che affascina, non grandezza che ispira. Ci si sente il teatro. Si pensa più alle fatiche e ai milioni che vi si profusero, che a Quegli cui furono dedicati; più ai pittori e agli scultori, che agli angeli e ai santi. L'anima è così tenacemente legata alla terra dalle meraviglie dell'arte, che a sprigionarla e levarla in alto occorre assai maggior forza e più difficile lotta, di quel che a farla uscir vittoriosa dalle tentazioni esterne della vita, contro cui la chiesa dovrebbe servire d'asilo»[37].
Così De Amicis descrive il rapporto che si venne immediatamente a creare fra le nuove autorità ed il clero della capitale, il giorno dopola Brecciadi Porta Pia:
«La mattina dopo il 20, venendo dal Campo Vaccino sul Campidoglio, la prima cosa che vedo, in cima a una delle grandi scale che danno sulla piazza, è un gruppo di bersaglieri e di frati che se la discorrono fraternamente, seduti sugli scalini. I bersaglieri mangiavano. Due o tre frati rivolgevano tra le mani una gamella, guardandola di sopra e di sotto. Altri tenevano in mano un pane di munizione. Altri osservavano con molta curiosità i cappelli piumati appesi al muro. Ci fosse stato un fotografo! Parevano amici vecchi. A un bersagliere che scendeva domandai: - Che cosa dicono i frati? - So' chiù etaliani de noautri - mi rispose ridendo.
La sera, per le strade, se ne videro molti. Ce n'era di tutti i colori: bianchi, neri, bigi, cacao. Alcuni erano accompagnati da soldati. La gente guardava e rideva. Era infatti una mescolanza così nuova e strana che pareva di sognare. E il modo con cui andavano assieme! Come fosse la cosa più naturale del mondo, come fossero stati insieme sempre. Discorrevano di politica»[38].
Egli testimonia che svanì subito la paura che si aveva da parte di preti e frati e, comunque, di cittadini dell’ormai dissolto Stato Pontificio:
«A Monterotondo, discorrendo con un cittadino dei più noti, e in voce di liberale, gli domandammo come fosse contento del nuovo stato di cose.
- Per me sono contentissimo - rispose, e lo diceva sinceramente. - Tutto va bene, non si potrebbe desiderare di meglio. - E poi a bassa voce: - Hanno rispettato le chiese, hanno lasciato stare i preti; messe, vespri, funzioni, ogni cosa come prima.
- Oh curiosa! Ma credeva che si venisse qui a guastare il mestiere ai preti, lei?
- Io? ... Nemmen per sogno.
Certo che lo credeva, e con lui chi sa quanti, che all'entrare dei nostri soldati si saranno chiusi in casa e fatti dar del codino. Ma ora che si son disingannati e rassicurati, non credo che saranno meno sinceramente italiani degli altri.
Non ricordo in che villaggio, una donna del popolo fermò il primo ufficiale che vide, e gli disse con voce affannosa e supplichevole: - È una buona persona il nostro curato, gliel'assicuro; è un galantuomo; non gli dispiace mica che vengano i soldati del Re; non gli facciano nessun male, lo dica ai soldati, ci faccia questa carità ...
Quella donna credeva fermamente che il mandato dell'esercito italiano fosse di far la festa ai preti, come diceva don Abbondio. Ora lamentatevi, se vi pare, ch'essa non abbia messo fuor della finestra la bandiera tricolore.
Passava un drappello di seminaristi per una via di Nepi, poco dopo che v'erano passati i soldati. Un popolano, accennandoli, disse in tono burlesco: - Ora ... Quelli là ... È finita ... - E mi guardava.
- Perché finita? - gli domandai.
- A questi lumi di luna ...
- Ma che lumi di luna! I seminarii e i seminaristi seguiterete ad averli; ce li abbiamo anche noi, e ce li avremo sempre.
Restò sorpreso, e poi domandò: - In Italia? Ce li avete anche voi in Italia?
- Sicuro.
- E passeggiano per le strade?
- Passeggiano per le strade.
- E nessuno gli dice nulla?
- E cosa volete che gli dicano?
C'era da perdere la pazienza; mi ripugnava quasi di credere a tanta ignoranza. Avranno anche dato ad intendere a quella povera gente che gl'italiani distrussero le chiese e innalzarono i templi della dea Ragione?
In una via remota di Roma, poco dopo l'entrata dell'esercito, si vide un vecchietto che, all'aria, doveva aver avuto una tal paura delle cannonate da perdere il lume della ragione. Alla paura delle cannonate gli era poi sottentrata la paura delle dimostrazioni. Passavano alcuni giovani cantando e sventolando bandiere. Non avendo più tempo di fuggire, credette di dover far l'italiano per non essere accoppato. Cominciò collo sforzarsi a sorridere, e poi, raccolto tutto il suo coraggio, gridò con una voce da moribondo: - Accidenti ai preti.
Le bricconate fatte per viltà sono più rivoltanti di quelle fatte di proposito. Uno dei giovani del drappello lesse nel viso al vecchio e gli disse con piglio severo: - Per essere italiano non c'è mica bisogno di dir delle insolenze ai preti, sapete.
Il vecchio rimase attonito.
- Non ce n'è proprio bisogno - soggiunse il giovane allontanandosi e continuando a guardarlo. Il povero italiano fallito non profferì più parola. Anche a lui, certo, era stato dato a credere il viendront-ils degli zuavi.
Un oste, all'apparir dei soldati, s'affrettava a nascondere certi palloncini da luminaria su cui era scritto: W. Pio IX. Un ufficiale lo sorprese, e gli disse:
- Lasciate quella roba dove si trova.
- Ma io ...
- Lasciatela.
- Ma io non son mica per il Papa; io sono per lor signori.
- Ma per essere per noi signori non c'è mica bisogno di rinnegare il Papa.
- Ma questa roba ...
- Ma quella roba vi potrà ancora servire, e tra poco, speriamo, perché le cose s'aggiusteranno.
- Lei dice bene.
- E voi facevate male.
Del resto, i preti mostrarono di non aver le paure che s'adoperavano a mettere negli altri. Mentre nelle vie dei villaggi la buona gente tremava per la loro vita, essi, alla finestra assistevano tranquillamente al passaggio dei reggimenti, e molti non abborrivano dall'onorare d'un cortese saluto gli ufficiali a cavallo.
Un solo frate mostrò d'aver paura dei soldati, e fu vicino a Civita. Veniva innanzi con un somarello verso un battaglione di bersaglieri, pallido e tremante, e giunto a pochi passi dai primi soldati, si fermò e giunse le mani in atto di chieder grazia.
- Fa nen 'l farseur - gli disse un caporale. Gli altri gli domandarono notizie del Santo Padre. Qualcuno gli offrì del pane. Rassicuratosi, pareva matto dalla contentezza.
[…]
«Roma pel nostro esercito e pel nostro popolo sarà una forza.
Non è una forza oggi, né può essere. Per il nostro popolo Roma non è che la città capitale del mondo cattolico; le sue tradizioni son quelle della Chiesa; l'affetto che da lei muove non è che la reverenza religiosa; il suo nome non desta nella moltitudine altro sentimento o ricordo o immagine di grandezza fuori delle pompe splendide e delle cerimonie solenni del culto, delle chiese, dei giubilei, dei concilii, dei santi, dei martiri, dei pontefici antichi, delle cacciate dei barbari, del coronamento degl'imperatori, delle grandi lotte e dei grandi trionfi della religione, di tutte le vicende e di tutte le glorie che la Chiesa diffonde e celebra in ogni parte della terra dal pergamo, nelle scuole, coi libri, colle immagini, colle preghiere, coi mille mezzi che sono in mano sua. L'immagine di Roma per il popolo è avvolta d'un velo bianco, circonfusa del nimbo radiato, cogli sguardi nel cielo e la preghiera sul labbro; è la Roma nuova, la Roma cristiana, la Roma sacerdotale. Ma che è per lui quella antica? La Roma delle mille battaglie e delle mille vittorie, libera, potente e sovrana? La città di Fabrizio, di Bruto, di Paolo Emilio, di Catone, di Pompeo? Tutta la meravigliosa tradizione antica che a noi, benché tanto lontani e tanto dissimili nepoti, accende ancora l'anima d'entusiasmo e d'orgoglio, che cos'è ora per il popolo? Egli la ignora, egli non sa di Roma antica, le sue rovine sono coperte dal velo della religione; il governo del pontefice le lasciò così fredde e mute perché scaldate e interrogate parlerebbero di amor di patria, di gloria guerriera, di virtù cittadina, ed egli vive della negazione di queste tre forze; fra l'Italia nova e quelle rovine stanno diciannove secoli di pertinace lavoro inteso a distruggere lo spirito di libertà e d'indipendenza che ne gittò le fondamenta e le difese e le accrebbe e le fece grandi e temute; la tradizione di Roma antica è soffocata e sepolta.
Ma quando si solleverà il velo della religione, non per squarciarlo, ma per avvicinarlo al cielo, e il sole della libertà batterà su tutto codesto mondo sopito, allora quelle tradizioni si ravviveranno e diventeranno una forza pel popolo italiano. Diventeranno una forza quando su quei colli e tra quelle mura, dove sorse il più grande esercito del mondo ed ebbe il suo più lungo regno la vittoria, pianterà la sua bandiera l'esercito dell'Italia nuova, caldo di quell'amor di patria e di libertà che fece insuperabile l'antico. Diventeranno una forza quelle tradizioni e quelle memorie quando da ogni parte d'Italia si accorrerà tra quelle mura a raccoglierle, a trarne inspirazioni ed auspici, a sentirle più vive e più possenti nella contemplazione delle rovine che ce ne fanno fede.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 119-121
Nel decennio 1860-1870 le divisioni politiche si insinuano anche nel clero e tra i religiosi. La corrente intransigente, e fedele al papato, è largamente maggioritaria e prevale nei Gesuiti, nei Servi di Maria, tra i benedettini di prima osservanza, ma la comprensione verso l'Italia unita si diffonde tra i barnabiti, in parte tra gli scolopi, nascono dissidi anche all'interno dello stesso istituto, o dello stesso convento. Una iniziativa che provoca un certo clamore è quella di Padre Carlo Passaglia il quale nel 1861 raccoglie novemila firme di sacerdoti e religiosi per una petizione al papa perché rinunci al potere temporale. Le firme sembrano tante ma sono poche se si considera il numero di sacerdoti e religiosi, e che dopo la reazione della Chiesa, la maggior parte dei firmatari consente a ritrattare, avendo sottoscritto con sentimenti diversi, non di contrapposizione a Roma. Le manifestazioni di dissenso clericale restano sempre individuali, non esiste mai il rischio che si formi una Chiesa autonoma dalla Santa Sede. Quando i processi storici giungono a maturazione, di fronte a novità istituzionali e politiche definitive, quando insomma il nuovo Regno d'Italia diventa realtà, la Chiesa non si limita alle condanne perché interviene, come sempre nella storia ecclesiastica, il principio di realtà e di legittimità, che stempera e attenua molte cose, permette ai cattolici italiani di restar dentro i processi politici conclusivi del risorgimento. Qui occorre distinguere, perché il papa ribadisce che il nuovo Regno d'Italia ha usurpato i diritti della Chiesa, e adotta la formula di don Giacomo Margotti per la quale i cattolici non devono essere «né eletti né elettori», la traduce nel non expedit alla partecipazione alle elezioni politiche (non alle amministrative), proibisce ai sovrani cattolici di far visita al Re d'Italia per non avallare l'usurpazione nei confronti della Santa Sede. Però, anche ciò che è illegittimo agli occhi della Chiesa, per antica dottrina ecclesiastica, può essere legittimo agli occhi dei sudditi, anche sacerdoti, vescovi o cardinali.
Il principio legittimista è difeso da sempre dal gesuita Luigi Taparelli d'Azeglio, anche per giustificare Napoleone Bonaparte, e Carlo Curci ha buon gioco nel rivendicarlo appieno dopo il 1870 (nel suo Moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia) per dire che dunque il Regno d'Italia è cosa fatta, non è transitorio, sta dando un volto all'Italia e mettendo ordine nella penisola, ed oggi deve essere riconosciuto e obbedito dai suoi sudditi, laici o ecclesiastici che siano. Questa è la parola magica, si deve obbedire al sovrano legittimo (anche se nasce usurpatore), e alle leggi del Regno, lavorare perché l'Italia progredisca non perché si dilaceri, cada in rovina. Tanto questa impostazione è dottrinalmente fondata che la Chiesa la recepisce nei fatti. Protesta, contesta, ma obbedisce alle leggi, anche se ingiuste. Obbedisce alle leggi laiche e a quelle eversive: i cattolici si sposano secondo le norme canoniche, perché il matrimonio è un sacramento, ma la Chiesa consiglia di regolarizzare l'unione in municipio, subito prima o subito dopo la cerimonia religiosa; frati e suore di tutta Italia lasciano i conventi, quando la legge lo impone, e si industriano per rientrarvi ma nel rispetto della legge, sfruttando le sue ambiguità. Con maggiori difficoltà vescovi e clero riconoscono che Vittorio Emanuele II è re d'Italia, in qualche caso lo ossequiano nelle visite ufficiali, qualche cardinale esce sul balcone con lui per avere l'applauso della folla, e il Governo, pur diretto a volte da massoni e anticlericali, è il Governo dell'Italia. Coglie questo aspetto Gaetano Salvemini nel suo saggio postumo su Stato e Chiesa in Italia da Pio IX a Pio XI,quando rileva che in Italia cattolici e liberali coabitano grazie ad una serie di «infinite, piccoli e grandi combinazioni», escogitate ogni volta come un espediente transitorio da tollerarsi in attesa di una soluzione definitiva.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 122-124
In una visione d'insieme il conflitto con la Chiesa è ambiguo, è aspro se visto nella realtà concreta italiana, ma segue linee moderate tutte nostre, che bisogna saper scorgere. In altri termini, è un conflitto atipico, fatto di scontri e collaborazione, condanne e assoluzioni, resistenza e partecipazione. Soprattutto è un conflitto fondato su una moderazione di fondo che distingue l'Italia da altri Paesi che vivono nell'Ottocento rivoluzioni, o stravolgimenti che realizzano guerre tra religione e società che si trascinano fino al Novecento. Un primo punto, spesso ignorato a livello storiografico, riguarda il fatto che mai, nel processo risorgimentale, e nella fase unitaria successiva, ottiene fortuna, né prende corpo normativo, qualche progetto che punti alla reformatio Ecclesiae,cioè ad una riforma delle strutture della Chiesa ad opera dello Stato e delle sue leggi.
L'intento della riforma della Chiesa ab extra è un punto d'onore della rivoluzione francese del 1789-1794, e della Francia separatista del 1905. La prima approva e attua la constitution civile du clergé,con i suoi epigoni persecutori e di eccidi dei c.d. preti refrattari che rifiutano di sottomettersi a tale legge, giurando fedeltà ai suoi principi. Le norme rivoluzionarie delineano una nuova forma democraticista della Chiesa, con elezioni popolari dei vescovi e dei parroci, che devono avvenire su base circoscrizionale e territoriale. La Loi de séparation del 1905 ricalca la prima con l'intento di spezzare la forza strutturale e unitaria della Chiesa, ma entrambi i disegni falliscono. Quello del 1793 naufraga con la fine delle illusioni estremistiche e il Concordato napoleonico del 1801 che riconsegna alla Chiesa la titolarità del diritto di nomina di vescovi e parroci. Quello del 1905 si scontra con la resistenza di Roma e si esaurisce con l'interpretazione che della Loi de séparation danno il Consiglio di Stato e le autorità amministrative. Per il separatismo illuminista la reformatio ecclesiae riflette la volontà dello Stato di separare la Chiesa da Roma, imporre con la forza qualcosa della riforma protestante che non era riuscita a penetrare nei Paesi cattolici, e questo vulnus diviene un incubo per Roma che vede nuovi disegni di sottomissione della Chiesa e del clero alle autorità politiche.
In Italia non troviamo nulla di tutto ciò. Nessuna legge, nessuna disposizione, nessun atto amministrativo, puntano mai a incidere sulla struttura della Chiesa, sulla sua autonomia, e capacità di autogoverno, salvo che per l'approvazione delle nomine dei vescovi nel periodo successivo all'Unità. Ma quest'ultima è questione politica che si risolve presto. Ciò non vuol dire che non esistano, nella nostra classe dirigente liberale, tendenze francesizzanti che si manifestano a livello culturale, e vogliano tradursi a livello normativo. Ce ne sono, ed emergono periodicamente con diverse modulazioni. Però, hanno caratteristiche proprie, sono generiche, senza nerbo e convinzione, limitate ad alcuni aspetti particolari, senza radici in un qualche gallicanesimo, che d'altronde in Italia non è mai esistito. Infine, non raggiungono mai il livello dell'approvazione legislativa, in nessuna questione, maggiore o minore che sia. L'Italia sente il bisogno di una riforma della Chiesa, delle sue strutture, ma è un bisogno che viene da dentro l'anima cattolica, interpretata da quell'Antonio Rosmini che anticipa i tempi rispetto ad una Chiesa lenta a muoversi. Ed è un bisogno che non ha nulla di protestantico, vuole rafforzare la Chiesa e lanciarla sempre più nella sua missione universalistica.
In molti liberali italiani serpeggia un altro elemento, che affiora anche ai giorni nostri, quel rimpianto contraddittorio e generico per il fatto che l'Italia non ha conosciuto la riforma protestante, non ha beneficiario degli effetti modernizzanti che si ritiene ne siano derivati. È un rimpianto contraddittorio perché la Riforma, in Europa, dovunque si è affermata ha provocato la piena subalternità della Chiesa allo Stato, quindi esattamente il contrario di ciò cui (formalmente) aspira il liberalismo. Ed è un rimpianto generico perché formulato in modo astratto, spesso da intellettuali e politici che non solo si guardano bene dal farsi protestanti, ma rimangono fino alla fine tenacemente cattolici, al punto da sfidare ed eludere con tenacia ed ingegnose trovate le censure e le scomuniche ecclesiastiche. Giovanni Spadolini considera questo anelito riformatore inconcludente, perché il Risorgimento non si è «mai posto, in modo unitario e conseguente, il problema di una «rivoluzione religiosa», come complemento ed integrazione della rivoluzione politica, strumento per arrivare alla sintesi del cittadino e del credente, alla unificazione del patriota e del fedele».
E Cavour mise la croce in classe, di Giuseppe Dalla Torre (da Avvenire del 18 giugno 2004)
C'erano simboli religiosi nell'aula della famosa maestrina dalla penna rossa di deamicisiana memoria? Probabilmente sì; o almeno avrebbero dovuto esserci, stando alla normativa allora in vigore.
Pochi sanno, infatti, che il regolamento per l'istruzione elementare del 15 settembre 1860, n. 4336, attuativo di quella famosa legge Casati del 1859 che costituì per un sessantennio la struttura fondamentale del nostro sistema scolastico, prevedeva l'affissione nelle aule scolastiche del crocifisso. La disposizione era destinata a passare sostanzialmente senza soluzioni di continuità nella normativa regolamentare successiva. In particolare, prima di essere ripresa dai provvedimenti dell'età del fascismo (tutti comunque precedenti al Concordato del 1929), essa venne nuovamente ribadita dal regolamento generale dell'istruzione elementare del 6 febbraio 1908, n. 150.
Dunque l'esposizione del crocifisso nelle scuole non è frutto della «riconfessionalizzazione» dello Stato che, secondo un giudizio comune ancorché discutibile, sarebbe stata operata dai Patti lateranensi del 1929 o, più in generale, dal fascismo. Né tale esposizione deve farsi risalire agli ultimi governi liberali quando, per usare un'espressione di Gabriele De Rosa, viene meno l'ideale laicista ed è ormai entrato in crisi lo Stato liberale. Le disposizioni in materia hanno invece origine nell'età risorgimentale ed attraversano tutto il periodo del più duro e dilacerante conflitto fra Stato e Chiesa, quando separatismo e una laicità inclinante al laicismo segnano la politica e la legislazione italiana in materia ecclesiastica.
Qualcuno dirà che dette norme erano pure diretta conseguenza del principio della religione cattolica come religione dello Stato, consacrato nell'art. 1 dello Statuto albertino del 1848. Ma è noto che tale disposizione era stata sostanzialmente abrogata già all'indomani della pubblicazione dello Statuto. Sicché - come poteva scrivere alla fine dell'Ottocento un autorevole giurista, Carlo Calisse - l'art. 1 dello Statuto doveva intendesi solo «nel senso che essa (la religione cattolica: ndr ) è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l'autorità civile quando occorra d'accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose. Di modo che, a così poco ridotto, in nulla il detto articolo contraddice al sistema della separazione fra la Chiesa e lo Stato».
Da parte sua agli inizi del '900 un altro grande giurista, Arturo Carlo Jemolo, in uno studio sulla natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto, concludeva addirittura dicendo che non si trattava di una norma giuridica ma di una mera dichiarazione, senza alcun effetto giuridico pratico.
Le origini storiche di una disposizione che oggi, talora, viene messa in discussione, ci dicono almeno due cose.
La prima è che, come simbolo religioso, il crocifisso è un simbolo passivo, in quanto tale non idoneo né diretto a costringere o ad impedire l'individuo in materia religiosa e di coscienza, né a contravvenire al principio della laicità dello Stato. Il fatto che lo Stato italiano laico e separatista prevedesse come facoltativi i corsi di religione nelle scuole, ma prescrivesse al contempo l'esposizione del crocifisso, ne è una evidente riprova.
La seconda riguarda il crocifisso come simbolo culturale. Non c'è dubbio, infatti, che esso esprima una storia, una tradizione, una cultura; in breve: l'identità degli italiani. Ed anche qui il fatto che lo Stato ne prescrivesse l'esposizione, pure nei periodi in cui la scuola divenne il terreno della più rovente conflittualità tra Stato e Chiesa, tra liberali e movimento cattolico, costituisce un fatto illuminante. Esso prova, infatti, che si tratta (anche) di simbolo culturale; di un simbolo che ha plasmato l'identità italiana e, con altri simboli, ha alimentato gli italiani dei necessari sentimenti di comune appartenenza.
Ed è per questo che anche l'Ottocento liberale, e talora anticlericale, ne ha ritenuto non incompatibile, ma necessaria, la conservazione.
Bibbia all’Opera, qui si canta l’Italia, di Alessandro Beltrami
«Oh mia patria sì bella e perduta! / Oh membranza sì cara e fatal!». I petti si gonfiano, sulla pelle un brivido. E magari scende anche qualche lacrima.
Nonostante la disillusione che caratterizza il nostro tempo e i tentativi, tanto antistorici quanto recidivi, di trasformarlo nell’inno di un’improbabile Padania, il verdiano Va, pensiero (sì, così: senza apostrofo, come scrive nel libretto Temistocle Solera) è il vero solo canto che riesce a risvegliare negli italiani un po’ di amor di patria. Accadde nel 1949 a Napoli quando il 22 dicembre al termine del coro del Nabucco il San Carlo esplose nelle grida «Viva l’ Italia! Viva Trieste italiana» (e Va, pensiero fu l’inno degli esuli istriani, fiumani e dalmati dopo il secondo conflitto mondiale).
È accaduto il 13 marzo scorso quando Riccardo Muti all’Opera di Roma come bis lo fece intonare a tutto il teatro (questa volta contro i tagli alla cultura). Ma a riprova che Va, pensiero, per gli italiani è innanzitutto un mito, un’icona sonora, gran parte del pubblico cantò la prima quartina, bofonchiò qualche parola della seconda, esplose sulla «patria perduta» e si spense su quanto seguiva.
Non c’è dubbio che questo coro infiammi i cuori italiani oggi soprattutto grazie alla musica di Verdi. Ma al suo debutto le parole, che oggi suonano un po’ farraginose nell’italiano aulico della poesia per musica, dovettero essere una miccia davvero efficace.
È noto che a intonare dal 1842, anno della prima, la «patria perduta» è Israele in esilio. «Non è un caso» spiega Giuseppe Langella, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università Cattolica di Milano: «Il tema biblico dell’esilio e delle terra promessa è ricorrente nella produzione culturale dell’Italia risorgimentale. Avviene anzi una vera e propria identificazione dell’oppressione dell’Italia con quella subita da Israele. Diviene una sorta di archetipo, adottato in tutte le arti».
Ma è proprio la potenza e la diffusione del melodramma ad averne garantito una penetrazione culturale in ogni strato della società. Queste radici bibliche si sono però in parte offuscate. Alla loro riscoperta è dedicato oggi e domani “Sull’ali dorate. Ispirazione biblica nel melodramma italiano del primo Risorgimento”, convegno presso il Conservatorio di Milano organizzato da Biblia, a cui partecipano storici (come lo stesso Langella e Francesca Sofia) musicologi (Philipp Gossett e Claudio Toscani) biblisti (Piero Stefani e Daniele Garrone).
«La materia biblica come paradigma della situazione politica dell’Italia risorgimentale, evidente ad esempio in autori come Manzoni, era propria anche di chi non faceva parte dello schieramento cattolico – prosegue Langella –. Certo per tratteggiare la figura dell’esule vengono presi a prestito anche modelli classici, ma la storia biblica è vincente. Gli artisti romantici, che ambivano a comporre i loro lavori per educare il popolo all’amor di patria e alla libertà, sapevano che la Bibbia era l’immaginario collettivo delle nostre genti cristiane».
Nonostante la forte pressione politica applicata alle sue pagine, la storia biblica non subisce una sorta di processo di secolarizzazione. «In un certo senso, è stata la sua ricezione a caricare Nabucco e in particolare il Va, pensiero di valenze patriottiche – dice Piero Stefani, della Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale –. C’è in realtà una preoccupazione, anche se romanzata, a rendere esplicita la prerogativa del vero Dio, quello d’Israele, di guidare la storia. La dimensione religiosa è invece molto evidente ad esempio nel Mosè di Rossini, una sorta di oratorio in versione scenica».
Un’attenzione costante quindi al contenuto più autentico della fonte, c’è. Anche se il risultato è un po’ pasticciato, spiega Stefani: «Il fatto è la Bibbia è sempre una fonte indiretta, mediata da altri drammi. Nonostante questo ci sono tentativi di inserire sottotesti biblici. Ad esempio, ogni atto del Nabucco si apre con una citazione di Geremia, dalla versione italiana di Diodati. Solo che due di loro sono sbagliate… Ma c’è Geremia ad esempio nel rimprovero che Zaccaria fa al popolo ebraico proprio dopo il Va, pensiero. Popolo ebraico che, si badi, è sempre considerato come entità uniforme e monolitica, eredità di un pregiudizio antico. E nel Nabucco infatti in esilio in Babilonia ci va tutto il popolo. Mentre nella Bibbia la separazione è solo di una sua parte. Fatto che determina una visione dinamica interna a Israele, del tutto assente nell’opera».
Tra i motivi c’è il fatto che all’epoca era conosciuta la storia sacra ma non il testo biblico. «Analizzato in senso stretto, in realtà lo stesso apparentamento tra la “patria perduta” di ebrei e italiani è solo una suggestione». Però davvero efficace.
La Chiesa ed i simboli religiosi nella raffigurazione del Risorgimento

Gerolamo Induno, La partenza dei coscritti del 1866, 1878

Filippo Liardo, Sepoltura garibaldina, 1862-1864

Francesco Hayez, La meditazione, 1851

Andrea Appiani Jr., Venezia che spera, 1861
7/ Il tempo che verrà
7.1/ Il re (lo Stato) e il papa: un nodo che si deve sciogliere e non tagliare
da C. Cardia, Prefazione
Si può utilmente tornare a riflettere sulla «questione romana». Se è indiscusso l'approdo di Roma capitale, su un punto però il papa ha ragione ad insistere, a non accettare il fatto compiuto, perché una sovranità vera, sia pure lillipuziana, è necessaria alla libertà sua e della Chiesa per svolgere la propria missione universale. Il papa non è un vescovo qualsiasi, cui spettino alcune guarentigie pur speciali, ma il capo di una Chiesa ramificata in tutti i popoli, che parla e agisce in modo universale.
Sfugge ai liberali che non c'è simmetria tra il papa e il re, l'uno governa spiritualmente il mondo, l'altro regna su uno Stato. E sfugge al papa che l'universalismo della Chiesa non si identifica con il principato avuto in consegna dalla storia, perché questo può rimpicciolirsi facendo ingigantire la sua figura.
I liberali quasi temono che la Santa Sede svolga un vero ruolo internazionale, pensano che il Vaticano possa offuscare il Quirinale, vogliono declassare l’uno perché risalti l’altro. Invece è il contrario, il Vaticano aggiunge luce al Quirinale, lo illumina della sua universalità, il Quirinale assicura al Vaticano una amicizia che lo garantisce agli occhi del mondo. Lo si comprende quando i grandi pontefici del secolo XX agiscono a livello planetario, in amicizia con l’Italia democratica, e Roma diviene il crocevia di una storia politica, diplomatica, spirituale, unica nel suo genere.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 115-116
Accade così qualcosa di non prevedibile, perché proprio nel momento in cui «il papato sembra raggiungere il punto più basso dell'epoca moderna», la Chiesa opera con il Vaticano I la svolta verso l'esaltazione definitiva del primato, con il corollario dell'infallibilità del papa in materia di fede e di costumi. E proprio lo Stato liberale le dà una mano, perché provocando la caduta del potere economico e temporale della Chiesa, pone le basi per il trionfo della Santa Sede sulle chiese nazionali. Lo Stato separatista emargina il cattolicesimo dalla sfera pubblica e lo riconduce all'eguaglianza con altre confessioni religiose: ma questa nuova situazione ha come effetto eccentrico di privare gli episcopati nazionali di ogni scudo politico da utilizzare, di quella protezione statale che dava loro forza verso Roma. I vescovi tornano ad essere fedeli a Roma, non solo perché lo Stato li ignora e ne diffida, ma perché lo Stato non ha più i poteri del passato (exequatur, diritto di presentazione, o nomina, diritto di controllo, ecc.) e l'unico punto di riferimento per i fedeli, il clero, il cattolicesimo, resta il papa. Per paradosso, lo Stato liberale e separatista non ha più mezzi per sostenere l'autonomismo episcopale, gallicano, febvroniano, o d'altro genere.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 26-27
Gli artefici del risorgimento non intuiscono che c'è asimmetria tra il re e il papa, vogliono esaltare il primo ridimensionando il secondo, intendono costruire una grande Roma italiana che ospiti in Vaticano un piccolo papa, come uno dei tanti vescovi, cattolici o protestanti, sudditi dello stato di appartenenza. Sognano che l'Italia «si spapizzi» secondo l'espressione di Luigi Settembrini, perché «Roma, la nemica Roma, l'antica cagione di tutti i mali d'Italia, non istà sul Tevere, ma qui nelle nostre coscienze, e qui dobbiamo combatterla. Ogni prete val mille stranieri (...); l'Italia nuova e cattolicesimo vecchio non possono stare insieme; noi abbiamo fatto il papato, noi dobbiamo trasformarlo; e se l'Italia non si spapa e non si trasforma in religione, ella non ha ragion d'essere». L'universalità della Chiesa sembra antitetica alla sovranità italiana, quasi che una Chiesa universale rimpicciolisca l'Italia, e per evitarlo alcuni liberali sono disposti a tutto, anche far sorgere qua e là chiese e istituti protestanti, convinti che un'Italia un po' protestantizzata ridurrebbe immagine e influenza del papato. Commettono così l'errore più grande, non valutano che l'universalità cattolica è nell'intimo dell'identità degli italiani. I quali sono cresciuti per secoli respirando la classicità, poi vivendo l'universalismo religioso che ha esteso ulteriormente i confini spirituali di Roma. Se si possiede un bene universale non lo si cambia con uno particolare. Combattere l'universalismo cattolico vuol dire impoverire l'Italia, fame una nazione piccola, privarla dell'eredità maggiore che la storia le ha consegnato. D'altronde, i papi identificano a lungo l'universalità del proprio ruolo con il potere temporale, con quel principato che per secoli ha guidato l'Europa, avvertono il Regno d'Italia come nemico. Due visioni opposte che non riescono a inventarsi un futuro nuovo perché ferme nella difesa dell'esistente. Di qui un'altra contraddizione del risorgimento, quando appena conseguita l'Unità si dice che occorre fare la nazione, e fare gli italiani, e si incorre nell'errore di credere che «la nazione non è una realtà già costituita, ma un'idea da attuare; non è in una comunità effettivamente vivente, ma in una umanità investita di un compito messianico. La nazionalità, finisce, così, per identificarsi radicalmente con un'ideologia. Quella, appunto, che raccoglie l'eredità del giacobinismo, attua una sorta di mutazione antropologica, si afferma in forza di un'idea di futuro e si dispone a realizzarlo». L'Italia è già nazione, occorre darle uno Stato.
da Risorgimento, Unità d’Italia, Chiesa cattolica, di Carlo Cardia (su www.gliscritti.it )
Il papa non è assimilabile né al principe di Monaco né ai capitani di San Marino, la sua capacità d’influenza è asimmetrica rispetto a quella di qualsiasi principe territoriale, quindi anche a quella del Re d’Italia. La sovranità del Papa non dipende dalla consistenza territoriale, ha respiro universale, quella di uno Stato ha forza territoriale, ma non supera i propri confini.
L’Italia lo sa, elabora su questa asimmetria una paura che condiziona le sue scelte, la paura che il papa offuschi il Re, la Santa Sede oscuri il governo italiano, in Roma possano trovarsi affiancate due sovranità diseguali.
Con piena lucidità, Crispi lo dice in Parlamento nel 1864: “la Chiesa Romana è cattolica, cioè universale. Questa condizione, che è una forza per lei, è un danno per noi. Essa per la sua indole universale bisogna che viva da sé, che non si assoggetti ad alcuna potestà temporale (…). Il Pontefice romano, qual è oggi costituito, non può divenire cittadino di un grande Stato, discendendo dal trono su cui lo venera tutta la cattolicità. Bisogna che sia principe e signore a casa sua, a nessuno secondo. D’altra parte il Re d’Italia non può sedere accanto a un monarca a lui superiore”. Impossibile dire meglio.
La Legge delle Guarentigie è sapiente, e raffinata, anticipa il futuro perché inventa una sorta di mezza sovranità (personale) per il papa, di sospensione della sovranità italiana sui palazzi vaticani. Ma presenta un limite: quello di negare al pontefice e alla Santa Sede la soggettività internazionale che ha sempre avuto. Il papa può essere vescovo, capo della cattolicità, ma nelle sedi internazionali non deve aver voce, non può parlare neanche nelle conferenze sulla pace, non è competente in nessuna materia che interessi i rapporti tra gli Stati.
Viene dimidiata la funzione del papa, il quale è ridotto alla gestione della “sua” Chiesa, fingendo di non sapere che nella sua missione rientra proprio il poter parlare al mondo. Non solo, ma il papa diviene con la Legge delle Guarentigie un suddito, pur privilegiatissimo, dello Stato italiano. Quando Giosuè Carducci declama: “cittadino Mastai, bevi un bicchiere” non ricorre ad una metafora letteraria, si fonda su una verità giuridica. Nasce, così, l’ossimoro di un Papa che è suddito, diventa possibile giuridicamente ciò che è impossibile concepire sul piano concettuale e storico. [...]
Ma l’Italia insiste nel volere negare al papa il riconoscimento pieno della sua dimensione universale e internazionale. Si oppone infatti nel 1872 alla partecipazione della Santa Sede alla Conferenza di Parigi (la c.d. conferenza del metro), perché, afferma il ministro degli esteri Visconti Venosta, “il governo del Re non può esporsi a dover firmare accordi con un suddito proprio, il quale stipulerebbe a nome di un’autorità che non ha ai nostri occhi, né a quelli delle Potenze che ci vogliono essere amiche alcuna esistenza di diritto né di fatto in materie non ecclesiastiche”.
L’Italia ancora si oppone alla partecipazione della Santa Sede alla prima conferenza dell’Aja sulla limitazione degli armamenti del 1899, e a quella successiva del 1907. E soprattutto, il governo Salandra, stipulando il 26 aprile 1915 il trattato segreto di alleanza con Gran Bretagna, Russia e Francia, fa includere all’art. 15 una clausola in base alla quale le potenze dell’Intesa si impegnano “ad appoggiare l’Italia in quanto essa non permetta che rappresentanti della Santa Sede intraprendano un’azione diplomatica riguardo alla conclusione della pace e al regolamento delle questioni connesse con la guerra”.
Questi i termini della questione, irrisolti a lungo dopo il 1870, questo il corto circuito tra Italia e Santa Sede. La Santa Sede continua a pensare al vecchio principato, l’Italia diviene gelosa del papa, ha paura che il Vaticano conti più del Quirinale. Gli storici parlano del vago timore di Vittorio Emanuele II verso Pio IX, il quale confida alla regina d’Olanda nel 1872: “vorrei proprio che il papa lasciasse Roma, perché non posso guardare dalle finestre del Quirinale senza vedere dinanzi a me il Vaticano, e mi sembra che Pio IX ed io siamo due prigionieri”.
Essi sono prigionieri inconsapevoli della cultura nazionalista. Il nostro Re si sente piccolo di fronte al nostro papa che governa spiritualmente molti popoli. Pio IX si sente prigioniero perché Vittorio Emanuele ha uno Stato e lui no. Per questa ragione in tutta Europa si parla della possibilità che il papa lasci l’Italia; Pio IX chiede un giorno il parere ai suoi cardinali sulla praticabilità di una sua allocazione all’estero, alcune potenze europee assicurano a Pio IX il loro appoggio, e la disponibilità ad accoglierlo. In realtà il papa non crede a questa ipotesi, e (sia detto con tutto il rispetto) nessuno vuole davvero il papa in casa propria. [...] In realtà il papa non ci pensa per niente a lasciare Roma, e nessuno lo vuole veramente perché la sua presenza è impegnativa per chi non vi è abituato, e soprattutto perché tutti intuiscono che l’allontanamento dall’Italia sarebbe una scelta contro natura, violerebbe quel rapporto di simbiosi che si è costruito tra il papa e Roma, il papato e l’Italia in quasi due millenni. [...]
Un papa suddito è un ossimoro concettualmente incomprensibile, storicamente inaccettabile, e Pio IX resiste fino alla fine a questa soluzione rivendicando l’universalità del papato.
Ed è ancora una volta Giovanni Spadolini a cogliere ciò che altri non hanno visto quando afferma che “il merito storico di Pio IX, dal punto di vista cattolico, è di aver compreso che la causa del papato poteva essere salvata soltanto sul piano universalistico, sul piano della fede, e che nessuna combinazione diplomatica sarebbe riuscita a evitare il particolarismo degli Stati, a scongiurare il trionfo delle nazionalità, a prevenire il successivo definirsi e differenziarsi dei blocchi”.
Se dunque Vittorio Emanuele II aveva avuto ragione, in Piemonte, a dire no al papa su questioni di politica interna, Pio IX ha ragione a resistere nella difesa dell’universalità del papato e della Chiesa, e la storia ha confermato che la sua resistenza era fondata e non è stata inutile.
È la storia infatti che con il tempo dirada le paure dell’una e dell’altra parte. Quando le ideologie nazionaliste declinano, quando la storia dall’Europa si allarga ad altre parti del mondo, tende ad essere universale, anche nelle sofferenze delle guerre e nelle tragedie dei totalitarismi, si sente il bisogno di nuove regole e istituzioni internazionali, di autorità morali più alte che parlino a tutti gli Stati e a tutti i popoli.
È allora che il papato senza potere temporale sembra spiccare il volo, il suo ruolo universale si rinnova. Si allargano i confini della Chiesa tra i popoli, con le missioni, le attività benefiche, le rappresentanze diplomatiche. Si estende la voce del papa oltre ogni frontiera, tutti vogliono ascoltarlo, molti ne traggono conforto.
Il primo conflitto mondiale, con le sue tragedie e con la prima crisi delle ideologie nazionaliste vede Benedetto XV al centro dello scenario internazionale, non perché i belligeranti seguano i suoi consigli, ma perché è ascoltato, riconosciuto come autorità morale, e l’attività internazionale del papa, svincolata com’è da un potere temporale vero, appare nei suoi contorni morali, sociali, umanitari.
L’Italia se ne accorge, e già nel 1919 con Vittorio Emanuele Orlando è pronta a parlare di Conciliazione. L’Italia ha capito che il papa non può essere suddito a nessuno, e che il papato universale può essere un bene prezioso per l’Italia come lo era stato per secoli per gli italiani. [...]
Nell’amicizia tra Vaticano e Italia, Roma diviene il crocevia di una storia politica, diplomatica, spirituale, unica nel suo genere. Sta qui la ragione della nascita di quello “Stato bomboniera”, come amo definirlo, lo Stato Città del Vaticano che ha le fattezze formali di uno Stato ma ha la sostanza di un mezzo per consentire, e agevolare, lo svolgimento della funzione universale della Chiesa e della Santa Sede: esso vede la luce nel 1929 e trova subito tanto consenso a livello internazionale, ed a livello interno, fino alla ricezione dello spirito dei Patti del 1929, del Trattato del Laterano in particolare, da parte dell’Italia costituzionale e repubblicana.
Per le ragioni che ho detto, penso che oggi i giudizi sul Risorgimento possono essere più veri e completi, sia in termini specifici per ciò che riguarda il rapporto con la religione e la Chiesa cattolica, sia in termini generali con riferimento alla nascita di un’Italia indipendente e fondata sui diritti di libertà fondamentali. In termini specifici voglio ricordare Giovanni Spadolini che in più occasioni ha visto nel rapporto tra liberalesimo e cattolicesimo una preziosità incancellabile del processo che ha portato all’Unità d’Italia, e che anche nel conflitto con la Chiesa ha voluto intravedere un elemento di fecondità della nascente democrazia italiana, che è giunto a maturità in sintonia con lo sviluppo delle potenzialità democratiche e sociali dell’Italia del Novecento.
Il Risorgimento non soltanto non ha spezzato la nostra storia, negando valore al passato, ma ha portato a compimento il nostro cammino secolare armonizzando fede religiosa e libertà moderne, cattolicesimo e sentimento nazionale unitario, dotando così l’Italia di un amalgama sconosciuto ad altri Paesi europei. Molti liberali dell’Ottocento si stupirebbero nel vedere la Chiesa cattolica del Novecento sostenitrice dei diritti umani in tutto il mondo, eppure ciò è stato possibile proprio perché il patrimonio storico della Chiesa non poteva non andare in direzione della difesa della persona umana e delle sue libertà fondamentali.
In termini più generali, resto convinto che rimane insuperato il giudizio sul Risorgimento di Croce del 1932, per il quale “se per storia politica si potesse parlare di capolavori come di opere d’arte, il processo d’indipendenza, libertà, unità d’Italia, meriterebbe di essere detto il capolavoro dei movimenti liberal-nazionali del secolo XIX: tanto ammirevole in esso la contemperanza dei vari elementi, il rispetto dell’antico e l’innovare profondo, la prudenza sagace degli uomini di stato e l’impeto dei rivoluzionari e dei volontari, l’ardimento e la moderazione”.
Oggi possiamo esprimere un giudizio da trasmettere ai giovani, per cui nel Risorgimento riscopriamo anche le nostre virtù, l’inclinazione ad essere moderati, a rifiutare la violenza sistematica, a farci carico delle ragioni degli altri, a vincere democraticamente ma senza dominare, virtù che ci distinguono da popoli e Stati che hanno realizzato magari grandi rivoluzioni ma portano il peso di una violenza e aggressività che hanno fatto la storia al negativo.
7.2/ Il futuro della democrazia italiana
da Le origini della democrazia di massa in Italia e il ruolo dei cattolici, di Stefano De Luca (www.gliscritti.it )
Va sottolineato come i popolari fossero gli unici, nel periodo 1919-21, ad avere un seguito di massa e, al tempo stesso, se non una compiuta cultura politico-istituzionale della democrazia (su questo terreno molte erano ancora le carenze, tra i conservatori, i clerico-moderati e i ‘giacobini bianchi’ alla Miglioli), certamente una cultura antropologica i cui valori (rifiuto della violenza, attitudine al dialogo e alla mediazione) erano compatibili con le regole della democrazia.
I social-comunisti avevano (e i fascisti avrebbero avuto) un seguito di massa, ma certamente la loro cultura era incompatibile con la democrazia liberale; quanto al mondo liberal-democratico, aveva la cultura politica appropriata, ma era sprovvisto di seguito popolare.
8/ Il dramma delle ricostruzioni degli storici italiani e, quindi, dei libri di testo utilizzati nella scuola italiana è il provincialismo. Abituarsi ad una lettura non moralistica della storia, abituarsi alla sussidiarietà come chiave per capire la democrazia
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 160-161
Più imponente l’esaltazione topografica dei protagonisti del risorgimento, Vittorio Emanuele (cui è dedicato nel 1911 il Vittoriano di Piazza Venezia a Roma), Cavour e soprattutto Giuseppe Garibaldi, cui vengono intitolate vie e piazze in ogni città, e per i quali sono te statue un po' dovunque. La figura di Garibaldi diviene oggetto di un vero culto della persona, e Crispi ne esalta l'immagine di eroe semi-dio parlando a Bologna nel 1884: «nella vita di quest'uomo pareva che ci fosse del divino. L'Ercole e l'Achille degli antichi non valevano lui. Se fosse nato in Atene o in Roma, gli avrebbero alzato altari. (...) Da' suoi prodigi le immaginazioni restano colpite, e le popolazioni vedono in quella creatura un essere sovrumano».
Sono esaltate le reliquie del risorgimento, anche con le esposizioni nazionali. Nell'Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884, ideata per esporre i progressi scientifici e industriali del paese, diverse sale sono dedicate al risorgimento. Insieme a documenti, bandiere e manifesti, si espongono reliquie come le calze indossate da Garibaldi ad Aspromonte, il collare del cane di Gioberti, un cappello di Cattaneo, un fazzoletto di Cavour, la chitarra di Mazzini, una ciocca di capelli di Mameli, la mano imbalsamata di Colomba Antonietti, uccisa da una palla di cannone a Roma nel 1849. Si torna ad usare una terminologia religiosa, quando Giovanni Pascoli il 9 gennaio 1911 commemora l'anniversario della morte di Vittorio Emanuele II proponendolo come «l'anno santo della Patria. Santo, io ripeto. Quello che noi facciamo e il popolo italiano fa, non è una festa e una commemorazione civile, ma è una cerimonia religiosa. Noi celebriamo un rito della religione della Patria, che ispirò il pensiero di Mazzini, affocò l'energia di Cavour, che fece innalzar il tricolore a Carlo Alberto, che fece gittare il grido unitario a Garibaldi, che fece snudare la spada a Vittorio Emanuele».
da una nota di Andrea Lonardo (www.gliscritti.it)
Ogni mese si pubblica un libro di qualche storico italiano che analizza minuziosamente il caso di qualche eretico condannato come protestante. Gli estensori di libri di testo scolastici ne deducono che la Chiesa cattolica ha usato la violenza per imporre il suo punto di vista, mentre nei paesi protestanti regnava finalmente la libertà.
Perché non inserire, invece, gli eventi nel loro contesto europeo? Nell’Inghilterra elisabettiana si veniva decapitati per aver ospitato in casa un prete cattolico. Non solo avveniva la decapitazione del prete e di chi lo aveva ospitato al Tyburn, dove sorge ora Marble Arch, ma i loro corpi venivano squartati e smembrati in quattro parti perché i quattro brandelli venissero inviati come monito ai quattro capi della città.
Nella prima metà del ‘600, durante la “dittatura” di Cromwell (che si dichiarava paladino della democrazia ed ostile alla monarchia), oltre a continuare le esecuzioni capitali dei cattolici (e degli anglicani contrari al puritanesimo) vennero non solo chiusi, ma addirittura distrutti tutti i teatri (compresi il Globe ed il Rose), perché tragedie e commedie erano opera del diavolo. Tutto questo mentre il teatro barocco fioriva in Italia.
Nei “laicissimi” Paesi Bassi a cattolici come il grandissimo pittore Vermeer era proibito partecipare pubblicamente alla messa, perché essa poteva essere celebrata solo in case private, senza che alcun segno esteriore indicasse la presenza di una chiesa. Negli stessi anni l’ebreo Spinoza veniva scomunicato dalla sinagoga di Amsterdam: il consiglio dei rabbini vietò con decreto religioso agli appartenenti alla comunità giudaica di rivolgergli la parola e di leggere i suoi libri.
L’ultimo martire cattolico inglese è del 1681, ma solo nel 1830 avverrà l’ “emancipazione dei cattolici”, cioè sarà reso libero il culto cattolico, e solo nel 1846 ci sarà nuovamente un vescovo cattolico residente.
Sono provinciali gli storici ed i loro libri di testo che non rendono il lettore edotto di queste contemporaneità. Solo vedendo in parallelo Galilei, Vermeer e Spinoza, così come le nuove leggi di Carlo Alberto sui culti protestanti e la Legge sull’Emancipazione dei cattolici in Inghilterra si comprende cosa fosse tipico di un’epoca e cosa fosse invece peculiare delle diverse confessioni.
In Svezia sarà solo nel 1951 che diverrà possibile celebrare la messa cattolica in un pubblico luogo e non solo in un’ambasciata straniera.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 142-143
C'è un susseguirsi di fatti che mostrano i due volti dell'Italia unita, il volto del pluralismo religioso che porta a Roma la libertà per tutti i culti, fa erigere la grande sinagoga ebraica tra il 1901 e il 1904, la Chiesa valdese a Piazza Cavour tra il 1910 e il 1914. Altre scelte sono comprensibili, ad es. l’inaugurazione del monumento a Giordano Bruno in Campo de' Fiori il 9 giugno 1889, l'introduzione nel 1895 del 20 settembre come festa nazionale, l'inaugurazione del monumento a Garibaldi che dal Gianicolo sembra guardare Roma con occhio dominatore: visti nell'insieme tradiscono una volontà polemica insopprimibile. Ma l'altra faccia della medaglia è greve, si collega ad un anticlericalismo che ha molti volti. Il 13 luglio 1881 viene traslata la salma di Pio IX dal Vaticano alla Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, e durante il corteo un gruppo di anticlericali cerca di buttare il feretro nel Tevere, mentre altri vilipendono immagini religiose in modo osceno. Il garibaldino Alberto Mario commenta sul giornale La lega della Democrazia che mentre la salma del Papa era deposta nel sepolcro tra i fischi e le baionette, il suo cuore «faceva eco a quei fischi. Pio IX era uno stupido. Egli personificava la Chiesa cattolica ormai ridotta ad una mostruosa sciocchezza. Applaudiamo a quei fischi, ma noi avremmo applaudito ancor più se le reliquie del grande sciocco fossero state gettate dal ponte Sant'Angelo nel Tevere». Di qui, la sequenza di un'Italia anticlericale, di cui i padri risorgimentali si sarebbero vergognati, per la pesantezza del linguaggio, per la volgarità che offende i valori comuni che tutti dovrebbero salvaguardare. Nascono Circoli anticlericali nelle principali città, si aprono riviste come L’Anticristo, Satana, L'Ateo, Il Lucifero, I discepoli di Satana.Giosuè Carducci sembra dare nobiltà letteraria all'anti-religione con il suo Inno a Satana del 1892, nel quale contrappone tutto ciò che è religione a ciò che è scienza, libertà e arbitrio individuale, onnipotenza della persona; in realtà conferma quell'intenzione sottile dell'Italia di fine Ottocento che vorrebbe liberarsi della Chiesa, del clero, del papa. Per Federico Chabod «quel che s'era fatto sino ad allora, non bastava; l'abbattimento del potere temporale non era fine a sé stesso, ma semplicemente mezzo: come per il Ricasoli, anche se con intenzioni del tutto opposte, il Regno d'Italia non doveva «stare a vedere», ma operare sulla Chiesa. Operare, questa volta in senso distruttivo: l'Italia nuova e il cattolicesimo vecchio non potevano più stare insieme; l'Italia, creatrice del papato, doveva distruggere il Papato, doveva spaparsi».
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 156
Gli anglicani sono inviperiti perché i cattolici in Inghilterra, dopo la liberalizzazione del 1829, si organizzano e Pio IX ristabilisce la gerarchia episcopale con un atto definito Papal Aggression,mentre figure importanti come il cardinal John Henry Newman e il primate Nicholas Patrick Wiseman danno nuovo lustro al cattolicesimo inglese e alla sua cultura. D'altronde in Irlanda si combatte da sempre contro l'Inghilterra, e Londra che vuole l'indipendenza per l'Italia la nega agli irlandesi, anzi li perseguita come patrioti e come cattolici, li aiuta poco anche nella terribile carestia degli anni '50 che falcidia la popolazione.
da C. Cardia, Risorgimento e religione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 157-158
Si aprono chiese e scuola protestanti in varie città, in Roma è eretto il tempio anglicano in Via Nazionale, con una singolarità: nel mosaico del pittore Edward Burne-Jones, S. Andrea è raffigurato con il volto di Abramo Lincoln, S. Giacomo con il volto di Giuseppe Garibaldi, S. Patrizio con il volto del generale Ulysses Grant, comandante delle truppe nordista nella guerra di secessione americana. Ma l'attività missionaria trova un muro quando si accosta al popolo, al tessuto sociale cattolico più fitto, alla stessa Italia liberale, perché i protestanti prendono atto di una realtà a loro sconosciuta: gli italiani sono rimasti cattolici, o sono diventati laici (liberali, massoni, anticlericali, non importa), ma in entrambi i casi non vogliono sentir parlare di religione protestante: i cattolici perché la considerano eretica, gli altri perché a solo sentir parlare di religione vedono rosso.
Note
[1] Per evitare di essere sommersi dai neri e dal paganesimo, i coloni «dovevano necessariamente armarsi, proteggersi contro questa minaccia sempre crescente e quale mezzo migliore avevano di ricoprirsi di un'armatura impenetrabile - l'armatura della purezza razziale e della conservazione». Quindi, l’apartheid va considerata come «una missione di ispirazione divina e come un privilegio: convertire i pagani al cristianesimo senza cancellare le loro caratteristiche nazionali» (dalla Lettera del Primo Ministro dell'Unione Sudafricana, dr. Malan, inviata il 12 febbraio 1954, al rev. J. Piersma (doc. ONU n. 9, Assemblea Generale 1955).



