La solitudine di Rousseau e la nostra responsabilità, di Fabrice Hadjadj
- Tag usati: fabrice_hadjadj, jean_jacques_rousseau
- Segnala questo articolo:
Riprendiamo da Avvenire del 19/6/2016 un articolo di Fabrice Hadjadj. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per altri articoli di Fabrice Hadjadj, cliccare sul tag fabrice_hadjadj. Per approfondimenti, cfr. la sezione Storia e filosofia.
Il Centro culturale Gli scritti (26/6/2016)
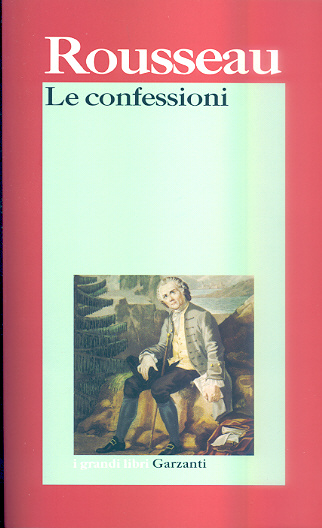
Nel 1749, Jean-Jacques Rousseau si reca a far visita a Diderot che è in prigione, e là, sulla via di Vincennes, ha la grande illuminazione dalla quale nasceranno le sue opere politiche. La causa scatenante è l’ultimo numero del Mercure de France.
Camminando, lo sfoglia fino alla pagina in cui si trova il quesito messo a concorso dall’accademia di Digione: «Il ristabilimento delle scienze e delle arti ha contribuito a purificare o a corrompere i costumi?», ed eccolo rapito in una specie di estasi. «Vidi un altro mondo», dirà nelle sue Confessioni.
Ma la cosa migliore è citare la sua seconda lettera a Malesherbes, dove questa esperienza quasi mistica è raccontata in modo dettagliatissimo: «Se mai c’è stato qualcosa di simile a un’ispirazione improvvisa, è il movimento che si fece in me a questa lettura; improvvisamente mi sento lo spirito abbagliato da mille luci; una folla di idee vive che si presentano tutte insieme con una forza e una confusione tali da gettarmi in un’agitazione inesprimibile; sento la mia testa presa da uno stordimento simile all’ebbrezza. Una violenta palpitazione mi opprime, solleva il mio petto; non riuscendo più a respirare camminando, mi lascio cadere sotto uno degli alberi del viale e trascorro mezz’ora in una tale agitazione che, rialzandomi, vedo la parte anteriore della mia giacca bagnata di lacrime, senza essermi accorto che ne stavo versando. Oh, monsignore, se solo avessi potuto scrivere la quarta parte di ciò che ho veduto e sentito sotto quell’albero, con quale chiarezza avrei mostrato tutte le contraddizioni del sistema sociale; con quale forza avrei esposto tutti gli abusi delle nostre istituzioni; con quale semplicità avrei dimostrato che l’uomo è naturalmente buono, e che sono le sole istituzioni che rendono gli uomini cattivi».
Leggendo questo racconto, non si può non fare il confronto della via di Vincennes con la via di Damasco. Rousseau dà del resto tre versioni della sua avventura - nella Lettera suddetta, nelle Confessioni e nei Dialoghi - e ciò corrisponde esattamente al numero di volte che la conversione di Paolo è descritta negli Atti degli Apostoli.
Nella seconda descrizione - la prima in un discorso diretto - l’apostolo racconta: «Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una gran luce dal cielo rifulse attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 22, 6-7). Numerosi sono i tratti in comune: l’arresto improvviso in pieno cammino, l’abbagliamento, il mutismo. Per Saulo, tuttavia, echeggia la “voce” di un altro: si instaura un dialogo che comincia con la domanda del “chi” e non del “che cosa”, (“Chi sei?” domanda, e poi: “Che cosa devo fare?”). P
er Rousseau, tra lo stordimento e le lacrime, non c’è che il che cosa, le «idee vive», la visione sotto l’albero. Il passeggiatore resta solitario anche se oramai ha il compito di pubblicare qualche bagliore di quell’immensa chiarezza.
Infine, e soprattutto, è il senso stesso dell’esperienza che è totalmente capovolto: mentre Saulo ha la rivelazione che era lui stesso il persecutore quando credeva di essere lo strumento della giustizia divina, Rousseau scopre che l’uomo è naturalmente buono (compreso lui stesso) e che sono le istituzioni che lo corrompono. E noi, su quale via siamo? L’epoca è tale che, ora più che mai, potremmo dare tutta la colpa a qualcun altro («è colpa di Rousseau», canta Gavroche ne I miserabili), o per lo meno alle “istituzioni”, all’“apparato”, alla grande “macchina” che ormai funziona in piena autonomia.
Io stesso, ritornando continuamente su ciò che papa Francesco chiama il «paradigma tecnoeconomico », medito spesso su tali «strutture di peccato» e questo può far pensare che tutto il male viene dal “sistema” così che il mio lettore ed io stesso possiamo assumere la posa di vittime innocenti.
Ora, non bisogna sforzarsi molto per accorgersi che il suddetto “sistema” si nutre della sua denuncia nella misura in cui tale denuncia si muove sul terreno dell’impersonale. Non solo essa ci fa evitare le nostre responsabilità, ma rinnova l’alienazione contemporanea e cioè, come dice Marx, «il rovesciamento del soggetto in oggetto e viceversa». La società dello spettacolo fa spettacolo della propria critica. La ribellione è il suo prodotto di punta. La sovversione è sovvenzionata. «Io sono Nuit Debout » per poi andare a dormire di giorno.
Certo, distruggo le vetrine del Grande Capitale, senza accorgermi che la distruzione è essenzialmente affare del Grande Capitale che è lo specialista dell’obsolescenza, della polizza cristalli, della nuova vetrina che rinasce dai suoi cocci fino a farsi virtuale. Distruggere una macchina non basta a farmi acquisire un savoir-faire. E vedere la pagliuzza nell’occhio del Big Brother non toglie lo schermo che è nel mio.
Allora gli uni parlano di “riprendere il potere”, come se il potere finalmente caduto tra le nostre bianche mani bastasse a salvare il mondo; mentre gli altri, meno ingenui, se ne lavano le mani e vanno a vivere da eremiti, votando il mondo alla collera degli dei. Ciò che fece Rousseau. Scrive il Contratto Sociale e poi si ritira all’Isola di San Pietro, confessando «il suo amore naturale della solitudine»: «Mi trovo meglio con gli esseri chimerici che riunisco intorno a me che con quelli che vedo nel mondo».
Là, con il suo cane, tra «l’oro delle ginestre e il porpora delle brughiere», egli eleva «[le sue] idee a tutti gli esseri della natura, al sistema universale delle cose, all’essere incomprensibile che abbraccia tutto». Ma così facendo gli sfugge la vera trascendenza del Creatore - quella della sua misericordia, della sua alleanza con le persone, al di là del “sistema delle cose”. Per aprirsi a questa trascendenza bisogna accettare di essere destituiti dalla posizione di giudice e riconoscere la propria miseria, ammettere che io sono complice del male fin dall’origine e cambiare il mondo cominciando da me stesso, a partire da una grazia che sola può preservarmi delle utopie devastatrici, perché mi fa accogliere la vita semplice, la vita ordinaria, la vita drammatica, come un dono che non ho meritato.



